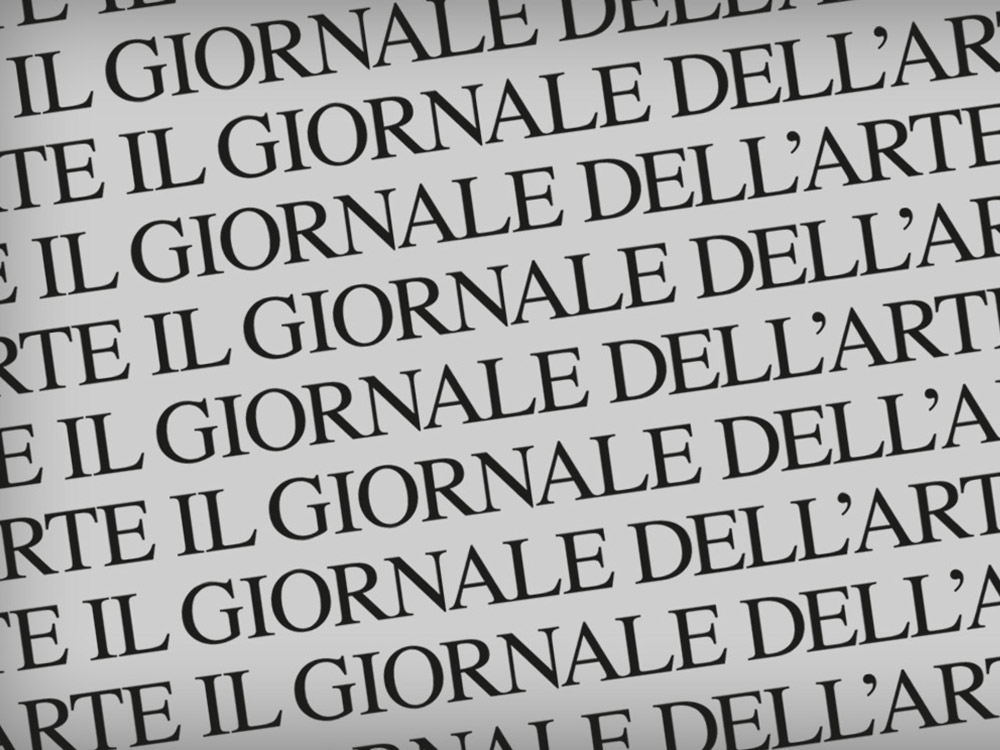Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Micaela Deiana
Leggi i suoi articoli
La decisione del direttore Adam Szymczyk di sdoppiare la 14ma edizione di Documenta nelle sedi di Atene e Kassel è della fine del 2012 e la preparazione ha coinciso con gli anni del braccio di ferro fra Eurogruppo e Governo greco. Lo statement curatoriale si è intrecciato così tanto con l’attualità geoeconomica della politica europea, che il pubblico è arrivato all’inaugurazione con un’elettrica curiosità, alimentata anche dal silenzio totale della comunicazione ufficiale durato fino alla conferenza stampa. Quest’ultima si è aperta con una radicalità all’altezza delle aspettative. I giornalisti sono stati accolti da una performance dei lavoratori di Documenta (il direttore, i curatori, gli artisti, gli operatori) interpreti di «Epicycle» del compositore greco Jani Christou, legata al concetto di «continuum», alla capacità di generarsi e rigenerarsi.
Si sono presentati come gruppo di lavoro, come sperimentatori uniti in una visione metodologica di rottura e, insieme, di rivendicazione di una forza creativa condivisa, processuale e dinamica, capace di creare un «Parlamento dei corpi» che si nutre della conoscenza endogena, greca. Da qui il motto «Impariamo da Atene». Dichiara Szymczyk: «C’è un grande insegnamento: non esiste una sola lezione, una sola scuola. Dobbiamo diventare soggetti politici, abbandonare preconcetti, immergerci nel non sapere». Dalla docta ignorantia di Socrate alla filosofia peripatetica di Aristotele, Documenta invita i visitatori all’esplorazione di Atene in un progetto che si sviluppa sino al 16 luglio in 47 sedi. Quattro principali (l’Athens Conservatoire-Odeion, il Benaki Museum, l’Asfa-Athens School of Fine Arts e l’Emst, il Museo Nazionale d’Arte Contemporanea) e una serie di installazioni fra istituzioni (come quelle di Daniel Knorr al Museo Archeologico Nazionale o di Mounira Al Solh al Museo di Arte Islamica), spazio pubblico (Sanja Iveković in piazza Advi) e sfiziose mete alternative (come l’opera di Pope.L nei bagni del fumoso Galaxy Bar).
Il registro spettacolare è pressoché bandito, la selezione dei nomi accoglie in larga parte artisti poco noti (fra gli italiani solo la scomparsa Maria Lai, presente anche alla Biennale di Venezia, oltre a Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi). I lavori toccano le idiosincrasie della nostra contemporaneità: gli effetti del neoliberismo sul vivere sociale, il fenomeno migratorio e il personale che si fa politico, l’identità democratica europea che rischia di sfaldarsi. Sia come medium sia come metafora, è forte la presenza del suono e della musica, nella sua visualizzazione attraverso il linguaggio pittorico, nella spazializzazione attraverso il momento performativo, nel farsi metafora dell’atto politico. Emblematica in questo senso è l’installazione «Exit» di Guillermo Galindo, un’orchestra di strumenti musicali (funzionanti) realizzati con i detriti di un campo rifugiati nei pressi di Kassel.
Il rigore delle dichiarazioni perde forza nel percorso espositivo. L’architettura delle sedi irrigidisce l’allestimento, che spesso risulta compresso e privo di direttrici prospettiche. Allo sfrangiamento delle relazioni fra le opere in mostra si aggiunge la complessità del rapporto con la città. Inutile negare che è serpeggiata l’accusa di sottile «postcolonialismo» culturale. Ma come avvicinare un pubblico allargato, come essere inclusivi se di fatto la comunicazione continua a essere respingente, le sedi sparse per la città sono difficili da trovare, le opere non sono accompagnate da nessun sussidio esplicativo? Mancano la data di nascita (e morte, visto che il numero degli artisti viventi e non praticamente si equivale) dell’artista, il contesto di provenienza, qualche informazione aggiuntiva sui lavori, indispensabile quando ci troviamo di fronte a opere documentative che poco operano sul piano estetico, di cui è quasi impossibile apprezzare il valore senza conoscerne il contesto di sviluppo.
Sono domande urgenti vista la cornice politica che documenta 14 si è data. Come dichiara Paul B. Preciado, curatore del public program, «la questione dei migranti, la Brexit, Trump, i neonazionalismi europei: è chiaro che dobbiamo muoverci collettivamente ORA, non sappiamo che cosa succederà nei prossimi anni, potrebbe non essere più possibile farlo». Ma è stata valorizzata adeguatamente questa occasione? O, per citare le scritte di protesta di «Crapumenta» apparse sui muri nei giorni dell’opening, è solo l’ennesimo incontro fra «narcisisti di tutto il mondo»? Si continuerà a dibatterne a Kassel, dove la parte tedesca della quinquennale rassegna si aprirà dal 10 giugno al 17 settembre.