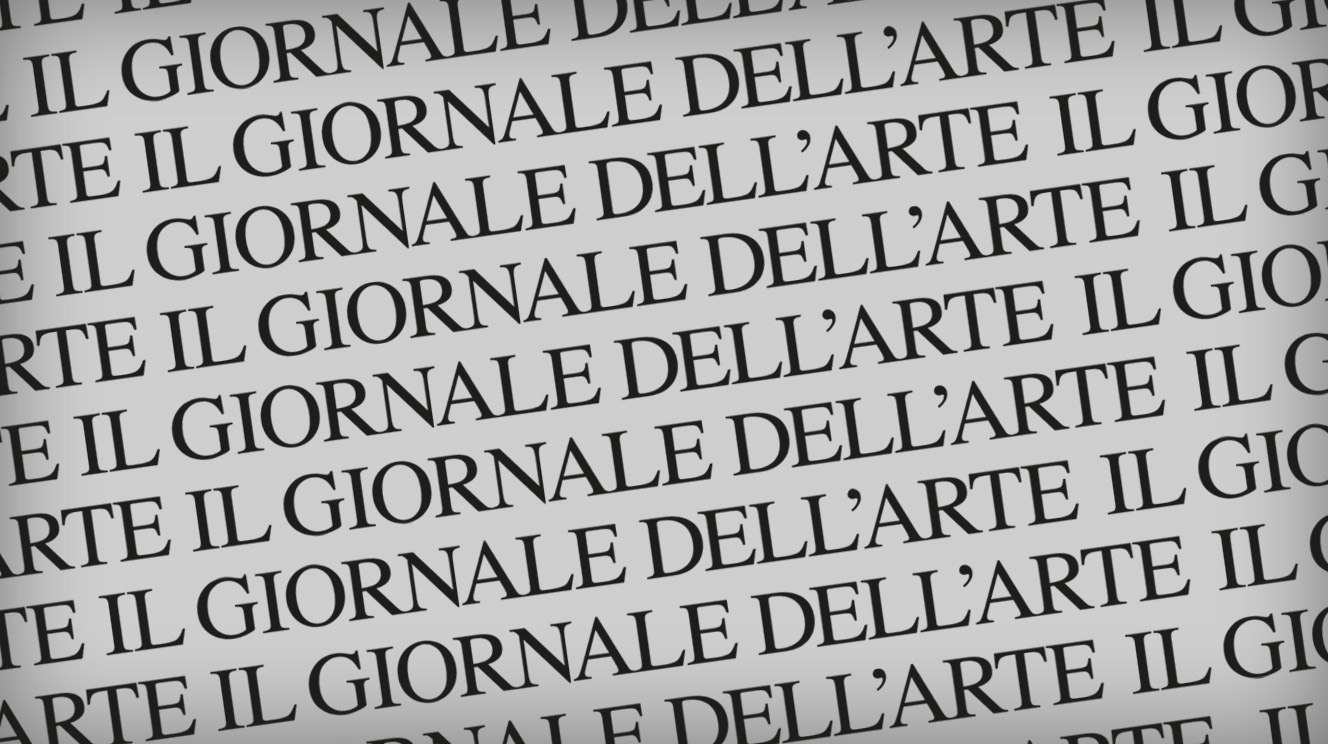Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Laura Lombardi
Leggi i suoi articoliFirenze. L’idea di Fabrizio Moretti di riunire al tavolo della Biennale dell’Antiquariato il legislatore della riforma dei Beni culturali Lorenzo Casini, il sindaco di Firenze Dario Nardella e lo storico dell'arte Tomaso Montanari è stata più che encomiabile, e infatti a Palazzo Corsini il 30 settembre scorso la folla era tanta. Oggetto della discussione doveva essere lo snellimento nella procedura della libera circolazione delle opere d’arte, il fatto che i tempi non possano essere così lunghi e che ci debbano essere regole fisse, criteri omogenei, riguardo la valutazione del pregio artistico, del valore storico, dell’importanza ai fini di studio, per decidere che cosa può uscire dal Paese e cosa no; e soprattutto un impegno dello Stato, nel caso delle opere notificate, all’acquisto entro certi limiti di tempo.
Insomma adottare il «modello francese», o inglese, propone appunto Moretti.
Lorenzo Casini, sulla cui riforma dei Beni culturali qualcuno ha avanzato perplessità, esprime la sua visione con l’equilibrio necessario a un uomo da governo; giurista, sintetico e chiaro, riconosce i problemi ma non si sbilancia.
La parola passa poi a Dario Nardella il quale sposta l’argomento cardine dalla libera circolazione e dal ruolo che gli enti locali possono giocare in quell’ambito al fatto che la res publica debba essere governata da chi è eletto dal popolo, quindi dagli enti locali, e non da chi è preposto alla tutela per formazione e ruolo tecnico. (O non s’era partiti dal modello francese? Dove lo Stato è così presente tanto che si possono fermare solo le opere giudicate da una commissione di esperti «trésor national»? E dove i cataloghi delle mostre dei musei statali hanno un unico editore: la Réunion des musées nationaux?).
Il patrimonio dei beni culturali italiani, prosegue Nardella, è patrimonio dell’umanità quindi, in sintesi, perché le opere devono stare per forza sul nostro suolo nazionale? Possono anche andare altrove, tanto fanno risplendere l’Italia, prefigurando uno scenario inquietante nel quale anche le opere dei musei potrebbero esser rese libere, e la loro circolazione decisa in nome, come replicherà poi Montanari, del consenso politico, del profitto economico più che della tutela… Uno scenario che non era certo quello da cui era partita la discussione di Moretti.
Tocca poi a Montanari il quale, pacatissimo, dopo aver a lungo contemplato l'enorme lampadario del salone Corsini che lentamente girava sopra le nostre teste, fa presente, tra le altre cose, che tutto potrebbe essere snellito potenziando le soprintendenze, invece di frammentarle, incrementando la presenza di giovani, perché lo Stato, osserva, fa tanti sprechi mentre potrebbe trovare più soldi per assumere nuove leve e far funzionare una struttura di tutela in sé virtuosa (ma si mostra ad esempio favorevole all’ArtBonus per la defiscalizzazione e al pagamento delle tasse attraverso le opere d’arte).
Nardella, con piglio non certo consono allo schieramento politico da cui proviene, riprende la parola a lungo, per poi lasciarsi andare a una frase che forse a lui pare inoffensiva, una boutade, ma che di fatto risulta pesante e anche provocatoria, visto che di fronte a lui siedono molti direttori e tra poco ex direttori di musei: «Fa più la cultura un giovane e bravo gallerista che non uno svogliato direttore di museo».
Il gallerista in questione era certo Moretti, grazie ai cui contatti, e soprattutto ai cui fondi, è stato possibile realizzare a costo zero per il Comune la mostra di Jeff Koons a Palazzo Vecchio.
Ora, sulla preparazione, la passione e la serietà di Moretti nessuno discute ed è sacrosanto che il mercato antiquario per le opere d’arte del nostro patrimonio ha fatto moltissimo, spesso con poco riconoscimento da parte delle istituzioni. Ma a parte tutto questo… Può un politico, un sindaco di una città come Firenze, successore di La Pira, dare dello svogliato a qualcuno che come lui rappresenta un’istituzione pubblica pagata con le tasse dei cittadini? In fondo non si deve dimenticare, per voce comune in tutto il mondo, che la formazione degli storici dell’arte nel nostro Paese è un’eccellenza riconosciuta in ambito internazionale (al pari della moda, per fare un paragone oggi in voga) e se vi sono delle letargie nelle soprintendenze queste sono forse dovute alla farraginosità legislativa e alla mancanza di rinnovamento del personale.
Resta il fatto che la competenza su cosa debba circolare o meno non può che essere affidata ai soli tecnici, a coloro che hanno una formazione specifica esattamente, come si fa per i medici o per gli ingegneri, nei rispettivi campi.
D’altronde, il pregiudizio riguardo alle soprintendenze, era già stato dimostrato dalla dichiarazione qualche anno fa di Giuliano da Empoli, assessore alla cultura dell’allora sindaco Matteo Renzi, che definì «polverosi» musei come quello diretto da Franca Falletti, ovvero la Galleria dell’Accademia, beccando uno dei pochi musei d’arte antica a Firenze che, nelle sale del David e dei fondi oro, aveva portato Bill Viola, Robert Mapplethorpe, Philip Glass, Georg Baselitz, Thomas Struth, Jannis Kounellis e fatto mostre come «Arte torna arte», con tanti artisti contemporanei, per cui opere di Antonio Catelani o di Massimo Bartolini stavano tranquillamente vicino al David. Ma in quel museo, evidentemente, lui non era entrato molto spesso.
La via per risolvere l’annoso problema della libera circolazione delle opere d’arte, che penalizza ingiustamente gli antiquari italiani, rispetto agli altri Paesi europei, non passa certo da qui.
Altri articoli dell'autore
Nel bicentenario della nascita, i suoi dipinti sono messi a confronto con quelli di altri protagonisti della pittura del Risorgimento, da Giovanni Fattori a Silvestro Lega e Telemaco Signorini
È stata inaugurata la mostra «Icone di potere e bellezza» con le tre teste in bronzo dorato del Museo di Santa Giulia a Brescia, secondo capitolo dello scambio di manufatti tra le due istituzioni gestito da Fondazione Brescia Musei
La Sala delle Nicchie ospita la prima di una serie di mostre-allestimento con capolavori di mobilio che testimoniano le diverse dinastie che si sono alternate nel palazzo fiorentino
Da Cecchini a Spoerri, Isgrò, Tremlett e molti altri, edizioni e cataloghi di precedenti mostre sono offerti tra i 100 e i 600 euro