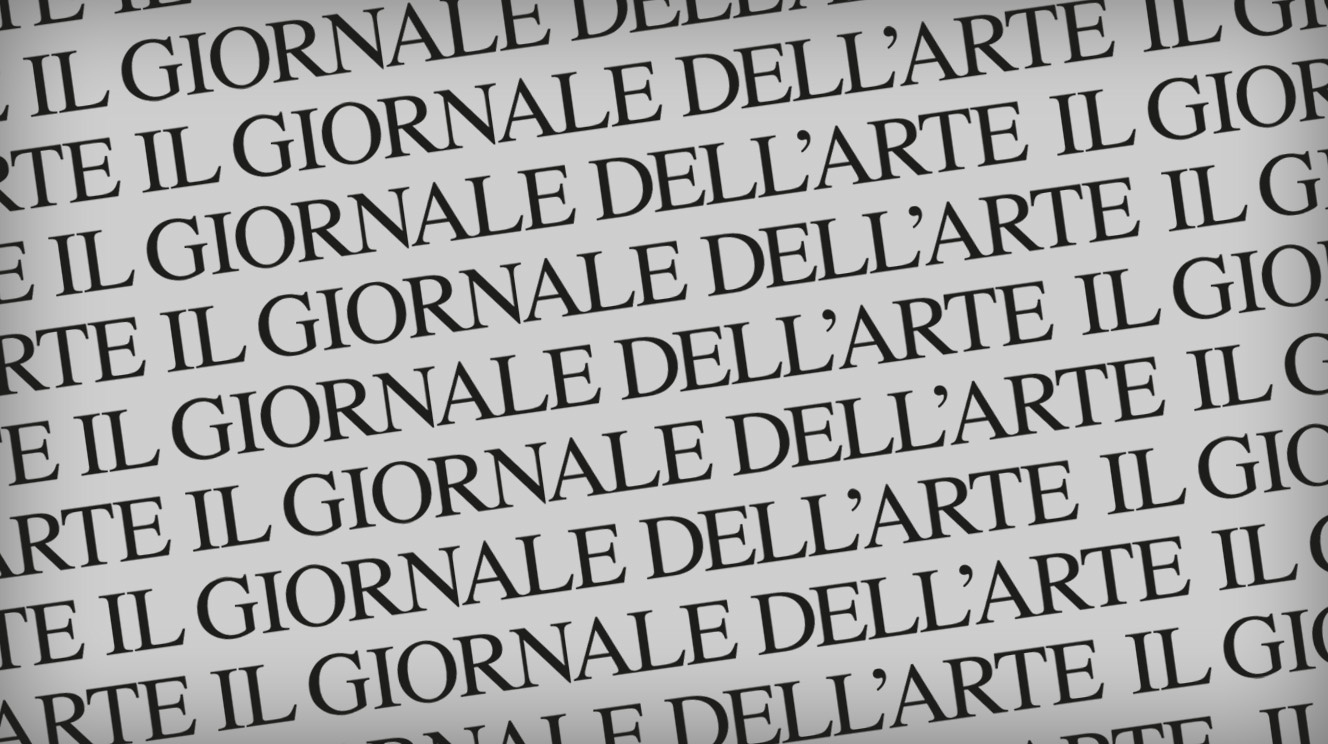Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Laura Lombardi
Leggi i suoi articoliFrederick Stibbert amava collezionare cassoni istoriati, dal Tardogotico al pieno Rinascimento, ma quando non erano in buono stato di conservazione, li smontava e ricomponeva secondo una consuetudine diffusa all’epoca di Viollet le Duc. Gli oggetti così ottenuti furono poi accantonati nei depositi del museo finché l’attuale direttore, Enrico Colle, è riuscito a ottenere da importanti antiquari italiani e stranieri fondi per il loro restauro.
In concomitanza con la Biennale di Palazzo Corsini sì è così inaugurata la mostra curata da Andrea De Marchi e Lorenzo Sbaraglio «Le opere e i giorni. Exempla virtutis, favole antiche e vita quotidiana nel racconto dei a rinascimentali» (fino al 6 gennaio).
L’iniziativa è in linea col rinnovato gusto per il cassone istoriato diffuso in ambito internazionale da una ventina d’anni, ma vuole anche riportare l’attenzione sull’aspetto attributivo e formale, non solo su quello della storia sociale come finora è stato.
I cassoni sono qui proposti come capitolo della storia figurativa nel quale si misurano artisti quali Apollonio di Giovanni, Biagio di Antonio, Jacopo del Sellajo o lo Scheggia, il fratello di Masaccio che dopo la morte di questi fu accolto da Brunelleschi e si specializzò lavorando a contatto coi legnaioli del cantiere della Fabbrica del Duomo.
Nella sala della Cavalcata troneggiano i due grandi mobili a stallo fatti costruire nel 1871 ricomponendo scampoli di sette cassoni in pastiglia originali del Quattrocento, fiorentini, umbri e senesi in un babelico mix di grande interesse per la storia del gusto.
Quando il cassone era in cattivo stato Stibbert agiva con molta libertà, come nel caso del cassone quattrocentesco segato, dorato, ridipinto e addirittura firmato su tre lati, ma che risulta essere in coppia con quello in buono stato conservato al Bargello.
Nel caso il cassone fosse invece in buono stato, Stibbert non vi metteva mano: l’appena riscoperto e assai pregiato cassone con scena di battaglia di fattura perugina del 1440 conserva anche l’originale foderatura in lino col monogramma.
L’opera è in attesa di restauro e la sua esposizione in mostra è finalizzata a un fundraising che riguarda anche le tre scene di Eros e Anteros dipinte da Francesco di Giorgio Martini.
Altri articoli dell'autore
Nel bicentenario della nascita, i suoi dipinti sono messi a confronto con quelli di altri protagonisti della pittura del Risorgimento, da Giovanni Fattori a Silvestro Lega e Telemaco Signorini
È stata inaugurata la mostra «Icone di potere e bellezza» con le tre teste in bronzo dorato del Museo di Santa Giulia a Brescia, secondo capitolo dello scambio di manufatti tra le due istituzioni gestito da Fondazione Brescia Musei
La Sala delle Nicchie ospita la prima di una serie di mostre-allestimento con capolavori di mobilio che testimoniano le diverse dinastie che si sono alternate nel palazzo fiorentino
Da Cecchini a Spoerri, Isgrò, Tremlett e molti altri, edizioni e cataloghi di precedenti mostre sono offerti tra i 100 e i 600 euro