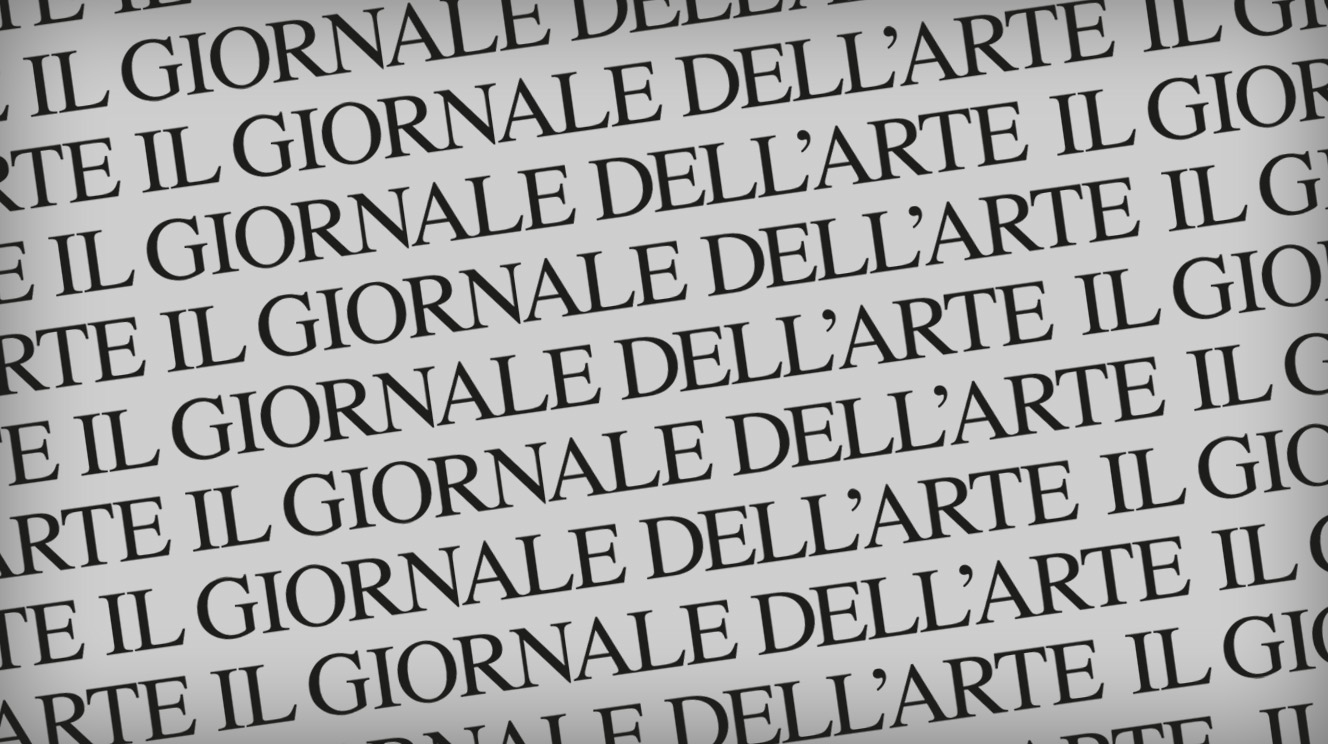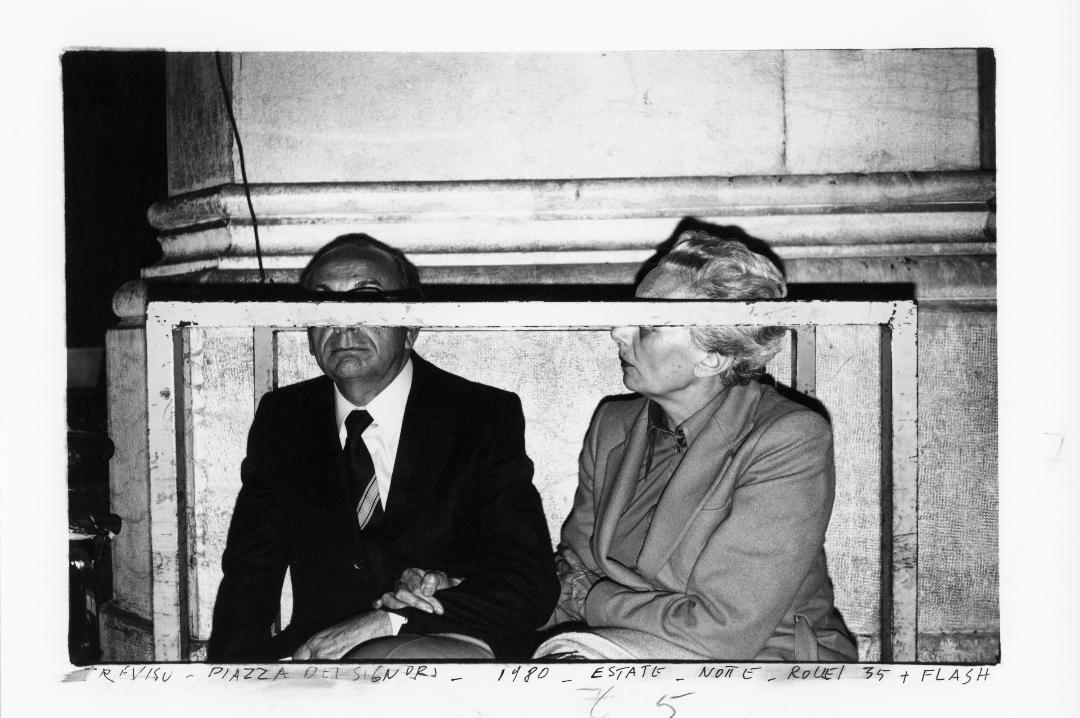Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Milano. Il 5 aprile si è tenuta una giornata di studi dedicata a «Committenza e artisti nella Milano del Cinquecento per San Maurizio al Monastero Maggiore: ipotesi, problemi critici e confronti» promossa dalla Banca Popolare di Milano, cui si devono anche i finanziamenti per il recente restauro degli affreschi dell'aula e del matroneo della chiesa claustrale di San Maurizio al Monastero Maggiore. Il convegno, al quale hanno preso parte Sandrina Bandera, Maria Teresa Binaghi Olivari, Maria Teresa Fiorio, Vincenzo Gheroldi, Luisa Giordano, Valerio Guazzoni, Pietro C. Marani, Mauro Natale, Sergio Rebora, Giovan Battista Sannazzaro, Gianni Carlo Sciolla, Dario Trento, Bruno Zanardi, Paola Zanolini e Gabriella Zarri sotto la presidenza di Carlo Bertelli, ha potuto fare il punto sull'argomento grazie all'ormai prossima conclusione dell'annoso restauro che ha interessato la chiesa, una delle più insigni di Milano per storia e importanza, ma anche uno dei gioielli dell'architettura e, più ancora, della pittura cinquecentesca.
La decorazione di San Maurizio al Monastero Maggiore (preziosa, per conoscerne le vicende, la limpida introduzione di Maria Teresa Fiorio al volume Bernardino Luini e la pittura del Rinascimento a Milano. Gli affreschi di San Maurizio al Monastero Maggiore, Skira-Banca Popolare di Milano, 2000) si presenta infatti come una sorta di palinsesto della pittura lombarda dell' intero Cinquecento (cfr. anche box qui a fianco): un palinsesto che grazie ai risultati del restauro avviato nel 1984 da Paola Zanolini sotto la direzione di Sandrina Bandera e agli esiti delle ricerche d'archivio, oggi possiamo leggere più chiaramente. Le pitture erano infatti fortemente danneggiate dalle efflorescenze biancastre causate da un'intensa umidità di risalita dovuta al passaggio del contiguo fiume Nirone, interrato, e al contempo soffrivano per un forte annerimento dei colori, causato dall'albumina stesa a piene mani dai restauratori dell'Ottocento per consolidare i colori ed esaltarne la cromia. Queste sostanze organiche avevano infatti subito un'ossidazione e una polimerizzazione che hanno scurito le pitture fino a snaturarle; e il problema è stato tanto più vistoso sui volti delle figure di Bernardino Luini, che nell'Ottocento, per il suo raffaellismo, era particolarmente amato. Va ricordato poi che il Luini lavorava a mezzo fresco, come allora usava nelle botteghe lombarde: affidava la prima stesura a fresco agli allievi, poi interveniva quando l'intonaco era ancora umido per impostare la figura, usando anche un poco di colla animale. Alla fine venivano sovrapposte le decorazioni (delle vesti, dei gioielli...), quasi del tutto perdute, applicandole a secco con leganti animali; i volti invece erano eseguiti a fresco, da lui, e in giornate ben riconoscibili. Data la tecnica complessa, le analisi sono state necessariamente sofisticate, e molto lunghi i tempi di lavorazione, per salvare dapprima gli ori superstiti; poi per agire con impacchi successivi (talvolta a distanza di mesi) e di diversa natura sui diversi pigmenti. Il risultato è però più che soddisfacente (dato il carattere decorativo ed omogeneo dell'impianto, si è proceduto a integrazioni pittoriche, sia pure lievi, per restituire la completezza all'insieme): quasi ritrovata la luminosità originaria, a dispetto dell'abrasione diffusa dovuta ai numerosi interventi di pulitura passati (almeno sei, dalla fine del Settecento) e consolidati gli intonaci, si è anche potuto verificare che i paesaggi dell'aula delle monache, sinora considerati fra i primi «paesaggi puri» della nostra storia dell'arte, risalgono invece alla fine dell'Ottocento o, forse, addirittura al primo Novecento: sotto, sono state infatti ritrovate le decorazioni a schema geometrico, molto danneggiate, che risalivano alla decorazione originaria della chiesa.
Altri articoli dell'autore
Dal 30 aprile nel comune di Bellano trova casa, grazie alla donazione della famiglia, l’intero corpus grafico e un centinaio di dipinti dell’artista scoperto nel 1983 da Giovanni Testori
Per molti anni ripudiate dai critici e dagli stessi designer («escluse le “tre M” Mari, Munari e Mendini), le affinità elettive tra design e arte sono indagate dall’istituzione milanese
10 Corso Como dedica al maestro romagnolo una mostra incentrata sulla realtà più labile che esista, selezionando scatti in cui si aprono riflessioni sugli statuti della fotografia e sull’atto stesso del fotografare
Con un convegno in programma il 22 e 23 maggio sarà presentato il restauro degli affreschi realizzati nella Chiesa di San Salvatore nel 1375 dal Maestro di Lentate