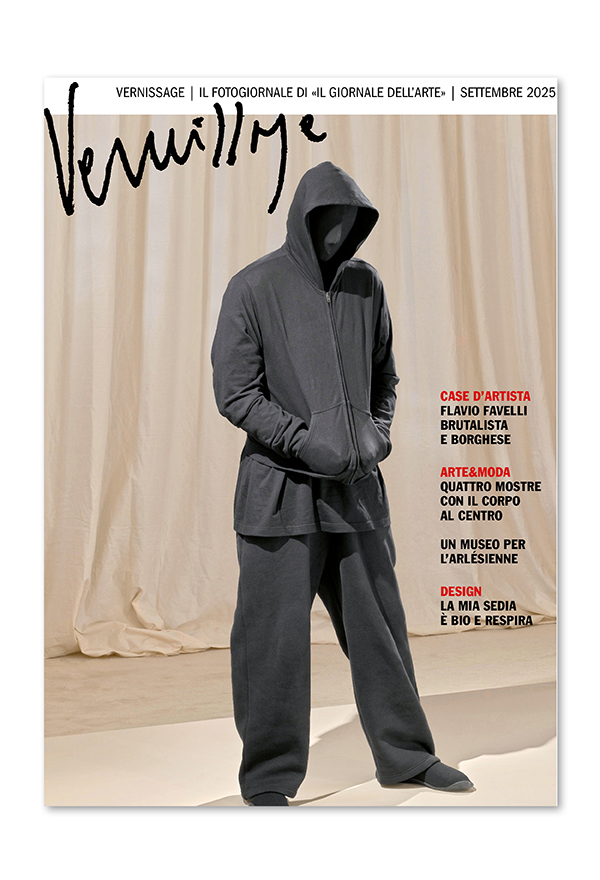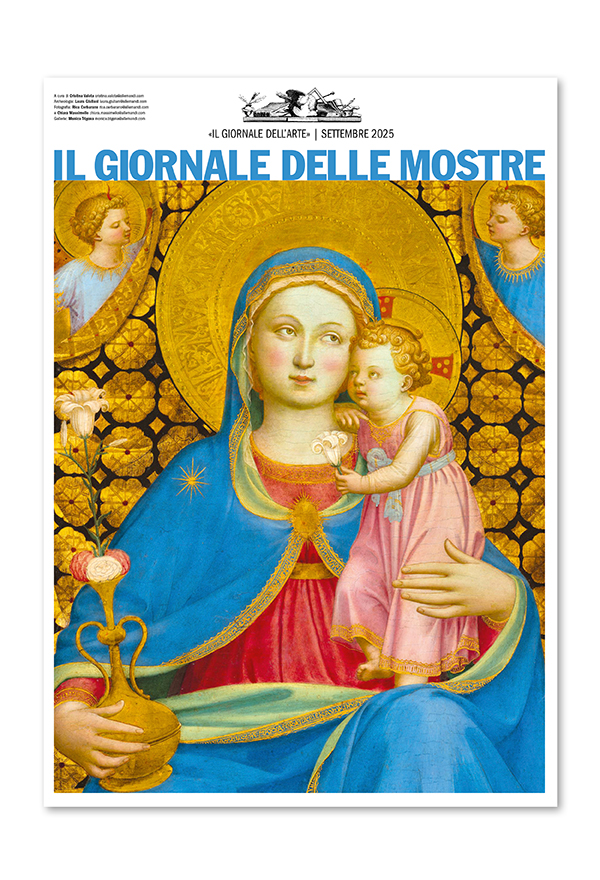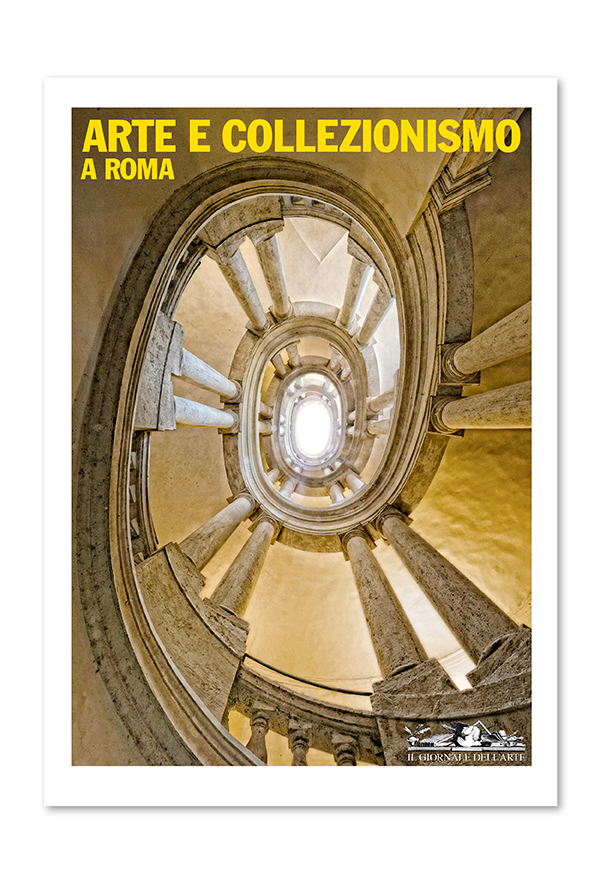Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Valerio Veneruso
Leggi i suoi articoliPer il mondo della fotografia, o meglio della cultura in generale, il 2025 è iniziato con una perdita importante, quella di Oliviero Toscani (Milano, 1942-Cecina, 2025). Entrato nell’immaginario collettivo grazie soprattutto alle sue discusse campagne pubblicitarie per Benetton, Toscani è stato molto più di un semplice fotografo: un vero e proprio maestro della comunicazione visiva che, attraverso uno sguardo attento e lungimirante, ne ha saputo ridefinire i parametri. Una visione fuori dagli schemi, la sua, ben racchiusa in esperienze come il coraggioso magazine di culto «Colors», fondato nel 1991 insieme a Tibor Kalman, e il centro internazionale di ricerca per le arti Fabrica, attivo a Catena di Villorba dal 1994.
Guardando al suo lascito creativo oggi, cioè con gli occhi smaliziati del nostro tempo, l’estrema contemporaneità dei suoi scatti ci risulta ancora più chiara. Questo avviene non tanto per l’attualità dei loro messaggi, quanto per l’intrinseca struttura memetica che ne ha sempre determinato il forte impatto visivo e culturale. Complice quella peculiare ironia dissacrante, espressa tramite un’estetica essenziale, diretta e didascalica, il linguaggio utilizzato da Toscani non è in fin dei conti così distante da quello altrettanto basilare ed esplicito dei meme.
Ovviamente non è né a lui né ad altri autori affini che si può o che si vuole attribuire la paternità di un fenomeno del genere; ciononostante non si può fare a meno di constatare quanto un modello compositivo formato da sovrapposizioni di testi concisi su immagini emblematiche coincida con quello della maggior parte delle cornici memetiche che vediamo continuamente su web e social media da una ventina di anni a questa parte. Se poi si considera l’estrema popolarità che le immagini di Toscani hanno avuto in un’epoca preinternet e presocial riusciamo a carpire ancora di più la loro innata viralità.
Oltre a questo, le analogie tra il modus operandi di Toscani e quello di un ipotetico memer/content creator si possono ritrovare anche nelle inevitabili finalità commerciali insite in tali espedienti. Non è infatti un caso se i meme oggi vengono utilizzati principalmente nel campo della pubblicità o per alimentare meccanismi di matrice capitalistica (come rafforzare pagine social e relative community, richiedere iscrizioni e donazioni, promuovere prodotti ecc.). Sebbene per Toscani la pubblicità sia stata utilizzata come mezzo di rottura, il suo lavoro nasce principalmente per la vendita di beni di consumo; e anche il presunto status sovversivo dei meme ha poi svelato un’ormai imprescindibile vicinanza con le dinamiche di mercato.

Oliviero Toscani, «Hearts», 1996
È interessante, a questo punto, ricordare anche la singolare vicenda che, a metà degli anni Novanta, coinvolse un’altra «precorritrice dei meme»: Barbara Kruger (celebrata proprio nel 2024 con una importante retrospettiva alla Serpentine South di Londra). Conosciuta a livello mondiale per la sua personalissima cifra stilistica in grado di unire insieme arte concettuale e graphic design, l’artista statunitense fu al centro di un particolare caso di ispirazione/appropriazione intellettuale da parte del famosissimo brand di skate e streetwear Supreme. Creato nel 1994 dallo stilista e imprenditore James Jebbia, il marchio in questione è rappresentato da un logo che attinge spudoratamente dalla composizione formale delle frasi inserite nelle opere/slogan a firma Kruger. L’efficacia visiva di quelle parole bianche scritte con font Futura Bold Oblique dentro rettangoli rossi si è così diffusa, come un vero e proprio virus, influenzando sia un ambito come quello della moda, sia lo stesso immaginario collettivo. Memetico, in questo caso, non è soltanto il lessico visivo insito nei lavori di Barbara Kruger ma tutto ciò che da esso è poi scaturito.
Divenuto oramai parte integrante del nostro quotidiano, il linguaggio memetico si è per sua stessa natura replicato in maniera imprevedibile nel corso del tempo: una caratteristica inscritta già nello stesso termine «meme», coniato nel 1976 dal biologo britannico Richard Dawkins per descrivere il processo di imitazione e mutazione con cui vengono diffuse le informazioni culturali. Al giorno d’oggi ogni cosa è memabile, soggetta cioè a rivisitazioni di qualunque tipo (non solo in termini visivi) e a condivisioni continue tramite social media, podcast, programmi televisivi, abitudini sociali, e quant’altro. In particolar modo se si pensa all’apporto di software text to image basati sulle Intelligenze Artificiali. Dagli accadimenti politici, alle scoperte tecnologiche, passando per la storia dell’arte e le notizie di cronaca, ogni avvenimento è soggetto a un processo di memeficazione che non risparmia niente e nessuno. Su questo indaga, per esempio, la rivista trimestrale «Iconografie» che, con uno sguardo in qualche modo debitore del sopracitato Colors, analizza il potere della divulgazione delle immagini nell’epoca contemporanea. Ideato dal giornalista freelance Mattia Salvia (classe 1990), il progetto editoriale mira a offrire una mappatura puntuale dei cambiamenti sociopolitici propri dello Zeitgeist nel quale ci muoviamo.
Tracciare una mappatura dei cambiamenti del nostro tempo attraverso lo sviluppo delle immagini è anche al centro di «The Great Wall of Memes»: un progetto che Valentina Tanni, curatrice e storica dell’arte (nonché autrice del saggio Memestetica. Il settembre eterno dell’arte) porta avanti dal 2013. Recentemente allestita al museo MAMbo di Bologna, in occasione della mostra «Facile ironia. L’ironia nell’arte italiana tra XX e XXI secolo», l’installazione si avvale di un muro vero e proprio per tessere le fila di un’evoluzione memetica che, ispirandosi agli insegnamenti di Aby Warburg, collide inevitabilmente anche con la storia dell’arte.
Nel tentativo di rimanere lucidi nel mezzo di un bombardamento visivo sempre più difficile da gestire, non ci resta allora che tenere gli occhi ben puntati verso i luminari del passato per ritrovare, nella storia della fotografia e della comunicazione visiva, i geni dei cambiamenti futuri.

Barbara Kruger, «I shop therefore I am», 1987
Altri articoli dell'autore
Il meglio della nuova edizione del festival fotografico torinese targato Paratissima, in scena a Torino fino all'11 maggio
Sorveglianza di massa, diritti digitali, tracciamenti facciali: il lato oscuro delle IA è al centro della mostra «When they see us» alla Biblioteca Salaborsa di Bologna