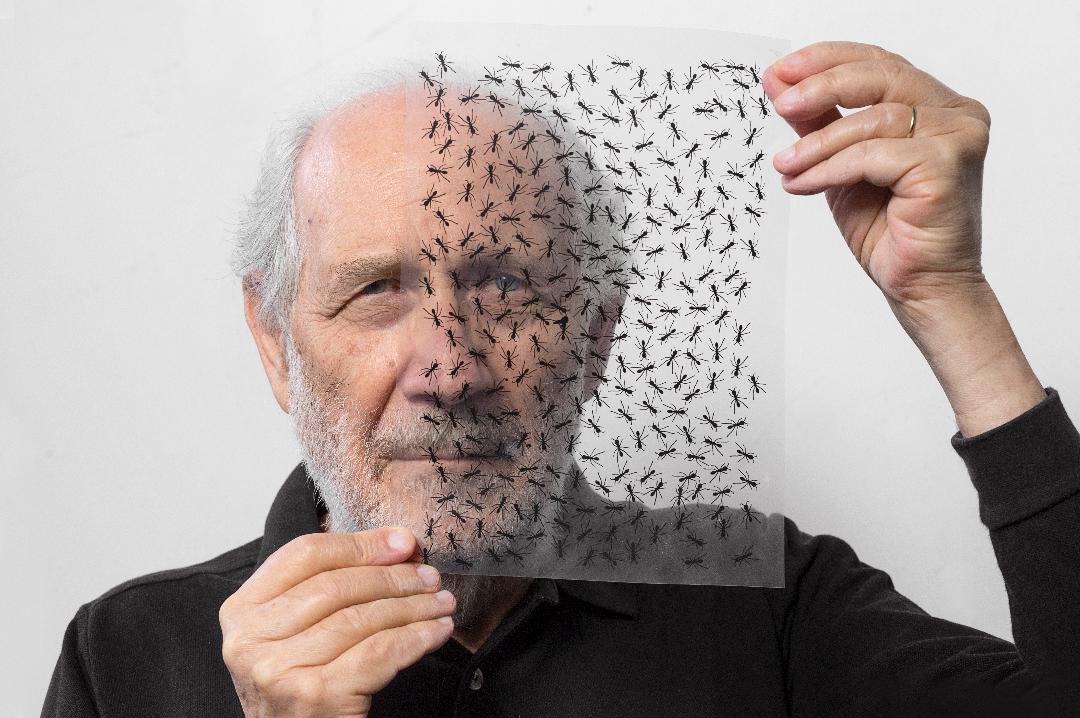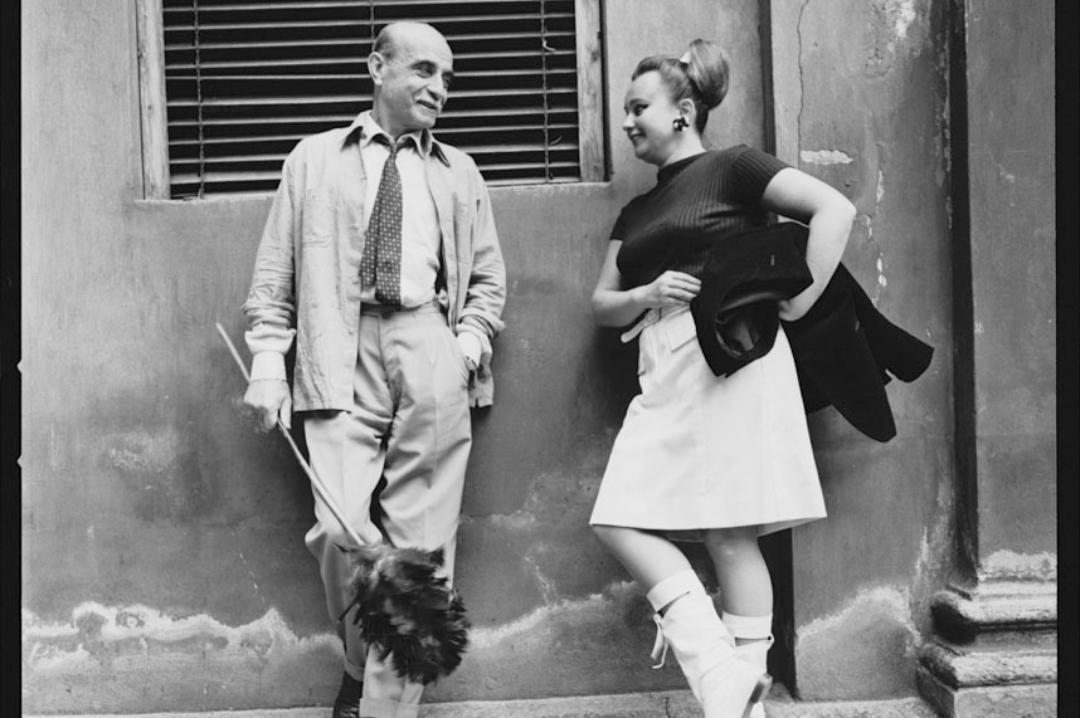Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Matteo Mottin
Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI
A Bosco Marengo, un piccolo paese a sud est di Alessandria, nella pianura compresa tra il torrente Orba e il fiume Bormida, sorge il Complesso di Santa Croce, un convento domenicano con annessa chiesa decorata da Giorgio Vasari, fortemente voluto dal cardinale Michele Ghislieri prima di diventare Papa Pio V. Dopo la soppressione degli enti religiosi, nei primi anni del XIX secolo, il complesso cambiò molte volte uso e destinazione: magazzino, ospedale militare e, per quasi un secolo, dal 1894 fino agli inizi degli anni ’90, riformatorio minorile. La porta d’ingresso di questo luogo di detenzione era un noto spauracchio per i bambini della zona: per decenni i genitori si tramandarono la discutibile ma diffusa usanza di fermare la macchina nel piazzale della chiesa, indicare la porta d’ingresso al riformatorio e inventarsi colorite minacce per strappare ai figli vacue promesse di buona condotta. Varcando quella medesima porta, fino al 5 ottobre, è possibile visitare «Ruins», un progetto delle curatrici Amina Berdin e Tatiana Palenzona, che insieme a Michelangelo Buzzi hanno formato l’associazione MARES con lo scopo di riattivare il luogo attraverso un dialogo con l’arte contemporanea emergente. Tramite una open call hanno selezionato quattro artisti, Jade Blackstock (Birmingham, 1993), Giovanni Chiamenti (Verona, 1992), Luca Pagin (Dolo, 2002) e Teresa Prati (Novi Ligure, 1999), che per tre mesi hanno vissuto e lavorato nel Complesso, esplorando il territorio dell’alessandrino per indagarne le dinamiche economiche, storiche e geografiche. La mostra presenta le opere prodotte durante il periodo di residenza, allestite in maniera organica negli spazi dell’ex convento, dalle celle del riformatorio ai chiostri, passando per il dormitorio e la biblioteca, in un percorso che svela e reinterpreta gli angoli più cupi della sua storia recente, ragiona sul rapporto tra natura e industria del territorio circostante, e si spinge fino a immaginarne una possibile evoluzione in un futuro prossimo.
Sullo scalone principale Teresa Prati ha allestito un’opera sonora: «L’Educazione - Ain’t no fun» (tutte le opere sono del 2025) è un adattamento per coro giovanile di un brano del 1992 del rapper Snoop Dogg: il candore del canto a cappella che si diffonde tra le stanze del convento contrasta con il testo della canzone, di carattere crudo, sessista e misogino, il cui messaggio principale è che «non è divertente» (ain’t no fun) avere una donna se non la si può condividere con gli amici. Quella dell’artista non è una provocazione gratuita: l’opera nasce da approfondite ricerche sulla vita nel riformatorio minorile, in cui l’ambiente coercitivo esclusivamente maschile portava i giovani detenuti ad atti di abuso e nonnismo, il tutto coperto dalla facciata di un luogo sacro.

Complesso Monumentale di Santa Croce, Bosco Marengo, 2024. Foto Lorenzo Morandi
Nell’ambiente del piano superiore in cui gli adolescenti venivano rinchiusi — uno stanzone rettangolare, tinto di azzurro, con su un lato due livelli di celle a grate bianche ortogonali — Giovanni Chiamenti presenta nuove opere ispirate alla possibilità di un futuro mutamento evolutivo che vede l’adattamento di nuovi organismi a un ecosistema saturo di polimeri. Le creature ritratte dall’artista sono speculazioni fantastiche suggerite da un attento studio e da un costante confronto con esperti e scienziati. I grandi dipinti a tecnica mista della serie «Genomic Chimeras» e le sculture in alluminio di «Processed Archetypes» nascono da una ricerca sulla storia geologica della regione, in particolare sulla fauna marina che la abitava in tempi remoti, quando l’odierno Monferrato era coperto dal mare. Visitando le grotte di Bossea l’artista ha appreso che anche questo ambiente, a lungo considerato incontaminato, è stato raggiunto dalle microplastiche, portando i particolari organismi che lo abitano a una convivenza forzata con gli scarti prodotti dall’essere umano. Le figure nelle opere di Chiamenti non sono state immaginate per evasione dalla pressante questione ambientale, ma per ipotizzare su quali nuove strade potrebbe svilupparsi l’inarrestabile corso della vita.
Negli ambienti di quello che fu l’ex dormitorio, Luca Pagin ha creato dei gruppi scultorei elaborando le forme di lavandini e saponiere, gli unici oggetti stranamente rimasti integri durante gli anni di abbandono del Complesso, dopo la chiusura del riformatorio. L’artista li ha ibridati formando strutture basse e simmetriche, oggetti oblunghi che ricordano giacigli, e ne ha ricoperto la superficie di strutto profumato con essenze balsamiche, le stesse coltivate dai monaci nel XVII secolo: l’aspetto diafano e opalescente delle sculture, e l’aroma che emanano, evocano il desiderio di piccole isole di privacy e cura del sé, desiderio sicuramente espresso da chi ha vissuto in quel luogo. Con un gesto scultoreo preciso e delicato, Pagin connette un bisogno del passato con un rimedio proveniente da due secoli prima: un dramma che si svolge su assi temporali non comunicanti.
Il corpo e il suo rapporto con l’ambiente sono i temi centrali della pratica performativa di Jade Blackstock: nei suoi lavori impiega spesso materiali come melassa, indaco e rami d’albero, trattandoli come elementi simbolici per connettere il suo mondo interiore alla realtà esteriore, momenti biografici alla memoria collettiva, tradizioni ancestrali a meccanismi estrattivi. Nel contesto di Ruins, l’artista ha realizzato per la prima volta degli oggetti scultorei: su una lastra di metallo ossidato ha disposto centinaia di capsule di resina, ciascuna contenente una goccia di miele di acacia, pianta non autoctona ma fondamentale per il paesaggio agricolo dell’alessandrino. In un’altra scultura, esposta nel chiostro inferiore, a chiusura del percorso espositivo, Blackstock ha impregnato un lungo drappo di cotone con cera d’api: realizzata quotidianamente durante i tre mesi di lavoro nel Complesso, l’opera è una sorta di diario sull’evoluzione del suo periodo di residenza, scritto con un materiale che richiama l’unione dell’operosità animale, vegetale e umana. Esposta all’imprevedibilità degli elementi, e destinata a un continuo e lento cambiamento, non è difficile considerarla come una metafora, o forse leggervi un saluto, o un augurio.
A novembre 2025 sarà pubblicato il catalogo della mostra, edito da Allemandi, con testi critici a cura di Berdin e Palenzona.

Jade Blackstock, veduta dell’installazione. Foto Lorenzo Morandi
Altri articoli dell'autore
Dalla crisi strutturale ai nuovi pubblici, la conferenza annuale dell’International Committee for Museums and Collections of Modern Art rimane il luogo centrale del dibattito internazionale attraverso il dialogo e lo scambio di idee
Alla Fondazione intitolata all’artista torinese una mostra ben riuscita, che si può leggere come una poesia o analizzare come un saggio, traendone in ambo i casi un profondo e durevole arricchimento
Artista concettuale, pittore, poeta, scrittore, drammaturgo e regista ma soprattutto ideatore della Cancellatura. L’artista dell’anno 2026 de «Il Giornale dell’Arte»
Un monumentale lavoro, durato oltre trent’anni, o re una nuova visione della vita e dell’opera del grande artista