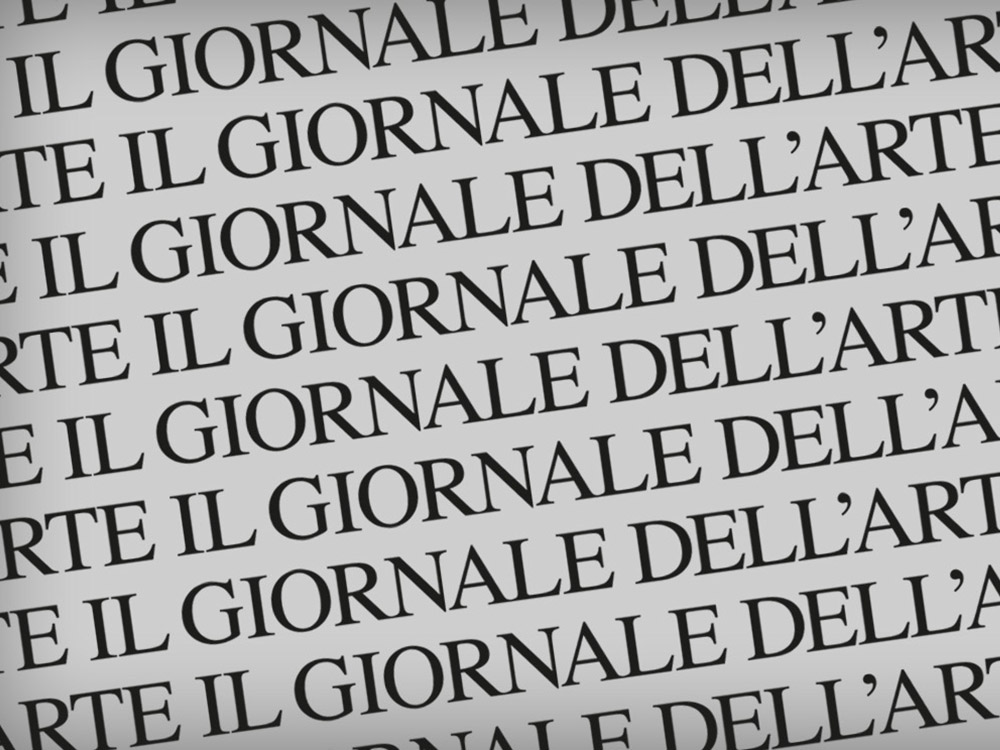Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi
Leggi i suoi articoli<!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 11.0px; font: 8.5px 'Swift Neue LT Pro'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 11.0px; font: 8.5px 'Franklin Gothic Std Condensed'} span.s1 {font: 8.5px 'Franklin Gothic Std Condensed'; font-kerning: none; color: #414141} span.s2 {font-kerning: none} span.s3 {font: 8.5px Helvetica; font-kerning: none} -->
Vetting delle opere sempre più severo, offerta piacevole e varia
Una Biennale folta e ricca di proposte (oltre che sfavillante di eventi e feste lussuose) quella del 2017, sotto la regia di Fabrizio Moretti e nel nuovo allestimento scenografico ma essenziale e arioso di Matteo Corvino. Fin dall’affollatissima preview del 20 settembre nella quale alcune vendite sono giunte a buon fine, la maggior parte degli antiquari esprime pareri molto positivi nei confronti di una manifestazione che può dirsi internazionale non tanto per il numero degli espositori stranieri, comunque in aumento, quanto per il pubblico internazionale nei gusti e nella preparazione.
Qualche parere meno entusiasta c’è (Giovanni Sarti ad esempio), ma senza nessuna accusa alla Biaf quanto al momento di crisi generale che coinvolge analoghe manifestazioni. Quel che soddisfa i galleristi, le cui opere sono passate al duro vaglio di un vetting sempre più severo, è il vedere i propri stand frequentati non da visitatori «a passeggio» ma da esperti pronti a intessere relazioni destinate a esiti futuri: quasi tutti gli espositori infatti non puntano alla vendita immediata bensì confidano su trattative che, pur se lunghe (anche con istituzioni museali italiane e straniere) solo dalla Biennale possono prendere avvio.
Solito riserbo nei confronti delle cifre di vendita e talvolta perfino nei riguardi degli oggetti venduti, molti per scaramanzia che la trattativa pur già molto avanti, possa non andare in porto, oppure, dicono, per riserbo nei confronti degli acquirenti. Soddisfatto Carlo Orsi (Milano) per il premio del miglior dipinto alla sua «Allegoria della Pazienza», l’ovale di Carlo Dolci, premiato ex aequo con «Il carro allegorico del principe Giovanni Battista Borghese» di Johann Paul Schor, esposto da Alessandra Di Castro (Roma); ma anche per la vendita della medaglia di Galileo Galilei e per la presenza di un cartone preparatorio per un arazzo della villa di Cerreto Guidi con la «Veduta del castello di Grottaferrata» dalla collezione Barberini. Soddisfatti anche Francesca Antonacci e Damiano Lapiccirella (Roma), che hanno venduto varie sculture e dipinti fin dalla serata inaugurale tra cui il top lot della galleria, «L’attesa» di Cagnaccio di San Pietro che andrà a una fondazione del Nord Italia, e c’è una trattativa in corso per il fregio di Sartorio. Vendite anche nello stand monografico dedicato ad Arman da Sperone (New York), con opere solo del periodo d’oro dell’artista, tra il 1962 e il 1969 (le richieste andavano dagli 80 ai 220mila euro), come pure da Enrico Frascione (Firenze), dove sono partiti subito «L’incontro nell’atelier» di Luigi Serra, il «Ritratto del cardinale Marcantonio da Mula» di Tintoretto e il Mario Ceroli del 1968 che era suo corrispettivo sulla stessa parete a formare un intrigante gioco di specchi tra forme umane di epoche lontane (e nel mezzo una «Fantasia macabra» di Hermann Hugo Otto Poertzel del 1927).
Buoni risultati anche da Robilant+Voena, stand di notevoli proposte, con valutazioni intorno ai 600-800mila euro, dove sono stati venduti, tra l’altro, i due santi di Jusepe de Ribera. Ha attratto compratori anche lo stand molto chic di Giovanni Pratesi (Firenze) con la splendida ciotola romana del II secolo d.C. con le prese di Valadier e il fregio robbiano, i due obelischi in porfido del Sei-Settecento e il ritratto di Giovan Battista Niccolini scolpito da Lorenzo Bartolini firmato e datato, acquistato dagli Amici della Galleria dell’Accademia di Firenze.
Soddisfazione anche alla Galleria Frediano Farsetti (Firenze), che presentava opere firmate e datate di maestri come Chagall, Klee, Morandi, Savinio, Carla Accardi, Léger per le quali sono in corso varie trattative. Molto interesse anche per lo stand di Mehringer-Benappi (Monaco, Londra, Torino), che conferma la sfida nel proporre opere di una linea molto ricercata, ma di notevolissimo valore, come il «San Giovanni Evangelista» in legno di tiglio di Giovan Angelo Del Maino (primo Cinquecento), che ha infatti vinto il premio per la miglior scultura.
Una menzione speciale è stata assegnata per la qualità delle opere presentate e l’allestimento alla Galleria Copetti (Udine) e alla galleria di Riccardo Bacarelli e di Bruno Botticelli (Firenze), che si sono presentati in duo come a Maastricht, e tra le cui opere molto interesse hanno suscitato la Madonna spoletina del Trecento e la scultura cinquecentesca del Maestro dei bambini turbolenti. «Fabrizio ha battuto se stesso, commenta Bruno Botticelli, È un’impresa non facile allestire una fiera così in un mondo dominato dalle immagini, perché nell’era di Instagram il pubblico ha bisogno di stimoli continui sennò si stanca subito e soprattutto non chiede più all’antiquariato certe sicurezze da tramandare ai figli, il che ha visto ad esempio tramontare il settore degli arredi».
Buone vendite anche nel raffinato stand di Romano Fine Art (Firenze) con disegni dal Cavalier d’Arpino a Mario Sironi, dal Volterrano alla futurista Marisa Mori, da Pinelli a Thayaht e Casorati. Soddisfatti Walter Padovani (Milano) che ha venduto l’«Ercole» di Francesco Righetti, e la galleria Carlo Virgilio (Roma) che, pur specializzata su Otto e Novecento (con il bel marmo di Aristodemo Costoli e il finissimo pastello «Alba sul Lago di Nemi», 1914 di Aristide Sartorio), ha avuto tra le sue vendite un dipinto dell’Empoli.
Anche la galleria Società di Belle Arti (Viareggio-Milano) conferma di aver avuto contatti interessanti con un pubblico anche giovane, esigente, e alla ricerca di oggetti rari e particolari, concludendo vendite di opere macchiaiole per valori intorno ai 150mila euro. Molto discretamente Fabrizio Moretti (Londra, Montecarlo, Firenze) ha preferito lasciare spazio agli stand di nuove gallerie che hanno aderito alla manifestazione, esponendo solo, ai piedi della scalinata, due opere, l’una di proprietà privata, il «San Leonardo» di Neroccio di Bartolomeo Landi (che è poi lo stesso che cinge Moretti nella scultura «cero» di Urs Fischer nell’arengario di Palazzo Vecchio), l’altra notificata: il dittico di Andrea Bonaiuti. Tra i premi assegnati dalla Biaf il «Lorenzo d’Oro» ad Alberto Angela.
Altri articoli dell'autore
Nella sede fiorentina della Galleria Poggiali sono riunite 25 opere dell’artista svizzero che trasforma l’arte optical in un’esperienza sensoriale
L’artista toscana inaugura il «Project Space» di Palazzo Strozzi con un’installazione che, ispirata ai versi di Eliot e con riferimenti a Brueghel, Bacon e Paula Rego, «riflette più sull’assenza umana che sulla sua presenza»
Identità culturale e linguaggio sono i temi dell’artista indiana, la tensione e il limite nel tempo e nello spazio quelli del vicentino. All’Arco dei Becci il colombiano che da ragazzino dipingeva con i numeri
Per il riallestimento del Salone nel Museo del Bargello, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei, sono state coinvolte professionalità interne ed esterne al museo