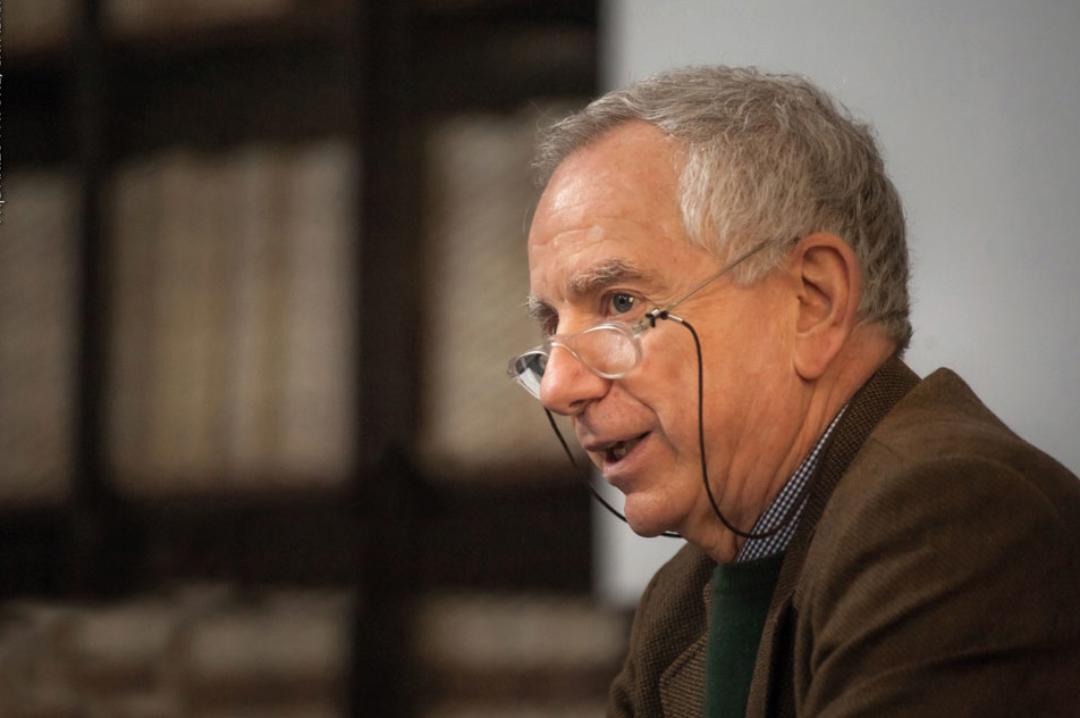Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Sono lontani i tempi in cui, per fare storia dell’archeologia, bisognava ricorrere alla lettura dei necrologi. Oggi quel racconto è praticato con successo. Ma la divulgazione bisogna saperla fare, Andrea Augenti la sa fare benissimo e il lettore se ne rende conto subito perché gli occhi che leggono sentono al tempo stesso la voce dell’autore, che quelle storie le ha magistralmente raccontate nelle trasmissioni di Radio 3, che dall’audio al testo scritto non perdono nulla della loro vivacità.
Le vite raccolte non vogliono immortalare un pantheon dei «migliori»: sono scelte dichiaratamente soggettive e non ha senso indicare questa o quell’assenza. A partire da Michele Mercati, fascinoso antiquario cinquecentesco, di cui Augenti ci regala una commovente e attualissima citazione pacifista. L’autore sceglie alcuni dei maestri del passato per «frugare nelle pieghe delle loro esistenze», illustrarne le origini, l’estrazione sociale (l’archeologia fu a lungo un hobby per aristocratici), le relazioni pubbliche e private. Non per gossip, ma per capire come, quando e perché l’archeologia, che fa storia attraverso le tracce materiali dell’umanità, abbia definito i propri obiettivi e strumenti. Un corpo vivo di caratteristiche si è andato edificando mattone su mattone, regalando all’archeologia l’immagine non solo di una somma di conoscenze in continuo accrescimento, ma quella di un metodo per individuarle, estrarle dal magma indistinto del terreno e interpretarle.
Nel libro rivivono i personaggi che hanno dotato l’archeologia dei suoi strumenti privilegiati (le analisi tecnologiche, tipologiche e stratigrafiche), sorretti dal metodo comparativo e da un imprescindibile sguardo contestuale: pilastri del fare storia attraverso l’archeologia, cui ognuna delle personalità biografate ha portato un contributo teorico e operativo. Un esempio per tutti: il passaggio dallo sterro al metodo di scavo stratigrafico. Lungo e faticoso perché è impossibile stabilire chi, come e quando abbia inventato questa procedura senza la quale l’archeologia non potrebbe definirsi tale. Valgano invece le parole sempre attuali di Giacomo Boni che suggerivano: «meglio dello scavare conviene apprendere a scavare».
Augenti non è sempre tenero nei giudizi, che si tratti degli eccessi ricostruttivi di Arthur Evans o delle falsificazioni di Heinrich Schliemann. La vicenda surreale del Tesoro di Priamo, conteso fra Russia, Germania e Turchia, mi riporta a un’idea che ho sempre ingenuamente coltivato che quello possa diventare in un domani diverso dall’oggi il primo patrimonio culturale indiviso di tutta l’umanità...
Lo studio del passato, infatti, non si pratica per fuggire dal presente. Si può essere archeologi provetti e vivere a pieno nel mondo (pensiamo al patriottismo di Giuseppe Fiorelli, uno dei fondatori della tutela archeologica italiana) testimoniando una visione etica del proprio lavoro. Ad esempio, riconoscendo che «uno scavo non pubblicato è come uno scavo mai fatto», come diceva già il grande Pitt Rivers; ma anche, guardando un po’ più in là, denunciando il Mein Kampf di Hitler, come non temeva di fare il grande Vere Gordon Childe (Hitler, che il grande Ranuccio Bianchi Bandinelli descriveva come «qualche cosa come un controllore del tram»). O come il grande Worsaae, che a metà Ottocento contrastava chi rivendicava «il diritto nazionale del popolo tedesco a rioccupare i luoghi dove erano già stati i popoli di stirpe germanica», ricordando come terre storicamente tedesche fossero state abitate per lunghi secoli da popolazioni slave. O come la grande Kathleen Kenyon, che già sessant’anni fa denunciava le ingiustizie subite dalla popolazione palestinese, che avrebbero profeticamente portato «alla costruzione di un antagonismo ancora più grande»: denuncia che le valse, già allora, l’ignobile accusa di antisemitismo...
Per rimanere nel presente mi piace accennare al miracolo dei calchi delle vittime dell’eruzione di Pompei, la cui fisicità «va molto al di là degli scheletri» perché, osserva Augenti, quei calchi «si collocano proprio in quell’intersezione [...] tra la vita e la morte, che è il territorio in cui abitualmente si muove l’archeologia». E pensare che oggi alcune voci stralunate si levano contro l’esposizione di quei calchi per un non meglio specificato rispetto per le vittime, secondo i dettami politicamente corretti, che predicano l’oscurantismo e l’ignoranza.
Mortimer Wheeler ci ha insegnato che gli archeologi non scavano oggetti, ma esseri umani, tuttavia coltivando il senso del limite: «L’archeologo, scriveva, può trovare la botte, ma Diogene gli sfuggirà. Dobbiamo essere contenti di fare ciò che possiamo con il materiale che ci è stato consegnato, nella piena consapevolezza della sua incompletezza».
Archeologi. I maestri del passato,
di Andrea Augenti, 316 pp., 68 figg. b/n, Carocci, Roma 2025, € 24
Altri articoli dell'autore
Appello al ministro Giuli: nel silenzio generale, si sta decidendo che qualsiasi foto scattata d’ora in poi, magari anche per errore con la fotocamera del cellulare, non potrà essere divulgata liberamente se non a partire dal 2095
L’ultimo libro di Giuliano De Felice per Laterza secondo Daniele Manacorda opera una «“scelta di campo” rischiosa»
L’archeologo Daniele Manacorda traccia una road map per il neonominato al dicastero del Collegio Romano
Il vero problema sembra essere la nuova (vecchia) organizzazione per Dipartimenti, già varata ai tempi del ministro Buttiglione e presto abbandonata non per motivi politici, ma perché ritenuta non adeguata a un Dicastero come quello della Cultura, capillarmente distribuito sul territorio