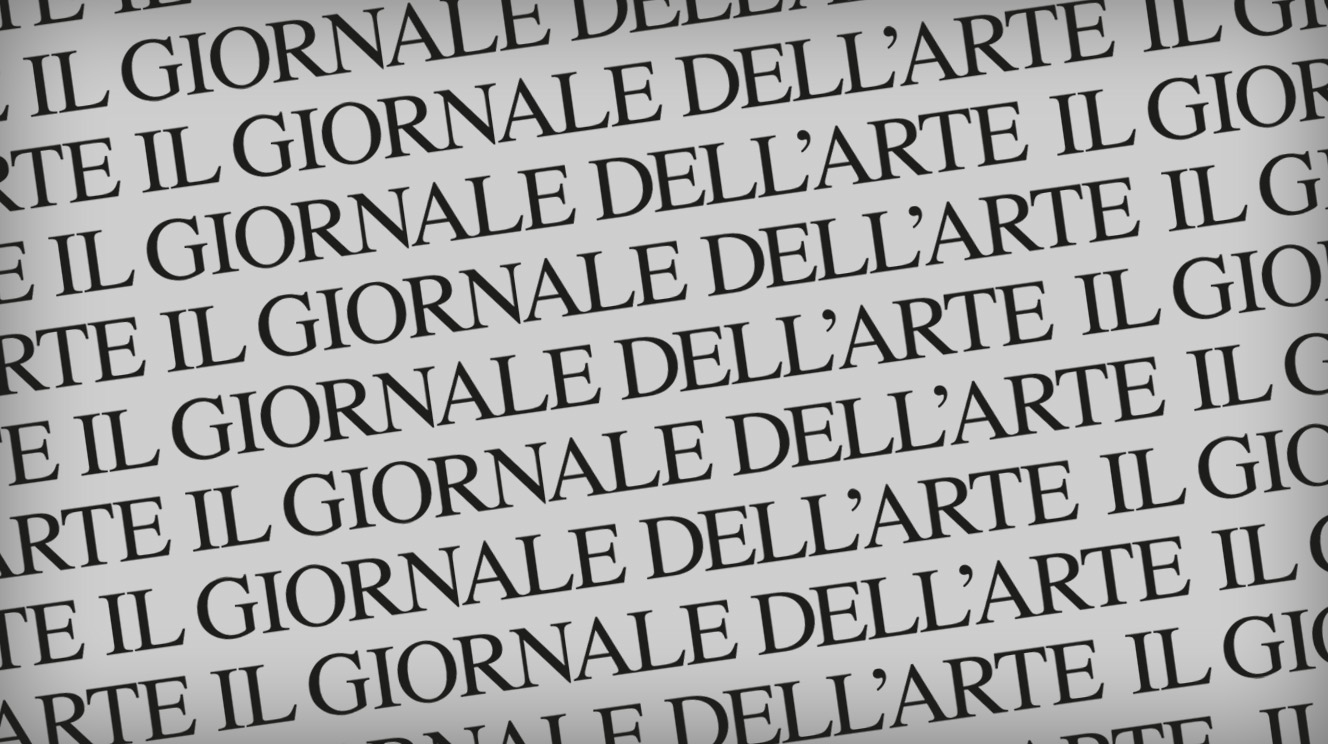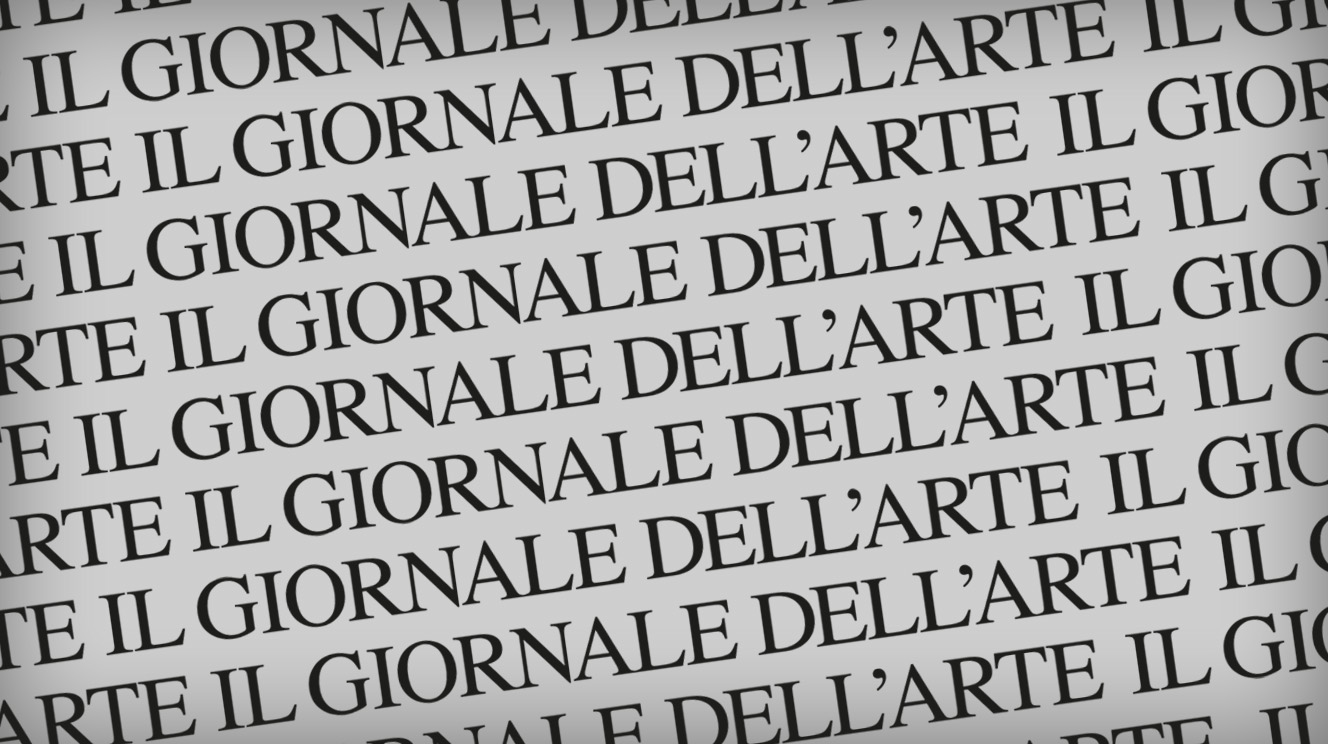Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Bozena Anna Kowalczyk
Leggi i suoi articoliI musei italiani posseggono un discreto numero di dipinti di Canaletto, Bellotto e Guardi, protagonisti della pittura veneziana di vedute del Settecento. La veduta è un genere razionale e illuminista ma nello stesso tempo poetico, sofisticato nella tecnica e nell’impaginazione prospettica ma di immediata lettura, decorativo ma di un rigoroso valore documentario; era talmente attuale e moderno da appassionare il mondo del più aggiornato collezionismo e da far nascere scuole e una fitta schiera di imitatori e falsari. Fin dai primi studi su questi artisti fu chiara la necessità del corretto riconoscimento e distinzione, ma nonostante l’impegno più che secolare sussistono abbagli attributivi, tanto più gravi quando concernono importanti opere esposte nelle collezioni pubbliche.
Giovanni Antonio Canal, noto come Canaletto (Venezia, 1697-1768), è magnificamente rappresentato in tutte le fasi della sua carriera da una ventina di dipinti scelti, provenienti perlopiù da importanti collezioni settecentesche, alcuni documentati fin dalla commissione; tutti, con poche eccezioni, riportati in Italia dall’Inghilterra.
Dalla metà circa degli anni Venti del Settecento serie intere delle sue opere abbandonano Venezia e l’Italia, prima verso l’Impero asburgico e la Sassonia, poi, con la conversione illuminista, verso il collezionismo britannico del Grand Tour. Già prima del 1817 il principe Giovanni Torlonia (1754-1829), banchiere e collezionista, acquista quattro vedute di Venezia, di San Marco e del Canal Grande, del periodo più operoso di Canaletto, i primissimi anni Quaranta, dotate di tutti i caratteri amati dagli inglesi: la prospettiva razionale, la luce limpida e una miriade di dettagli. Passate allo Stato con il suo lascito testamentario, dal 1892 appartengono alla Galleria Nazionale d’Arte Antica in Palazzo Barberini.
Nel 1908 Ettore Modigliani, direttore di Brera e poi soprintendente alle Belle Arti a Milano, è artefice dell’acquisto per la Galleria Borghese di due piccole tele, «La Basilica di Massenzio» e «Il Colosseo», le uniche vedute romane dell’artista in un museo italiano e le uniche del periodo inglese. Nel 1922-24 lo stesso Modigliani suggerisce a Luigi Albertini (1871-1941), stimato direttore del «Corriere della Sera», l’acquisto di due monumentali vedute di Venezia, «Il Molo verso ovest, con la colonna di san Teodoro a destra» e «Il Molo e la Riva degli Schiavoni, verso est», apparse a un’asta Christie’s a Londra nel 1922 con la collezione di undici Canaletto formata da Thomas Osborne, IV duca di Leeds (1713-89); acquisite dal Comune di Milano nel 1995 per il Castello Sforzesco, rappresentano l’eccellenza della prima maturità dell’artista. Nel 1956 Mario Crespi, dell’importante famiglia di imprenditori lombardi e proprietari del «Corriere della Sera», riesce ad assicurarsi due imponenti opere della giovinezza di Canaletto, del 1723 circa, «Il Canal Grande dal Palazzo Balbi fino a Rialto» e «Il Rio dei Mendicanti», provenienti dalla collezione Liechtenstein a Vienna; dal 1983 vengono ammirate dai visitatori del Museo del Settecento Veneziano, Ca’ Rezzonico. Nel 2001, infine, Gianni Agnelli porta da Londra due copie di pendant, tre vedute del Canal Grande e «Il Campo Santi Giovanni e Paolo», emozionanti e uniche, commissione del 1725 del nobile lucchese Stefano Conti, documentata quasi giorno per giorno; fanno parte della Pinacoteca Agnelli di Torino. Ricordiamo che le Gallerie dell’Accademia di Venezia conservano il celebre «Capriccio», saggio d’ammissione all’Accademia di Belle Arti, l’ultimo dipinto datato, e le Gallerie degli Uffizi posseggono «Il Canal Grande da Palazzo Balbi verso Rialto», inviato nel 1728 da Anton Maria Zanetti (1680-1767) all’amico Francesco Maria Gabburri. Altri rari ma fondamentali dipinti che non hanno mai lasciato l’Italia sono gelosamente custoditi nelle collezioni private, le due imponenti immagini delle feste, «L’ingresso al Palazzo Ducale dell’ambasciatore imperiale Giuseppe Bolaños Navia y Moscoso» e «Il Bucintoro al Molo il giorno dell’Ascensione», commissionate nel 1729 dallo stesso ambasciatore, acquistate nei primi anni Trenta del secolo scorso da Aldo Crespi, fratello di Mario, e il non meno celebre «Fonteghetto della Farina», eseguito nel 1728 circa per il nobile intellettuale veneziano Giambattista Recanati (1687-1734).
Tre dipinti, attribuiti tradizionalmente a Canaletto o a «Canaletto e studio», vanno esclusi da questa splendida compagine, come chi scrive ha ampiamente disquisito in un recente saggio, pubblicato nel volume Il Seicento e il Settecento alle Gallerie dell’Accademia. Nuovi Studi (a cura di Giulio Manieri Elia e Michele Nicolaci, Officina Libraria, Roma 2024): sono la coppia di pendant «Capriccio con rovine di una cappella» e «Capriccio con un arco gotico», già Contini Bonacossi, delle Gallerie dell’Accademia di Venezia (recupero Siviero), e la versione più ampia del primo, acquistata nel 1933 per il Museo Poldi Pezzoli dalla collezione dello storico dell’arte Robert Langton Douglas (1864-1951), su suggerimento dello stesso Modigliani; è ora il fulcro della nuova, elegantemente allestita sala del Settecento veneziano, dove fa da contrappunto al «Prato della Valle, Padova», del tardo Canaletto (acquisizione di Gian Giacomo Poldi Pezzoli del 1879). Questi dipinti, che seguono i modelli di Canaletto, appartengono a un’amplissima serie di repliche, realizzate dalla metà circa del Settecento fino alla fine del secolo o oltre, un incredibile successo collezionistico spiegabile con il messaggio massonico che trasmettono. Soltanto del «Capriccio con rovine di una cappella» è stato identificato in una collezione privata l’originale del maestro; eseguito nel 1742-44, è stato replicato prontamente ma con un tocco personale dal nipote e allievo Bernardo Bellotto (Venezia, 1722-Varsavia, 1780).
Questi, dotato di talento eccezionalmente precoce, oltre a essersi distinto già nel 1738-42 nel collezionismo inglese come alter ego dello zio, si fa conoscere in Italia, a Firenze e Roma, e più tardi, a Milano, Torino e Verona, gratificato da importanti commissioni dei nobili, veneti, toscani e lombardi, e di un re, Carlo Emanuele III di Savoia, prima di lasciare definitivamente l’Italia per Dresda nella primavera del 1747. Una parte delle opere formidabili create nella giovinezza rimane in Italia, scandendo i suoi sviluppi: un nucleo compatto, di circa 15 dipinti, dal «Rio dei Mendicanti, Venezia», del 1741, delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, già collezione Girolamo Manfrin, l’unica veduta della sua città natale ma emblematica dello stile, tecnica e rigore prospettico degli inizi, passando per l’«Arco di Tito» del 1743 circa, dell’Accademia Carrara, lascito del conte Giacomo Carrara, un piccolo gioiello di materia densa e luminosa, per i due meravigliosi «Capricci» del Museo Civico di Asolo, per la coppia di Brera, «Villa Perabò a Gazzada» e il «Villaggio di Gazzada», magici capolavori, come i due pendant che immortalano la Torino in espansione, «L’antico ponte sul Po» e «Il Palazzo Reale», della Galleria Sabauda, fino alla monumentale serie di quattro «Capricci» della Galleria Nazionale di Parma (probabile commissione del marchese Giacomo Antonio II Sanvitale, diplomatico parmense residente a Venezia, ricordato da Casanova). Il «Broletto Nuovo e il palazzo dei Giureconsulti, Milano» è un prezioso acquisto del 1998 del Comune di Milano dalla Matthiesen Gallery, Londra, per il Castello Sforzesco; la veduta di «Vaprio e Canonica sull’Adda verso sud, Lombardia», già collezione Mario Crespi a Milano, entra nel Museo di Capodimonte nel 2004, dono di Bianca de Feo Leonardi e Antonino Leonardi, Roma.

Copia da Bernardo Bellotto, «Il Mercato della Città Nuova, Dresda», 1800 ca, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica in Palazzo Barberini

Lorenzo Bellotto, «Il Castello Imperiale di Schlosshof, Vienna», 1760 ca, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica in Palazzo Barberini
Vanno escluse da questo corpus compatto le uniche vedute europee che nella Galleria Nazionale in Palazzo Barberini portano ancora l’etichetta con il nome di Bellotto, «Il Mercato della Città Nuova, Dresda» e «Il Castello Imperiale di Schlosshof, Vienna», parte del lascito del duca di Cervinara (1962), e non a causa del soggetto. Nel 1967 Pietro Zampetti espone ambedue come pendant alla celebre mostra al Palazzo Ducale di Venezia «I vedutisti veneziani del Settecento», citando l’opinione orale di Stefan Kozakiewicz (confermata nella fondamentale monografia pubblicata nel 1972) che giudicava una copia il primo e opera di collaborazione con il figlio Lorenzo il secondo. Oggi, dopo decenni di studi, poco si può aggiungere al parere dell’illustre studioso polacco per quel che riguarda la veduta di Dresda: è definitivamente una copia anonima tarda tratta da due stampe, debole nella tecnica e diversa nella materia. L’idea della copia, accolta nei cataloghi della quadreria Barberini, è, a sorpresa, ribaltata in una recentissima mostra («Canaletto, Van Wittel, Bellotto. Il Gran Teatro delle Città. Capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica», al Complesso Monumentale di San Francesco di Cuneo, catalogo a cura di Paola Nicita e Yuri Primarosa, MondoMostre, 2024), dove la tela è presentata con il nome di Bellotto! Chi ha steso la scheda ci fa anche sapere che l’artista è nato il 30 gennaio 1721, aggiungendo enigmaticamente «o, secondo alcuni, il 20 maggio 1722» e ci fa sperare nel ritrovamento delle casse con la sua biblioteca, mentre noi eravamo fermamente convinti, sulla base dei documenti pubblicati nel 1993, 1995 e 2012 che fosse nato il 20 maggio 1722 e che le casse con i suoi beni fossero andate distrutte nel luglio del 1760 assieme alla casa in Salzgasse a Dresda dai cannoni dell’esercito prussiano, come ha lamentato lo stesso proprietario. Né rappresenta Bellotto «Il Castello Imperiale di Schlosshof», meticoloso ma impacciato nella resa dei dettagli delle architetture, grossolano nella stesura del colore, goffo nelle figure. Il dipinto, una replica ridotta di un capolavoro del maestro, è invece da ascrivere integralmente al figlio Lorenzo (1742-70), a Vienna diciottenne e già presente nell’atelier del padre, secondo la tradizione di questa famiglia di pittori.
Tanto più meraviglia, alla Galleria Nazionale di Parma, l’attribuzione a ribasso dei due carismatici «Capricci» di Bellotto, provenienti dalla collezione di Enrico Pellegrini, ampiamente studiati ed esposti, anche da chi scrive. Le didascalie che recitano «Bernardo Bellotto (attribuito)» sono forse un nostalgico rimpianto dell’antica attribuzione al giovane Canaletto? Il nome di Canaletto porta invece, a sorpresa, il «Capriccio con ponte», pendant del «Capriccio palladiano», questo sì del grande vedutista, ambedue commissionati dal conte veneziano e intellettuale cosmopolita Francesco Algarotti (1712-64); una coppia stravagante ma ben documentata come una sorta di gara tra Canaletto e il suo valente competitor Giuseppe Moretti. La messa in luce di questa storia singolare ne accrescerebbe certo l’interesse, come anche l’inserimento del nome di Francesco Zuccarelli, che completa con le sue arcadiche figure due dei quattro «Capricci» di Bellotto, già Stefano Sanvitale, non svilirebbe l’apprezzamento di queste meravigliose opere.

Bernardo Bellotto, «Capriccio lagunare», 1746, Parma, Galleria Nazionale

Giuseppe Moretti, «Capriccio con ponte», 1744 ca, Parma, Galleria Nazionale
Francesco Guardi (Venezia, 1712-93) è presente con una compagine variegata, che rispecchia la sua natura creativa e capricciosa, così lontana dalla razionalità di Canaletto e Bellotto: poco più di quaranta tele e tavole, perlopiù piccole o di medie misure, vedute e capricci, disseminate nei vari musei lungo la penisola, di epoche diverse. I capolavori sono altrove, ma quando si uniscono la qualità e conservazione, Guardi ci incanta, come nel caso del «giovanile» e limpido «Bacino di San Marco dalla Piazzetta» del Museo di Santa Caterina di Treviso, di cui eccezionalmente si risale alla storia settecentesca, veneziana; della tarda tavoletta del «Rio dei Mendicanti», lascito conte Guglielmo Lochis, a cui il recente intervento di restauro di Carlotta Beccaria ha restituito la cromia luminosa e argentata o «L’isola di San Giorgio Maggiore» e «Il ponte di Rialto da nord», già Mario Crespi, donate al Museo di Capodimonte assieme alla veduta di Vaprio di Bellotto qui sopra menzionata.
Sono principalmente i grandi collezionisti dell’Ottocento ad assicurare ai musei le opere dell’artista, dal conte Guglielmo Lochis ad Antonio Guasconi, a Cesare Bernasconi ed Emilio Sernagiotto.
Con il lascito testamentario stilato nel 1848 dal nobile monzese e ingegnere Pietro Oggioni (1779-1855), cavaliere dell’Ordine di San Michele di Baviera, collezionista e mercante, nel 1855 entrano alla Pinacoteca di Brera, con 146 dipinti, italiani di varie epoche, fiamminghi e olandesi (23 vengono poi restituiti all’erede Ferdinando Oggioni), due tele con il nome di Francesco Guardi, «Veduta del Ponte di Rialto in Venezia» e «Veduta del Canal Grande in Venezia», cui viene attribuito un prezzo altissimo, di 4mila lire ciascuno. Il lavoro secolare di studiosi ha portato a rivedere le antiche attribuzioni senza mai gettare dubbi sull’autenticità dei due Guardi, gli unici a rappresentare l’artista nella Pinacoteca di Brera, accanto ai capolavori di Bellotto. Assieme alla pala d’altare di Carlo Crivelli del 1493 proveniente dalla Chiesa di San Francesco a Fabriano, l’«Assunzione della Vergine» di Lorenzo Lotto e una scena storico-religiosa di Giovanni Domenico Tiepolo, sono ritenute le opere più importanti del lascito Oggioni.
Eppure, per una serie di motivi, questi due dipinti, «Il Canal Grande da Palazzo Grimani fino al Ponte di Rialto» e «Il Canal Grande con le Fabbriche Nuove di Rialto» vanno considerati come lavori di un abile imitatore/falsario dei primi decenni dell’Ottocento, probabilmente inglese. Sono la consistenza della materia, diversa da quella «magra» di Guardi, i colori accesi e la resa insolitamente vivace dei palazzi che si susseguono lungo il Canal Grande, già dal sapore ottocentesco, che hanno messo in guardia chi scrive già nel 2012-13, alla mostra monografica al Museo Correr di Venezia. La stessa composizione della coppia è atipica: la veduta con il Ponte di Rialto è ripresa dal livello dell’acqua, l’altra, con le Fabbriche Nuove, dal piano alto di un palazzo, probabilmente Belloni Erizzo; la prima, è risultato di una strana compressione in un formato tendente al quadrotto delle due versioni autografe di pronunciata orizzontalità (ambedue esposte alla mostra del Museo Correr); la seconda, prospetticamente distorta, non ha precedenti né repliche, ma esiste al British Museum un disegno, forse della stessa mano e a imitazione della tecnica dell’artista, che la segue fedelmente in dimensioni molto vicine. Proviene dalla collezione di James Byam Shaw, grande conoscitore dei disegni, che annotò nel verso: «Modern forgery of Guardi» (Falsificazione moderna di Guardi, Ndr).
Chi può essere stato così bravo a ingannare anche gli specialisti, che comunque non sono mai riusciti ad assegnare alle due tele una data precisa? L’ipotesi più affascinante è quella che conduce a John Ingram (1767-1841), ricordato da Francis Haskell e Antonio Morassi per aver posseduto diversi dipinti di Francesco Guardi commissionati direttamente all’artista. Sia lui, che sua figlia Augusta, si dilettavano a copiarli. Ma questo è un altro capitolo.

Imitatore di Francesco Guardi, «Il Canal Grande da Palazzo Grimani fino al Ponte di Rialto», 1800-40 ca, Milano, Pinacoteca di Brera

Imitatore di Francesco Guardi, «Il Canal Grande con le Fabbriche Nuove di Rialto», 1800-40 ca, Milano, Pinacoteca di Brera
Altri articoli dell'autore
Due esempi di cataloghi museali di ultima generazione che vale la pena avere nella propria biblioteca
Un percorso labirinto e dubbie attribuzioni rendono ingiustamente il paesaggio veneziano settecentesco un genere minore