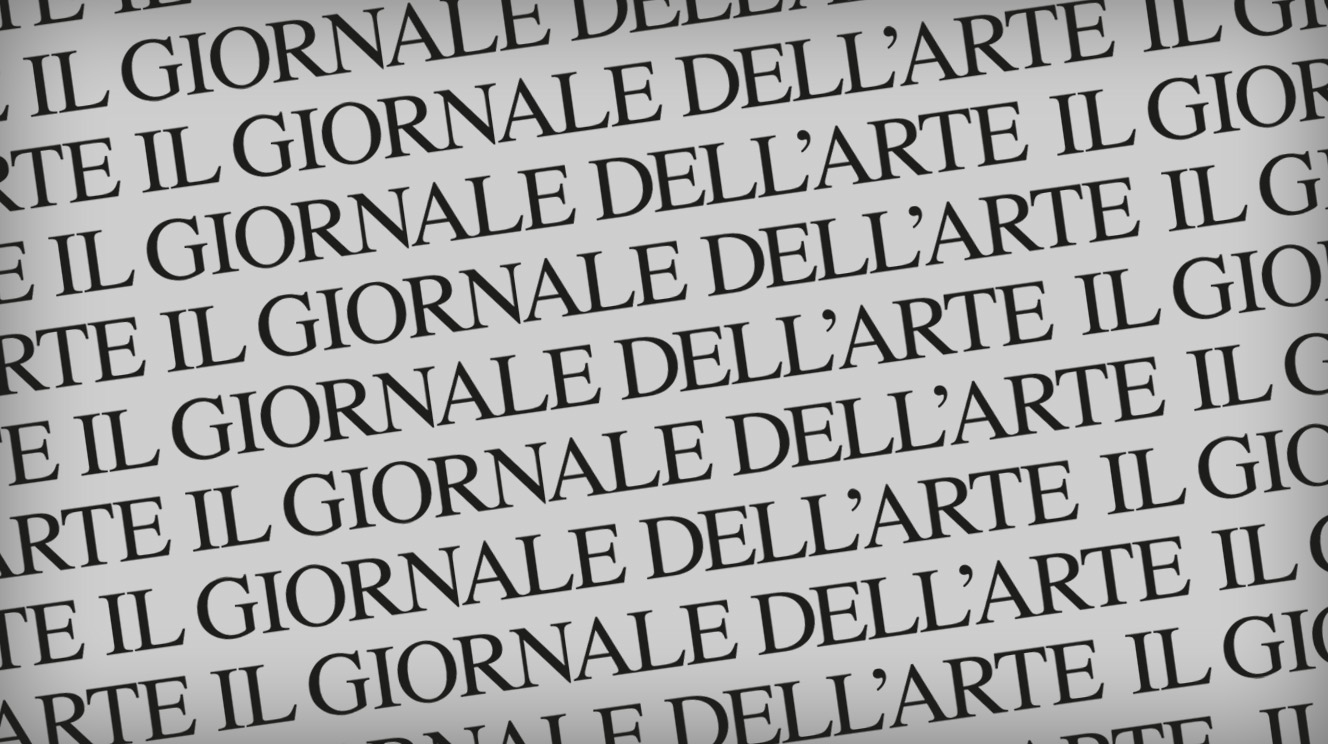Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Milano. Bernardino Luini sembra conoscere una nuova stagione d'oro, pari a quella di cui godette tra fine Sette e Ottocento, compiici Mengs, Giuseppe Bossi e poi Ruskin (ma il suo primo «recupero» si deve al cardinale Federico Borromeo che ne ribaltò la sfortuna cinquecentesca dovuta al solito Vasari, mai tenero con chi non fosse fiorentino).
Una serie di fortunate coincidenze e di restauri che si completano in queste settimane riporta dunque alla ribalta il pittore lombardo, con la sua bottega familiare e la sua cerchia, che seppe coniugare la lezione di Leonardo con la tradizione lombarda in cui si era formato e con la «Maniera nuova», dando vita a un'arte singolare, caratterizzata da un rigore sommesso e da una ricchezza cromatica sfolgorante.
Tra maggio e giugno sono stati portati a compimento i restauri di due suoi cicli pittorici, nel piccolo Oratorio della Passione in Sant'Ambrogio il primo, frammentato ma prezioso; in quel gioiello dell'arte milanese che è la chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore in corso Magenta il secondo: due edifici che dal tempo delle soppressioni napoleoniche avevano subito un continuo degrado, specie per l'aggressione dell'umidità.
Nell'Oratorio della Passione, restaurato in un anno di lavori e con 300 mila euro d'investimento grazie a Zambon Group e Mapei (che ne ha curato l'aspetto tecnico), sono tornati a risplendere la volta e, soprattutto, l'abside con gli affreschi di Luini, già restaurata negli anni Sessanta del secolo scorso da Mauro Pelliccioli.
La chiesa di San Maurizio è separata in due parti da un tramezzo: una aperta al pubblico e una più grande riservata alle monache (cfr. Il Giornale dell'Arte n. 199, mag; '01, p. 34). Nella prima si è intervenuti sugli affreschi del tramezzo e di tre cappelle, nella seconda, l'aula delle monache, il restauro è stato complessivo a esclusione della volta.
La chiesa del monastero, che ospitava del resto le figlie della migliore nobiltà milanese, conserva una sorta di antologia della pittura milanese dal tempo degli Sforza fino a Carlo Borromeo: la prima pietra fu posta nel 1503, su progetto, spiega la soprintendente milanese Maria Teresa Fiorio, «di un grande architetto di formazione bramantesca, che probabilmente dettò le linee non solo della struttura architettonica ma anche del progetto decorativo. Si era ipotizzato che si trattasse di Gian Giacomo Dolcebuono e alcuni documenti sulla base dei quali G. Battista Sannazzaro ne ha posticipato la morte al 1510 rendono verosimile l'attribuzione».
La prima fase della decorazione, preluinesca, risale agli anni dieci del Cinquecento; dal decennio successivo, fino alla morte, nel 1532, irrompe poi Bernardino Luini, con il suo linguaggio apparente mente facile e piano, in realtà colto e sofisticato (il suo primo intervento qui, secondo Pietro C. Marani, sarebbero gli sfarzosi ritratti sul tramezzo dei committenti, Alessandro Bentivoglio e la moglie Ippolita Sforza). Poi il cantiere subisce una battuta d'arresto e quando riprende, alla metà del Cinquecento, Milano è cambiata: tramontata la signoria sforzesca, passati i francesi, ora è sotto l'Impero. I lavori riprendono presumibilmente nel 1572, data trovata ora sulla volta (la cui decorazione si credeva neogotica e che invece è cinquecentesca, certo ispirata al cantiere del Duomo): nel clima borromaico vengono dettate nuove, più severe regole e la decorazione della chiesa di San Maurizio si adegua. Sopraggiungono nuovi artefici e ai figli di Bernardino Luini (Aurelio, Evangelista, Giovan Pietro) si affiancano i Piazza da Lodi, il genovese Ottavio Semino, il veneto Simone Peterzano (maestro di Caravaggio), il cremonese Antonio Campi. I restauri hanno permesso una migliore leggibilità delle pitture, il che consentirà forse di dare nomi alle mani che ancora sono anonime. E a proposito di Bernardino Luini va segnalato infine che alla Pinacoteca di Brera di Milano Maria Teresa Fiorio ha esposto gli affreschi restaurati delle «Storie della Vergine e di san Giuseppe» provenienti dalla quattrocentesca chiesa di Santa Maria della Pace a Milano, e le storie bibliche e profane, provenienti dalla villa suburbana di Gerolamo Rabia, che sono tra le opere più pregiate delle raccolte braidensi.
Altri articoli dell'autore
A settembre al Palazzo Reale di Milano, dov’è ricostruito il fregio dei «Fasti di Napoleone» distrutti nell’ultima guerra mondiale, un centinaio di opere dell’artista (anche inedite). A complemento, un itinerario nei «suoi» luoghi
A Mantova la Fondazione sostiene il restauro della più sontuosa delle sale di Giulio Romano in Palazzo Te: «In Italia si pensa a lasciare tutto ai figli, ma per me, cresciuta nella cultura americana, è un gesto naturale»
Compie 25 anni Arthemisia, la società che ha aperto tante nuove strade nella produzione di mostre e che, nonostante le perplessità di alcuni e le traversie giudiziarie, ottiene grandi successi attraverso la «democratizzazione» dell’arte
Il cantiere, avviato all’inizio del 2023 grazie ai fondi del Pnrr, ha riguardato la ricomposizione dei parterre, il rifacimento dei tappeti erbosi e la cura delle carpinate, anche sulla base delle incisioni di Marc’Antonio Dal Re