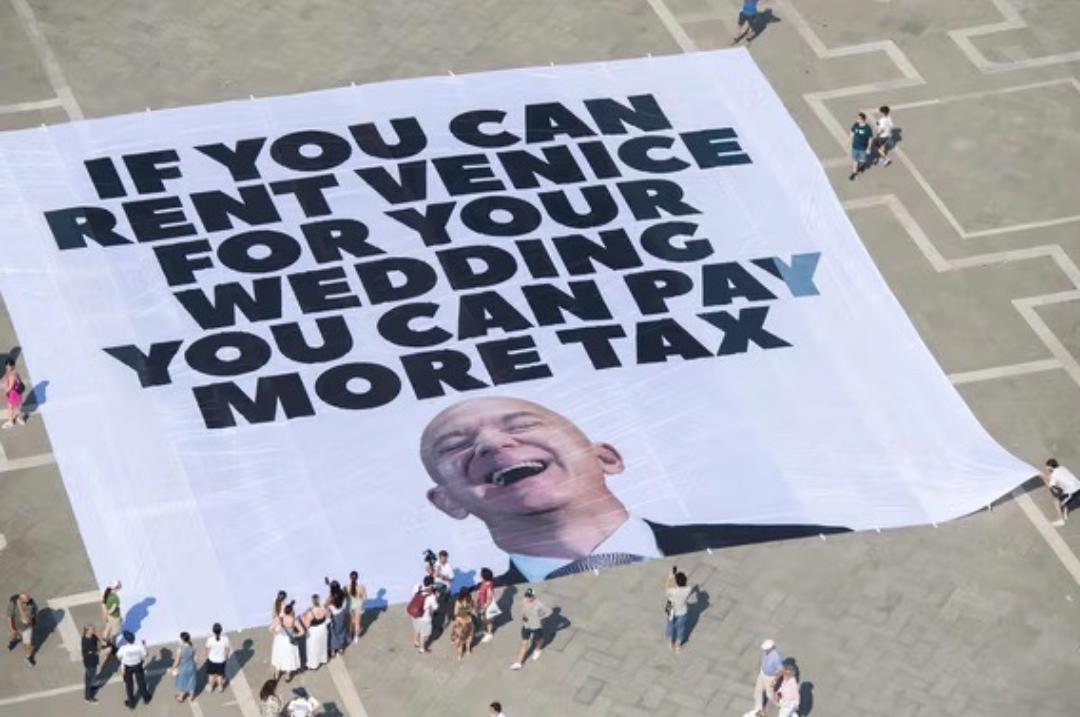Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Anna Somers Cocks
Leggi i suoi articoliRiad. Nel 1877, dopo 28 giorni trascorsi a dorso di un cammello, un inglese che si faceva chiamare Khalil arrivò, esausto e con il volto bruciato dal sole, ad Al-Ula, città oasi dell’Arabia nord-occidentale, insieme a decine di migliaia di fedeli in pellegrinaggio da Damasco verso Medina e La Mecca. Khalil, che non sarebbe anacronistico definire il primo turista occidentale della storia, si fermò qui per ammirare le tombe rupestri di Meda’in Salih (in arabo «Le città di un profeta musulmano», corrispondente all’antica Hegra) di cui aveva sentito narrare meraviglie a Damasco.
Quelle tombe sono la punta di diamante su cui punta l’industria del turismo saudita, al centro di una svolta epocale se si pensa che fino a poco fa tutti gli sforzi erano indirizzati verso l’obiettivo opposto: tenere lontano chiunque manifestasse anche solo curiosità per questi luoghi. Da settembre 2019, invece, l’Arabia Saudita rilascia visti turistici online e all’ingresso nel Paese. In particolare chi è in possesso di un passaporto dell’Unione Europea o di alcuni altri Paesi/territori può ottenere il visto elettronico a pagamento via web o all’arrivo. I visti hanno validità di 90 giorni (www.saudiarabianvisa.com).
Situate letteralmente in mezzo al deserto, le tombe rupestri di Medain Saleh sono opere di arte classica del I secolo d.C. e furono utilizzate per seppellire gli abitanti della ricca città più a sud del Regno dei Nabatei, la civiltà a cui dobbiamo il sito di Petra in Giordania. Tolomeo chiamò la città Hegra registrando che si trovava lungo la rotta commerciale su cui oro e incenso viaggiavano provenienti dallo Yemen.
Il Corano, d’altro canto, la definisce il luogo su cui si abbattè la punizione divina per i suoi idolatri e che venne abbandonato a partire dal VII secolo, lasciando i mausolei, con i loro frontoni, colonne e aquile imperiali, come unica testimonianza del legame tra Arabia, Grecia e Roma, e tra Europa e Mediterraneo, spezzatosi da allora.
Fino a poco fa. Adesso, infatti, il principe ereditario Mohammed bin Salman Al Saud è determinato a riallacciare quel rapporto con il resto del mondo rimasto interrotto per secoli, grazie soprattutto a «Saudi Vision 2030», il programma di rilancio del Paese sulla scena internazionale. Uno dei decreti approvati dal principe punta proprio a rendere Al-Ula e l’area di Medain Saleh facilmente accessibile ai turisti.
L’incarico è stato affidato al presidente della Commissione Reale per Al-Ula (Rcu), il principe Badr bin Abd Allah Al Saud, ministro della Cultura del Regno saudita dal 2018 (anno in cui fu istituito il Ministero), il quale deve assicurarsi che il progetto si realizzi preservando i tesori del sito e secondo criteri ecologicamente e culturalmente sostenibili.
Ma torniamo alla storia del nostro prototurista Khalil, il cui vero nome era Charles Doughty, medico, storico e poeta innamorato della lingua araba. Informato dei pericoli della regione, tra cui i predatori beduini, e invitato restare nel qalaa, il forte dei pellegrini nei pressi di Al-Ula (visibile ancora oggi), Doughty vi si fermò per diverse settimane, durante le quali studiò le iscrizioni in arabo antico sulle pareti delle tombe.
Quando visitò la città il suo arrivo fu accompagnato dagli schiamazzi dei bambini al grido di «Ahah, il Nasrani!» («Ahah, il cristiano!»), mentre i vecchi, dopo aver rimproverato i ragazzi, lo accolsero con parole cordiali, «Kul wahed ali din-hu» (A ciascuno la sua religione) e gli permisero di partecipare alle proprie assemblee. Tornato in Inghilterra scrisse Arabia Deserta, pubblicato nel 1888 (e poi uscito in molte riedizioni), considerato la miglior cronaca di viaggio scritta da un occidentale sulla Penisola araba, su cosa significava attraversare quei luoghi in quegli anni, sulle difficoltà, i pericoli, l’ospitalità.
Oggi i predatori beduini non ci sono più, e le difficoltà sono ridotte al minimo: Al-Ula è ben collegata con voli regolari da Riad, Gedda e Medina e piena di strutture di accoglienza. Certo, la distanza culturale tra Occidente e Arabia Saudita è ancora ampia, e la sfida per i sauditi sarà quella di costruire nuove connessioni creative ed emotive tra i due mondi. Di certo l’omicidio del giornalista dissidente Adnan Khashoggi, avvenuto nel 2017 all’interno del Consolato saudita a Istanbul, ha ostacolato a dirti poco il progetto e molti hanno messo in atto forme di boicottaggio nei confronti del Regno arabo.
Come 3 dei 14 membri del board di «Desert X», l’artista Ed Ruscha, la storica dell’arte Yael Lipschutz e la stilista Tristan Milanovich, che si sono tirati indietro dal progetto. Tuttavia, chi governa è una cosa, le persone sono un’altra, e negli ultimi 15 anni la scena artistica in Arabia è stata degna di nota, molti dei suoi esponenti si sono impadroniti del linguaggio concettuale dell’arte grazie a Internet e sanno esprimersi con creatività e coraggio, ragione per cui a boicottarli si rischia solo di fare un regalo a chi sostiene gli aspetti più repressivi del regime.
«Desert X Al-Ula» è nato grazie al principe Sultan bin Fahad Al Saud, anch’egli artista, il quale, dopo aver visto in prima persona l’evento californiano di Coachella, ha chiesto al curatore inglese dell’iniziativa, Neville Wakefield, di considerare la possibilità di replicare «Desert X» ad Al-Ula. «Diversamente dalla politica, il deserto non ha confini. Volevo che questa manifestazione gettasse un ponte fra le nostre culture diventando internazionale», dice il principe. I finanziamenti sono arrivati dall’Rcu, che è un ente dello Stato, il quale a sua volta, proprio per la natura assolutistica e di eredità tribale della monarchia, coincide con la famiglia reale Al Saud.
Non ha senso, quindi, definirli «soldi sporchi»: nel Regno saudita praticamente tutto il denaro arriva da lì, sia per gli ospedali, i musei o le decapitazioni. Grazie all’esperienza del team curatoriale tutto femminile composto da Raneem Farsi e Aya Alireza, «Desert X» ha visto la luce in soli 4 mesi, coinvolgendo artisti locali, europei e statunitensi. La location dell’evento è spettacolare: un canyon di arenaria a 10 chilometri da Al-Ula, con pareti scolpite dal vento, isole di massi levigati e rocce che assomigliano a dita puntate verso il cielo.
La mostra in realtà non ha un tema conduttore: «Nella Land art è il luogo che deve ispirare gli artisti. È anche una conversazione, in un certo senso: fra gli artisti e fra le opere e il pubblico. Il solo fatto di venire qui ha insegnato e ispirato un sacco di cose a me e agli artisti stranieri coinvolti», dice Wakefield. Al Farsi aggiunge che i temi emersi nelle varie opere vertono soprattutto sull’entrare in contatto con la comunità locale, la geologia del luogo, la poetica e la lingua, e sulle questioni legate all’esaurimento delle risorse naturali nel mondo.
I visitatori sono liberi di crearsi il proprio tragitto all’interno del canyon: il percorso si compie in circa un’ora e mezza, ma la passeggiata rappresenta di per sé un’esperienza, soprattutto per molti sauditi, abituati a guidare per andare ovunque. Nel frattempo, sul Mar Rosso, fino al 18 aprile è in corso il «21,39 Jeddah Arts Festival», alla sua 7ma edizione (cfr. n. 404, gen. ’20, p. 20), dove sperimentare al meglio un ampio spaccato dell’arte saudita odierna nella città più dinamica e aperta del Paese.
Durante «Desert X», Al-Ula ospita anche il secondo festival «Winter at Tantora», con performance, concerti e traversate in mongolfiera (fino al 7 marzo). Probabilmente in questo mese la piccola città nel deserto accoglie più eventi e turisti degli ultimi settant’anni, da quando passò di qui l’ultima carovana di pellegrini diretti a La Mecca, nel 1950. E i turisti qui, forse, sono una nuova specie di pellegrini.
Altri articoli dell'autore
Non è ancora confermato come i tre beneficiari collaboreranno su un tema di capitale importanza per la salvaguardia della città e per il mondo
Una guida in 10 punti, partendo dai 50mila euro raccolti da Palazzo Madama a Torino per acquisire cinque smalti del prezioso scrigno medievale
In una rara intervista del 2005 l’Aga Khan descrive il suo approccio globale per aiutare le comunità islamiche ad aiutarsi, ripristinando al contempo il loro patrimonio del passato: non basta ricreare un ambiente fisico senza affrontare anche i problemi sociali che lo circondano. Solo così si crea un «ambiente favorevole», dove possano fiorire la speranza, l'autosufficienza e la società civile
Dopo sei anni alla Pilotta di Parma, da nove mesi guida il museo fiorentino, sempre più minacciato dal sovraffollamento (5 milioni di ingressi nel 2023): il nuovo direttore vuole attirare pubblico a Palazzo Pitti e a Boboli, senza sacrificare i 40 milioni di euro di ricavi annui, con novità e progetti, dal Museo della Moda alla nuova Tribuna, al 30% di spazio in più nelle 12 sale dei Nuovi Uffizi