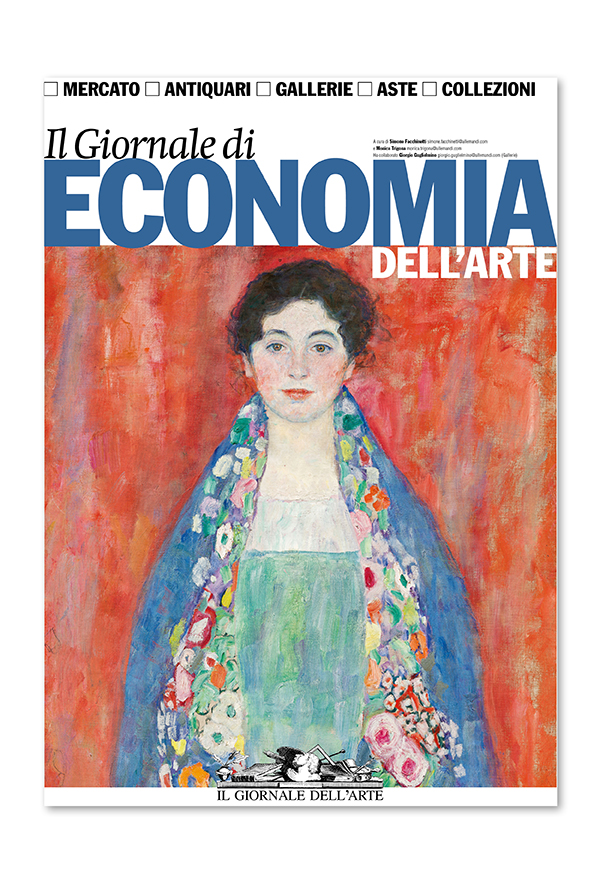Silvia Rosi è una giovane artista visuale emiliano-togolese, autrice di una ricerca espressiva che mette in dialogo la contemporaneità con la memoria. Il suo lavoro riporta a galla le storie di un’Africa celata, indagate relativamente a una prospettiva colonizzante sull’immaginario africano. Partendo dalla sua personale storia familiare, per poi raccontare la storia di un intero paese, Silvia cerca di ricreare un lessico visivo africano scevro da qualsiasi influenza derivante dal «dominatore bianco». Alla Collezione Maramotti, dal 28 aprile al 28 luglio 2024, in occasione della XIX edizione del festival Fotografia Europea di Reggio Emilia, Silvia Rosi espone la mostra «Disintegrata», con la quale l’artista porta la sua narrazione da personale a un livello collettivo e comunitario, creando un vero e proprio archivio familiare di afrodiscendenti in Italia.
Come ha sviluppato l’idea del progetto espositivo?
Il progetto si concentra sul concetto di «album di famiglia», tematica che ho sempre indagato, partendo, però, solitamente, dal mio personale album di famiglia. Questa volta, invece, la mia ricerca si è estesa anche a quello di altre persone (appartenenti, come me, alla diaspora africana) che hanno vissuto in Italia prima del 2000. È un progetto che analizza le foto d’archivio e le storie familiari, mettendo in dialogo il mio materiale con quello altrui. Partendo dal personale vorrei che le immagini del mio progetto diventassero universali all’occhio dello spettatore. Inoltre, lo scopo, non secondario, della mostra è anche quello di creare una comunità, un dialogo attraverso le fotografie, una possibilità per condividere storie che spesso passano sotto silenzio. La maggior parte delle persone che ci ha dato accesso ai loro album di famiglia non li apriva da molto tempo, così la mostra è diventata anche un modo per riattivare processi di memoria che erano sopiti, non solo negli spettatori, ma anche nella stessa comunità di afrodiscendenti in Italia che ha partecipato attivamente al progetto. L’esposizione diventerà, così, un luogo fisico a cui aggrapparsi per parlare di un determinato periodo storico.
Perché il titolo «Disintegrata»?
Il titolo è ispirato a una frase pronunciata da mia madre: «Un tempo sono stata integrata, adesso sono disintegrata». L’ho trovato un termine interessante per introdurre l’esperienza della diaspora africana vissuta in Italia, per mostrare la vita da migrante, una vita frammentata in diversi luoghi, spazi, contesti. Questa narrazione dialoga perfettamente con la mia poetica, con la mia visione frammentata dell’immagine, l’utilizzo di dittici e di medium diversi.
«Disintegrata» è anche una sua riflessione sul paesaggio italiano e sulla natura stessa del linguaggio fotografico…
Si, «Disintegrata» vuole essere anche una mia indagine visiva sulla presenza africana all’interno del paesaggio italiano. Per questo motivo è un progetto che trovo molto inerente al tema di Fotografia Europea sul rapporto uomo/natura e su come la natura ami nascondersi. Nel produrlo mi sono concentrata su specifiche domande: chi sono gli individui che costituiscono il paesaggio italiano, chi lo fruisce, qual è l’immaginario legato ad esso e quali individui sono lasciati fuori da questa narrazione? Usando come materiale narrativo le immagini di album di famiglia, si rivela così l’esperienza vivida della comunità di afrodiscendenti nel paesaggio italiano.
Per quanto riguarda, invece, la presenza di elementi metafotografici nelle mie immagini, come il cavo dell’autoscatto ad esempio, ci tengo a specificare che la sua presenza non è solo una manifestazione del medium e un modo per indagarne il processo, ma vuole anche far intendere che io non sono solo il soggetto dell’immagine, ma anche l’autrice. Se pensiamo alla storia della fotografia di studio dell’Africa occidentale, di derivazione coloniale, attraverso cui popolazioni indigene venivano immortalate dai coloni senza consenso, il fatto che compaia quel cavo nelle mie immagini sta a rappresentare la mia volontà di ribaltare la prospettiva, di richiamare quella memoria e ridarle nuova vita, di rivendicare l’immaginario africano.

Immagine dall’archivio © Silvia Rosi
Articoli precedenti
A Reggio Emilia, al via la XIX edizione di Fotografia Europea con il tema «La natura ama nascondersi». Ne abbiamo parlato con uno dei direttori artistici
La prima volta in Europa di «Portaits in Life and Death»
L’artista americana riporta alla luce le opere d’arte saccheggiate dai nazisti durante la seconda guerra mondiale alle famiglie ebree
Si apre l’8 marzo con un programma incentrato sulle autrici che hanno indagato il concetto di «privato»