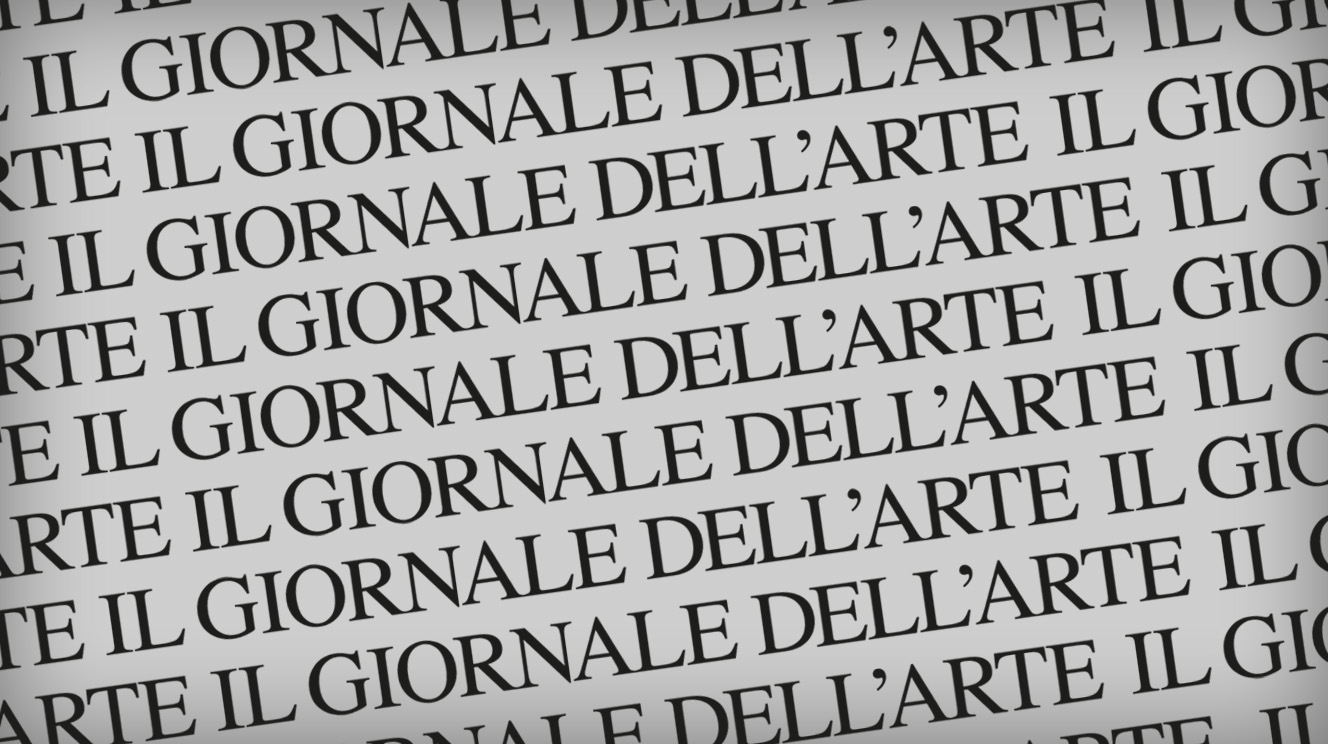Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Cristina Valota
Leggi i suoi articoliIn opposizione al soprannome, il Piccio («piccolo»), attribuitogli nell’ambiente della villa dei conti Spini, datori di lavori del padre «fontaniere», la recente rilettura della produzione pittorica (che include anche un’antologia grafica) di Giovanni Carnovali (1804-73) ha richiesto a Renzo Mangili (1948; nella foto), storico dell’arte specializzato nella pittura veneta del Settecento (in particolar modo Sebastiano Ricci) e in quella lombarda tra Sette e Ottocento, anni di studi sfociati in un monumentale catalogo promosso dalla Fondazione Giorgio Cini che ridimensiona numericamente i dipinti di mano del pittore lombardo (301 quelli riconosciuti come autografi, 473 quelli di «attribuzione sospesa o non condivisa»).
Ammesso nel 1815, appena undicenne (un anno in anticipo rispetto alla consuetudine), nelle aule dell’Accademia Carrara di Bergamo, il Piccio ha incarnato lo stereotipo dell’artista romantico (suggellato dalla tragica fine per annegamento nelle acque del Po), tanto stravangante nell’aspetto (nei molti dipinti declassati da autoritratti a ritratti compare con capelli lunghi e barba incolta) quanto «rivoluzionario» (e quindi «incompreso») nel fare artistico. Ne parla l’autore.
Colpisce la mole del volume che, come lei confida, ha richiesto oltre tre decenni di lavoro. Perché così tanto tempo?
Devo essere più preciso: sono solo otto o nove gli anni di lavoro concentrati sullo specifico, il resto se n’è andato per la necessità di chiarire genesi e contesto della vicenda del Piccio. Per cominciare, ho dovuto esplorarne la formazione, del tutto nebulosa ancora negli anni Ottanta del Novecento. Ho ricostruito le peculiarità didattiche dell’Accademia Carrara di Bergamo appena aperta, una realtà eccellente benché defilata in provincia. Ho puntato la «mano» di Giovanni Carnovali dal suo apparire, per poterla distinguere senza esitazione anche in seguito, nella confusione creatasi intorno ad essa per via della precoce moltiplicazione degli emulatori. Solo in seguito ho potuto istituire relazioni tra il Piccio e il meglio offerto dalla pittura italiana, tra l’artista lombardo e le avanguardie transalpine. Per restituire una figura quanto più possibile aderente al vero, il libro è stato così anticipato da saggi, monografie e mostre che ho dedicato a Giuseppe Diotti, primo direttore della Carrara, e ad altri artisti usciti dalla sua scuola.
Lei riconosce nel Piccio un anticipatore della «rivoluzione linguistica della seconda metà del XIX secolo». Non pensa che possa suonare come una forzatura, per un pittore che la vulgata considera «minore»?
La vulgata si è basata su un catalogo inquinato da «cadute» erroneamente addebitate al pittore e, di contro, l’enfasi sull’aspetto leggendario è l’ovvio corollario di un riconoscimento di grandezza da parte dei contemporanei. Ora, davanti al nuovissimo «puzzle» delle opere, si possono rivalutare senza pregiudizio gli aspetti tecnici, stilistici e poetici, che confermano che il pittore ripartì dalla tradizione padana cinquecentesca per mettere a punto un modo inedito di rendere la vibrazione cromatico-luminosa della realtà, in sintonia (intuitiva) con le nascenti teorie sull’ottica (specialmente francesi). Carnovali potrebbe essere considerato un precursore di alcuni versanti del Simbolismo, scavalcando, fatta salva qualche sporadica tangenza, lo stesso Impressionismo. In Italia, la sua fuga in avanti sul piano linguistico fu del tutto solitaria. Il suo rigore sperimentale lo diversificò anche da ritrattista, conferendo una forza particolare al realismo richiesto dal genere, proprio nella stagione in cui la psicologia sfuggiva al monopolio dei grandi romanzieri per farsi scienza.
Perché le sue opere sono conservate perlopiù in collezioni private italiane?
È conseguenza ritardata del comportamento umbratile del Piccio e dell’intempestività della sua epifania artistica. La critica dominante a Milano, quando il pittore tentò proprio lì la sua fortuna, fu sostanzialmente disattenta: era solidale con il resto dell’intellighenzia nel supportare poetiche più manifestamente organiche alla causa risorgimentale; non sembrava, ad essa, né tempo né luogo per squisiti esperimenti di forma e di lingua. L’innovatore romantico, a quel punto, ripiegò sdegnosamente sul consenso di una ristretta cerchia di protettori. Quando fu riscoperto dagli Scapigliati della generazione successiva, a Parigi era esploso l’Impressionismo, cui egli non poteva essere regolarmente associato. Andò a finire che le opere rimasero a lungo custodite in palazzi e ville di una classe dirigente periferica ma di cultura visiva raffinata. Le sporadiche fuoriuscite furono immediatamente assorbite da musei di vocazione civica (a titolo di donazione) o dallo scatenato collezionismo dei nuovi imprenditori dell’Italia postunitaria. Sul grande salto dell’internazionalità gravarono anche certe improprie attribuzioni, che facevano del Piccio un «artista geniale, però...».
Si può parlare di «falsari» a proposito dell’opera del Piccio?
Sì, però i surrogati risultano perlopiù penosi. Ma, torno a sottolineare, il maestro milanese fu più che altro interessato da un fenomeno di imitazione, di omaggio; nel caso del cremonese Francesco Corbari, fu oggetto di devoto vampirismo creativo.
La sezione dedicata ai dipinti indiscutibilmente di mano del Piccio è seguita dalla schedatura di opere la cui classificazione rimane «sospesa». Perché queste incertezze?
Non si tratta di irresolutezza e nemmeno dell’escamotage per indorare la pillola all’eventuale collezionista deluso. La sospensione del giudizio è d’obbligo, ad esempio, là dove l’opera censita non sia stata visionata in originale e la sua documentazione fotografica sia di qualità insufficiente alla lettura critica.
Quali pensa saranno le reazioni del mercato antiquariale alla scrematura da lei compiuta sul corpus pittorico?
L’antiquariato, non diversamente da altre attività lecitamente in bilico tra cultura e pecunia, si divide in una componente ragionevole, che accetta di agire nel rispetto degli studi specialistici quando non in sinergia con essi, e in una componente «uterina». Reazioni, di fatto, ci sono già state: diffide per raccomandata e telefonate minacciose, appena trapelato che stavo lavorando al catalogo; poi, a volume in distribuzione, un manipolo di negozianti, spalleggiato da qualche patrio «intenditore» e persino dal conservatore di una pinacoteca prestigiosa, ha tentato di screditarmi e di innescare la polemica giornalistica. Le confesso la momentanea superbia: ho pensato alla cagnara con cui venne accolto, nel 1863, il capolavoro del Piccio per la chiesa di Alzano. Lui non aprì bocca.
Piccio. Tutta la pittura e un’antologia grafica, di Renzo Mangili, 684 pp., ill., Lubrina Editore, Bergamo 2014, € 260,00
Altri articoli dell'autore
A volo d’uccello tra le eccellenze del calendario espositivo internazionale di quest’anno
Dopo 18 anni il pittore fiammingo torna nel capoluogo ligure con una mostra che tra le sue 25 opere conta due inediti e vari pezzi mai esposti prima in Italia. Finalmente svelate le identità dei potenti genovesi raffigurati
In streaming da Londra, Hong Kong e New York l'asta di Christie's del 23 marzo
Una proposta di legge per le edizioni d'arte del gallerista Mario Peliti