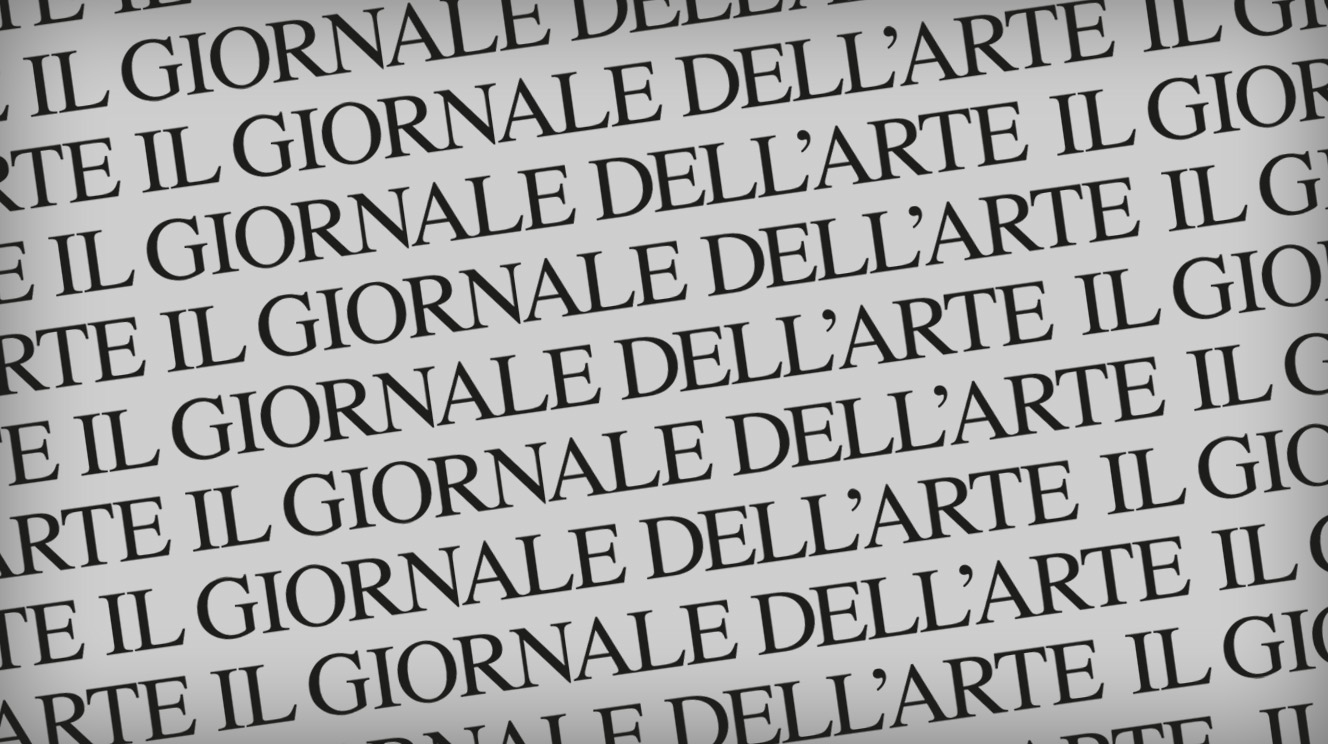Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Laura Lombardi
Leggi i suoi articoliUnione e diversità. L’Italia di Vasari nello specchio della Sistina, ultimo libro di Massimiliano Rossi, edito da Olschki, riflette, anche nel titolo, la rigorosa coerenza di ragionamento con la quale Rossi affronta e domina la varietà di una materia ricca e intricata, dove lo scenario complesso e bizzarro offerto dalla cultura del Cinquecento è indagato con profondità e chiarezza.
Il libro è articolato in quattro sezioni che si inanellano l’una nell’altra, con una prima parte costituita da due saggi di struttura speculare, dalla Sistina allo Studiolo. Rossi assegna a Vasari un ruolo cardine nel progetto di risarcimento della parete della Sistina crollata nel 1522 (là dove erano gli affreschi di Ghirlandaio e Signorelli), impresa di cui anticipa la datazione, trovandone conferma nell’emblema araldico di Paolo V e non di Gregorio XIII e vi legge un atto simbolico di carattere figurativo, che sigla l’alleanza tra il neoincoronato granduca Cosimo I de’ Medici, Pio V e Vasari. Se la Cappella Sistina rivela dunque un completamento pittorico di indiretta ispirazione vasariana in cui si misurano voleri estetici, fratture e ricomposizioni storiche e politiche, sono invece proprio le Vite ad accogliere la suggestione strutturale di quel luogo: la Sistina si configura dunque come una fonte storiografica del progetto dell’opera letteraria vasariana, la cui paternità, messa in dubbio o addirittura negata negli ultimi anni da alcuni studiosi, è per Rossi invece del tutto fuori discussione. Campo di forze che si offre a una lettura metaforica, la Sistina, già nel Dialogo di Paolo Giovio, scritto all’indomani del Sacco di Roma, è presentata quale spazio politico disgregato, poiché l’unità armonica del cielo quattrocentesco, che aveva retto con la pace di Lodi fino alla morte di Lorenzo il Magnifico, viene distrutta da Michelangelo (che Giovio chiama Ferus).
Da Roma si torna poi a Firenze, per leggere lo Studiolo di Francesco I, la cappella palatina in cui si celebra trionfalmente il culto di Francesco princeps artifex, come una Sistina profana, in cui si attua quell’estetica tra disegno e varietà, tra «unione e diversità», per dirla con Borghini. Rossi coglie i numerosi rimandi di carattere tipologico all’impresa michelangiolesca per dimostrare quanto Vincenzo Borghini (a cui non spetta l’ideazione della Vite, come alcuni vorrebbero) compia una traslazione di significati, dalle storie dell’Antico e del Nuovo Testamento presenti nella Sistina, al mito della nascita della natura e all’officina contemporanea nello Studiolo. Vasari, infatti, nell’introduzione alle teoriche della Torrentiniana del 1550 esprime proprio gli stessi concetti che saran di Borghini: «avanti che è si venga alla storia». Varietà disgregata e unità data dal disegno ritornano nella seconda parte del volume, dove Rossi segue, nelle due redazioni delle Vite, la fortuna-sfortuna critica di Rosso e di Pontormo, quest’ultimo punito da Vasari per aver osato competere con Michelangelo negli affreschi (oggi perduti) di San Lorenzo a Firenze. Per poi giungere alla poesia burlesca di Bronzino: infatti, così come la pubblicazione delle Vite giuntine viene a coronare la triplice impresa vasariana (storiografica, figurativa con la decorazione della reggia di Palazzo Vecchio e istituzionale con la fondazione dell’Accademia delle Arti del Disegno nel 1563), Bronzino salda la primazia fiorentina di lingua e pittura, indicando la Natura, «gran madre», come materia la cui forza creatrice è superiore ai limitati e fallaci mezzi dell’arte, secondo una massima ciceroniana di derivazione stoica. Pensieri che si intersecano con la disputa sul primato delle arti lanciata da Benedetto Varchi e con gli scritti di Doni, restituendo un’immagine quanto mai variegata della cultura fiorentina di quei decenni, che culmina nell’immagine lucreziana della cappella di Eleonora da Toledo in palazzo Vecchio, ultima suggestione di questo denso ma attraente percorso.
Altri articoli dell'autore
Inaugurato il tratto sul Ponte Vecchio con i ritratti di età imperiale, finora conservati nei depositi, in continuità con i marmi di Palazzo Pitti
Nel cinquantenario della sua fondazione, l’istituzione gli ha intitolato la sala dedicata all’esposizione del suo patrimonio storico
La Cappella fa parte del Complesso di Santa Maria Maddalena dei Pazzi nella cui chiesa, all’epoca dei Cistercensi, le donne erano ammesse soltanto due volte l’anno
Il moderno Opd, erede dell’omonima manifattura granducale di fine Cinquecento, compie 50 anni. La Cappella Bardi in Santa Croce è l’ultimo di una serie di restauri capitali condotti dall’istituzione attualmente diretta da Emanuela Daffra che illustra difficoltà ed eccellenze