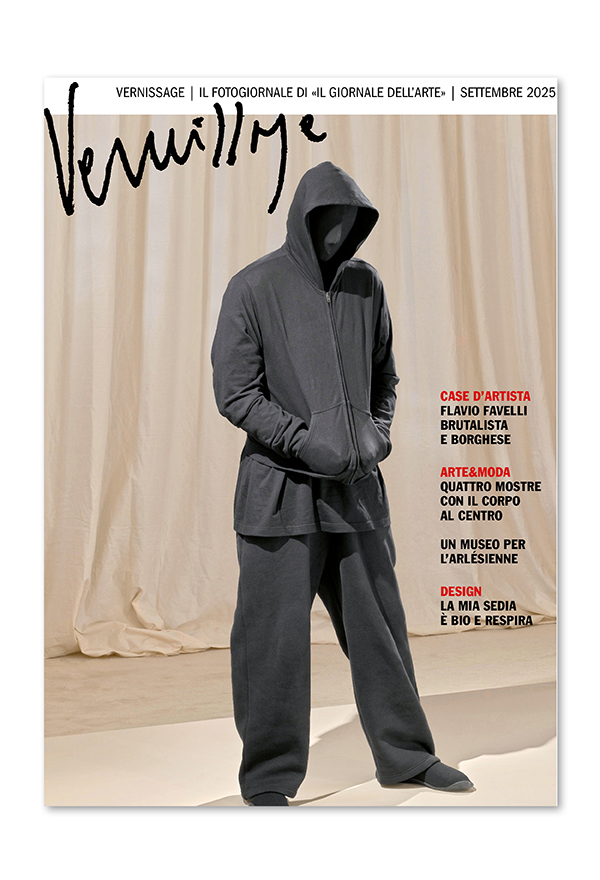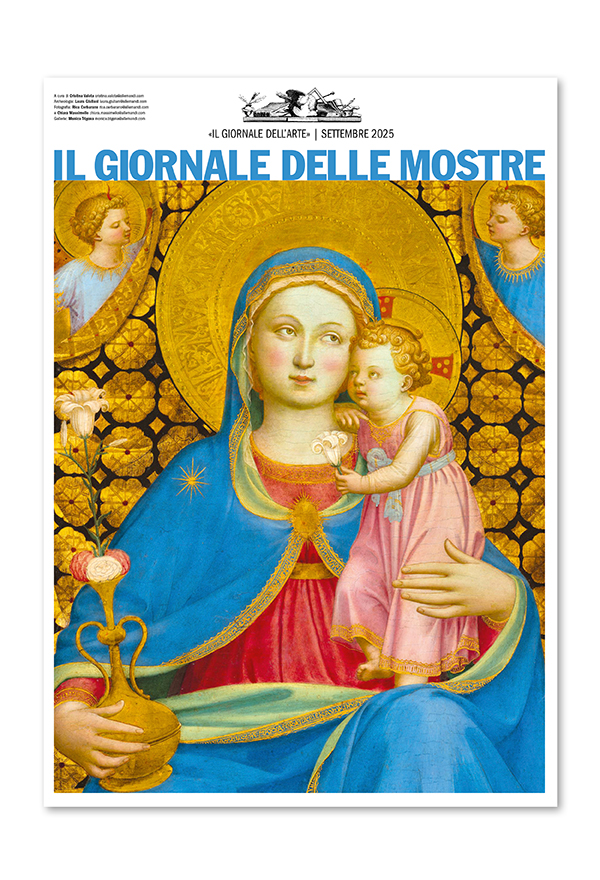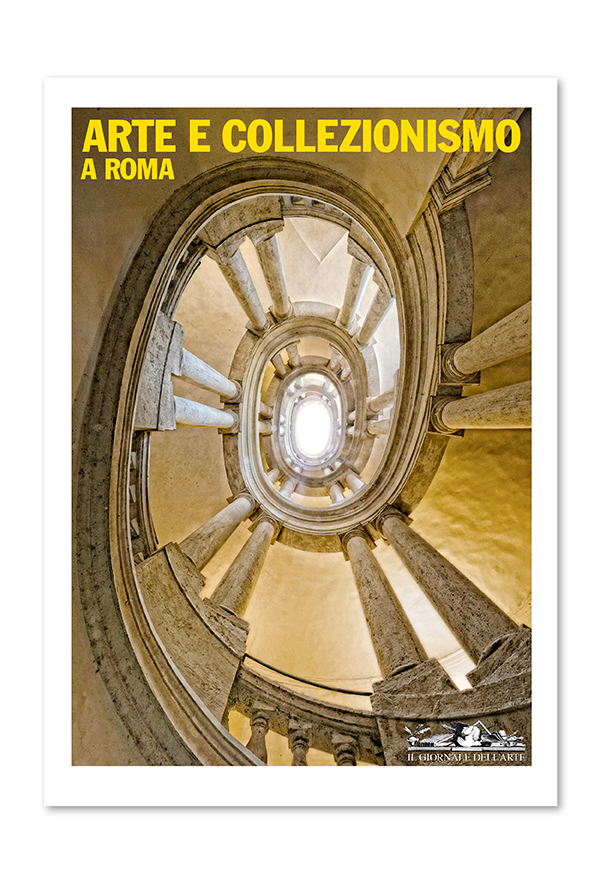Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Riccardo Deni
Leggi i suoi articoliSeparati da un secolo ma uniti da un’intensa ossessione per il corpo umano. Come luogo di tensione, verità e metamorfosi. Francis Bacon e Auguste Rodin sembrano dialogare come se appartenessero allo stesso tempo. Il primo nella carne viva della pittura, il secondo nel bronzo febbrile della scultura. Entrambi hanno indagato la vulnerabilità dell’essere con una forza senza compromessi. Non stupisce, dunque, che Bacon abbia riconosciuto in Rodin uno dei soli tre scultori veramente grandi della storia, accanto a Michelangelo e Brancusi. E che ora, in un raro accostamento sul mercato, quattro opere dei due maestri saranno protagoniste della Contemporary Evening Sale di Sotheby’s, a Londra, il 16 ottobre, durante la Frieze Week.
Provenienti da una prestigiosa collezione privata e rimaste insieme per oltre quarant’anni, si tratta due dipinti di Bacon – «Ritratto di un nano» (1975) e «Studio per autoritratto» (1980) – stimati rispettivamente fino a 9 milioni di sterline e 6 milioni di sterline, e due sculture monumentali di Rodin – «Pierre de Wissant, vêtu, Grand Modèle» e «Jean de Fiennes, vêtu, Grand Modèle» – entrambe valutate 600-900mila sterline ciascuna. I lotti saranno battuti nella stessa serata, in un dialogo incrociato che esalta la forza espressiva dei loro linguaggi divergenti e affini al tempo stesso.
Ma entriamo nel merito dei lavori. «Ritratto di un nano» è un dipinto dalla genesi insolita e dalla carica emotiva stratificata. Originariamente parte di una tela più ampia, Bacon decise di isolarne una sezione, firmandola due volte sul retro e conservandola nella propria collezione personale. Un gesto eccezionale per un artista che era solito vendere le proprie opere non appena terminate. Esposto nel 1977 alla Galerie Claude Bernard di Parigi, il dipinto rivela un Bacon nel pieno della maturità, che rielabora la pittura di Velázquez e l’eco dell’arte egizia in una figura compressa e straniante. Il soggetto – un nano – richiama non solo la tradizione pittorica spagnola ma anche la memoria personale dell’artista, forse incarnata da volti a lui cari come Peter Beard, George Dyer o Lucian Freud, in una sorta di ritratto mentale a più strati.
Accanto a questo, «Studio per autoritratto» appare come il suo controcanto emotivo. Un Bacon che si guarda con dolcezza, sfumato da una velatura azzurra che ammorbidisce la sua consueta distorsione. Realizzato nel 1980, rappresenta uno degli ultimi autoritratti dell’artista e mostra un’inconsueta tenerezza verso se stesso. “Questo è il mio periodo impressionista”, affermò Bacon, riferendosi a quel clima parigino in cui la tela fu dipinta e a quella vocazione al corpo come ricettacolo di emozioni inquiete, che condivideva con Rodin.

Francis Bacon, Study for Self-Portrait, 1980

Francis Bacon, Portrait of a Dwarf, 1975
Ed è proprio nel confronto con Rodin che le opere di Bacon rivelano nuove risonanze. I due bronzi in asta, «Pierre de Wissant, vêtu, Grand Modèle» e «Jean de Fiennes, vêtu, Grand Modèle», sono tra le figure più iconiche del gruppo scultoreo «I borghesi di Calais», una delle opere più rivoluzionarie della storia dell’arte moderna. La scultura fu commissionata a fine ottocento dalla città francese, Calais, per commemorare il sacrificio di sei cittadini durante la Guerra dei Cent’anni. Di fronte all'attacco dell’esercito inglese nel 1347, i sei uomini si offrirono volontari per consegnarsi al re Edoardo III in cambio della salvezza della popolazione. La loro vita fu infine risparmiata, ma il gesto restò impresso nella memoria collettiva come simbolo di eroismo civile.
I bronzi in asta sono fusioni postume eseguite nel 1984, sulla base di quei grandi modelli originali, cioè gessi o modelli scolpiti da Rodin stesso tra 1885 e 1886, conservati al Musée Rodin. L'artista scelse di non rappresentare gli uomini come martiri idealizzati, ma come esseri profondamente umani, attraversati dall’angoscia, dalla paura, dalla dignità e dalla rassegnazione. Invece di esaltarne il coraggio, ne scolpì il tormento interiore. Ogni figura venne concepita come un ritratto autonomo e psicologicamente complesso, carico di espressività drammatica. È questa scelta, radicale per l’epoca, a rendere Rodin così vicino a Bacon, che un secolo più tardi avrebbe ritratto volti e corpi con simile intensità emotiva e deformazione tragica.
«Pierre de Wissant, vêtu, Grand Modèle» e «Jean de Fiennes, vêtu, Grand Modèle», nelle loro versioni monumentali, condensano quella tensione fisica e spirituale che Bacon ammirava profondamente in Rodin. I volti contratti, le membra tese, il peso morale del sacrificio si traducono nella materia viva del bronzo, così come nelle pennellate febbrili di Bacon si incarnano angosce interiori e identità frantumate. Entrambi gli artisti, pur con mezzi diversi, rifiutano l’ideale classico del corpo per sostituirlo con una visione più vera, più disturbante. Ma anche più umana.

Auguste Rodin, Pierre de Wiessant, vêtu, Grand Modèle

Auguste Rodin, Jean de Fiennes, vêtu, Grand Modèle
Altri articoli dell'autore
Galleria Studio G7 di Bologna inaugura la stagione espositiva con la dodicesima personale dell'artista in galleria. Dal 30 settembre al 27 dicembre
Dal 17 settembre al 22 novembre 2025, Gagosian presenta una monografica dedicata all'artista svizzero: tra opere realizzate con la polvere e riflessioni sulla realtà
Nel 2025 e 2026, la manifestazione si prepara ad attraversare una nuova e audace fase della sua esistenza, con tre edizioni in altrettante importanti destinazioni
Milanese di origine, Fontana vive e lavora da oltre vent’anni in Belgio, dove ha costruito un solido percorso nel mercato dell’arte