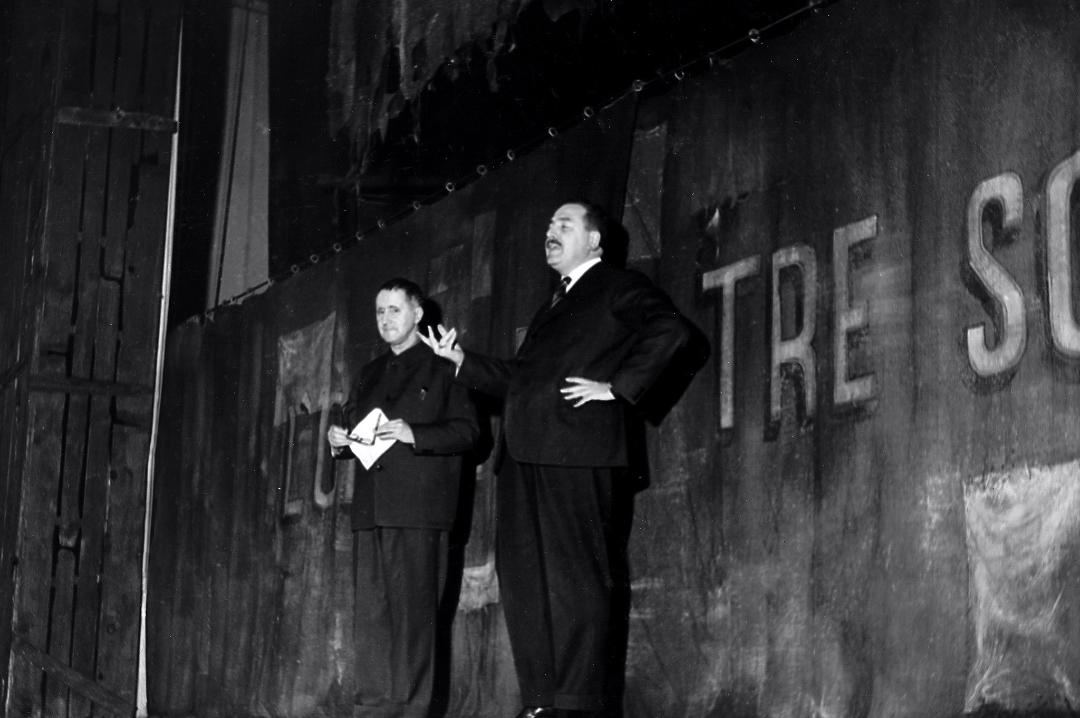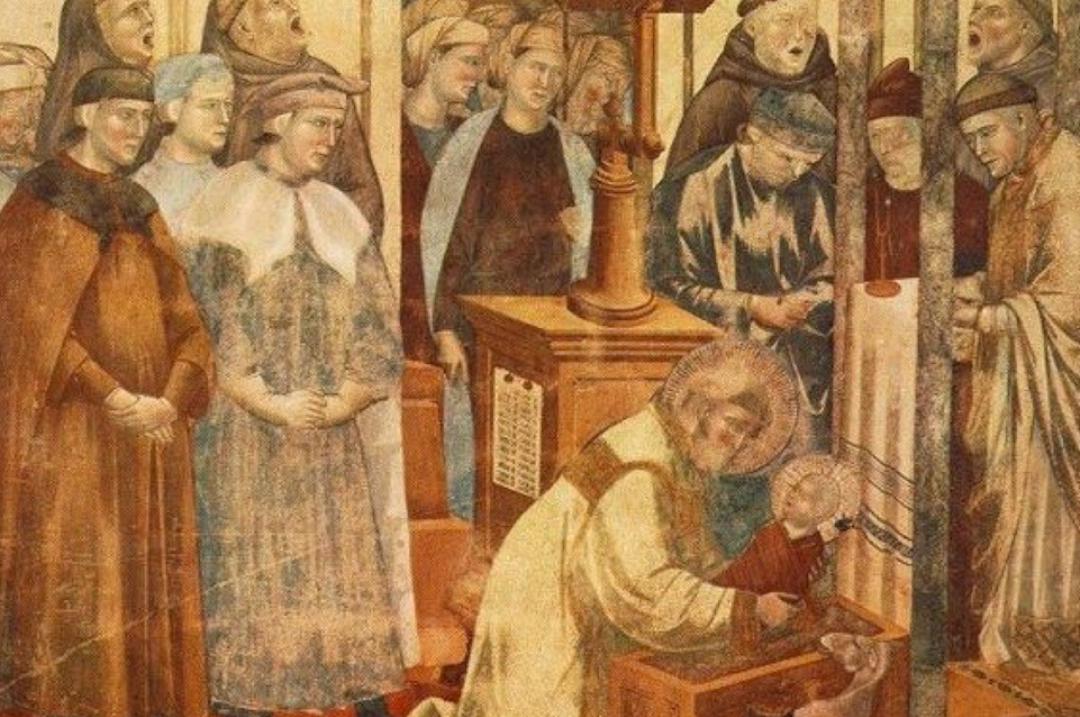Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Sergio Buttiglieri
Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI
In lui abbiamo sempre ammirato la capacità di miscelare la sua passione per la pittura con i suoi spettacoli fatti più di immagini e movimenti che di parole. Dall’esordio folgorante di «Einstein on the beach» ai più recenti passaggi in Italia come l’ultimo suo capolavoro che riuscimmo a vedere a Firenze al Teatro della Pergola. Un indimenticabile omaggio a Pessoa in prima mondiale assoluta. Ritratto da vicino di un genio che non smette mai di porsi nuove sfide.
Bob Wilson diceva di sé che avrebbe voluto essere un buon pittore, ma non lo è stato. E allora ha usato il teatro, la scena, per realizzare quadri: ogni suo allestimento è prima di tutto un disegno, gli attori e i cantanti vengono disposti proprio nel punto previsto per loro dai suoi disegni. «Per me Bob, diceva Heiner Muller, grande regista tedesco fra i più radicali, con cui Wilson in passato ha interagito, ha la stessa funzione del Cubismo nell’arte figurativa: serve da impianto di depurazione, vi si passano al setaccio i mezzi teatrali e improvvisamente prendono corpo nuove forme e nuove tecniche. Ma sarebbe da stupidi volerlo copiare, certe cose le può fare solo lui».
«Pietra miliare del teatro sperimentale mondiale», come lo ha definito il «New York Times», Bob Wilson fu scoperto in Europa nel 1976, al Festival di Avignone, con «Einstein on the beach», uno spettacolo creato in coppia con il musicista Philip Glass, una rivoluzionaria opera contemporanea. E l’Italia quella volta arrivò prima dei francesi: già nel ’74 infatti Wilson aveva debuttato al Festival dei Due Mondi di Spoleto in prima mondiale con «A letter for Queen Victoria», uno spettacolo in quattro atti contrapposti dove l’elemento guida è il tempo, e protagonista è un ragazzo autistico che Wilson era riuscito a far esprimere nella sua matematica genialità, al di fuori di ogni schema. Rivendicando così al teatro e a sé stesso una funzione maieutica e socratica; convinto, com’è, che un bambino nasce con la conoscenza dentro di sé.
E proprio di questo ci aveva parlato pochi anni fa, al Teatro Franco Parenti di Milano, in una sala strapiena, nel corso di una magnetica lectio magistralis sul suo lavoro, un teatro programmaticamente di gesti e di immagini, non testuale o di parola, un tipico prodotto della storia americana e del babilonico caos linguistico che essa ha accumulato; un frutto di questo paese di immigrati da ogni parte del mondo in cui spesso ci si comprende più facilmente per immagini che a parole.
Wilson lavora sulla saggezza essenziale della fiaba, e il «Macbeth», macchina perfetta del suo teatro (che avevamo visto a suo tempo a Reggio Emilia al Teatro Romolo Valli), lo aveva confermato ampiamente. Per la precisa gestualità, memore anche del teatro delle marionette, ad esempio nella posizione delle mani dei cantanti, sempre come appese al suo filo registico... E per la gestione del palcoscenico, completamente privo di arredi, ma colmo di luci trascoloranti, di movimenti coreografici, diviene inevitabile l’associazione al magico mondo poetico dei film di animazione di Michel Ocelot. Il suo piccolo capolavoro del 2000, «Princes et Pricesses», contiene decise assonanze con la poetica di Bob Wilson alle prese con Giuseppe Verdi mutuato da Shakespeare.
Nelle sue note di regia alla magnifica produzione del «Trovatore», che avevamo visto alcuni anni fa prima a Parma e poi al Teatro Municipale di Bologna, raccontava come in gioventù l’ultima cosa che avrebbe pensato di fare era mettere in scena Verdi. Pensiero che smentì successivamente avendo poi prodotto con successo ben quattro sue opere, realizzando come la sua musica ha un’intimità e una grande bellezza interiore che non aveva assolutamente bisogno delle stereotipate grandi produzioni, spesso inutilmente sfarzose e intrise di romanticismo.
Le sue regie ad alta densità formale si concentravano sullo spazio. Non a caso, sempre nelle sue note allo spettacolo, Wilson ci rivelava che «spesso quando vado a vedere l’opera faccio fatica ad ascoltare i cantanti o l’orchestra, gran parte di ciò che è in scena è superficiale e melodrammatico, troppo elaborato. È la costruzione tempo-spazio che mi interessa nelle opere di Verdi. Le sue opere sono molto precise, non c’è una singola parola o singola nota superflua, tutto è molto concentrato». L’apporto registico nell’opera è ancora oggi purtroppo un tabù per molti amanti della lirica, nostalgici delle produzioni sempre uguali a sé stesse. Tutto secondo loro deve rimanere immutato. E registi come Wilson danno ancora tanto fastidio.
A Reggio Emilia, pochi anni fa, lo avevamo potuto vedere anche al Teatro Ariosto, in qualità di attore, interpretare, con una scena pensata tutta in bianco e nero, ma con i suoi calzini rosso fuoco: «L’ultimo Nastro di Krapp» di Beckett. Dove, ad un certo punto, era balzato per aria folgorandoci con lo sguardo alla Jack Nicholson in «Shining», esattamente come ci aveva salutato alla fine della sua conferenza milanese, che era iniziata con lui fermo, immobile per vari minuti, in cerca del silenzio assoluto della platea. Una scena, quella per Beckett, dominata da una libreria luminosa, metafora della griglia dei nostri pensieri (che ricorda anche la libreria fuligginosa, famosa installazione di Claudio Parmiggiani), in cui lui si muove con gesti da cinema muto, ascoltando al magnetofono, sotto una pioggia scrosciante, lacerti della sua vita.
Per Wilson, che come ci raccontava lui stesso si è formato con i grandi nomi della danza americana, da Merce Cunningham a Balanchine, dentro una tradizione teatrale che non conosce le nostre forme di resistenza, è di estrema importanza la categoria «tempo», la sua relativizzazione, la scomposizione dell’attimo in secondi e millesimi di secondo; da lui si può imparare lo smembramento del teatro nei suoi elementi, l’anatomia del tempo teatrale. Il suo è stato un teatro interno alla dialettica di libertà e meccanizzazione.
Bob, questo architetto prestato alle scene, è stato accerchiato, quasi alienato dal successo, ma non ha mai smesso di farsi domande. Al contrario, il problema dei registi europei è tutto qui, fanno solamente quello che sono in grado di fare, ma questa è veramente la fine: «si può fare teatro solo tentando di realizzare quello che non si è in grado di fare», ci ricordava ancora Muller. Ed è per questo che siamo addolorati della sua scomparsa.
Altri articoli dell'autore
Affidato alla bravissima Fabrizia Sacchi, il testo di Antonio Tarantino messo in scena dal regista premio Oscar e da Stella Savino è un racconto di bassifondi e reietti. Il lamento della madre, una donna di vita, è un flusso inarrestabile di parole, feroce e lirico al tempo stesso
Nell’allestimento di Shirin Neshat dell’opera di Gluck in scena al Teatro Regio di Parma, il cantore e la ninfa sono un uomo e una donna contemporanei che vivono l’amore, il dolore e l’incomunicabilità
Al San Carlo di Napoli, e poi in tournée in varie città, gli incontri straordinari del padre del «Teatro d’arte per tutti» e la sua amicizia con Eduardo De Filippo
Il giornalista e scrittore sta portando in tour per l’Italia il suo fortunatissimo saggio sul patrono d’Italia, di cui il prossimo anno ricorrono gli 800 anni della morte