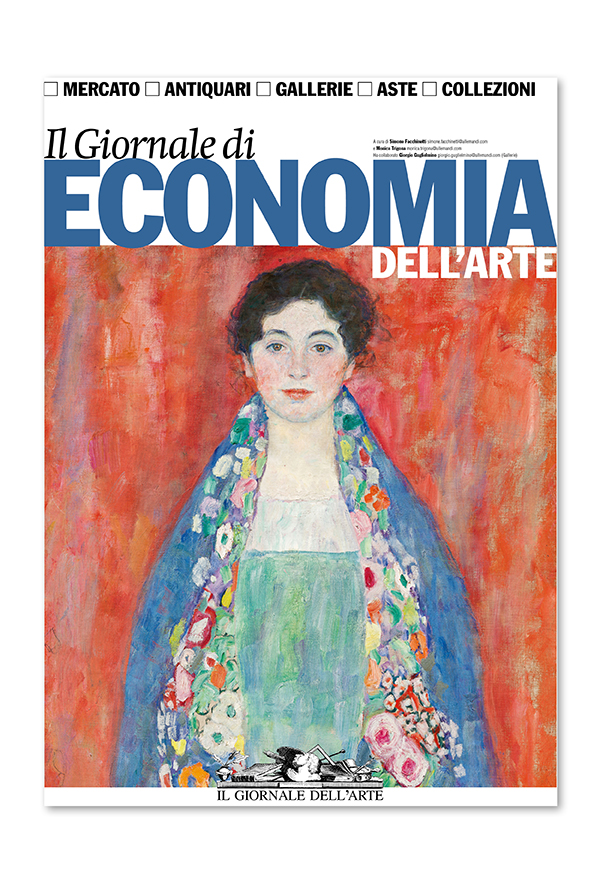Dal 27 aprile al 19 agosto la Berlinische Galerie ospita la mostra monografica «Kader Attia: J’Accuse» dell’installation-artist, fotografo e curatore francese nato nel 1970 a Dugny. Da molti anni Kader Attia esplora il principio della «riparazione» che considera una costante della natura e della storia umana. Per lui ogni sistema, ogni pratica sociale o tradizione culturale è un processo di riparazione senza fine ed è importante non rendere invisibili le ferite e le distruzioni, ma piuttosto comprenderle come punto di partenza per il rinnovamento o per una nuova esistenza, sfruttando il loro potenziale di resistenza.
Nella Berlinische Galerie l’artista franco-algerino espone due gruppi di opere, «J’Accuse» del 2016 e il più recente «The Object’s Interlacing», del 2020; a questi si aggiungono alcuni collage di Hannah Höch dall’iconica serie «Da un museo di etnografia», fotomontaggi provenienti dalla collezione dell’istituzione ospitante. La serie «J’Accuse», che dà il titolo alla mostra, è composta da 17 busti in legno, 8 sculture e un estratto di 11 minuti dell’omonimo film contro la guerra del regista francese Abel Gance (1889-1981). Il titolo rievoca naturalmente anche la famosa lettera aperta di Émile Zola apparsa nel 1898 sul giornale socialista «L’Aurore», in cui lo scrittore francese esprimeva solidarietà ad Alfred Dreyfus, capitano dello Stato Maggiore, ebreo, ingiustamente condannato nel 1894 da un tribunale militare con l’accusa, poi rivelatasi falsa, di alto tradimento. Abbiamo intervistato l’artista.
In che misura il film muto di Abel Gance, spesso descritto come pacifista, ha inciso sul progetto di questa mostra e sulle sue personali considerazioni e convinzioni sul tema della guerra e della pace?
La dimensione pacifista del film di Abel Gance mi ha ispirato molto, perché questo film del 1938 è una seconda versione del film che il regista aveva girato nel 1919, subito dopo la prima guerra mondiale. Quando il grande movimento pacifista si sviluppò in Francia, Germania, Italia, Belgio e in altri Paesi europei, gli artisti si sentirono obbligati a realizzare opere per condannare la guerra, dopo averne viste le atrocità. Quando girò il suo film, Abel Gance cercò di lavorare con veri soldati feriti della prima guerra mondiale, ma tutti rifiutarono perché traumatizzati o perché si vergognavano del loro volto. Il regista dovette quindi lavorare con attori truccati. È interessante notare che, più di un decennio dopo, Abel Gance si rese conto che stava per scoppiare la seconda guerra mondiale. Voleva mostrare al pubblico l’orrore della guerra per convincere la società a non farsi coinvolgere, e riuscì a persuadere i soldati feriti del primo conflitto mondiale dell’urgenza della questione, e quindi a partecipare a una seconda versione del film, nonostante la loro iniziale riluttanza. Ecco perché presento questa versione, in cui il regista utilizza vere «gueules cassées» (soldati della prima guerra mondiale con gravi ferite al volto, Ndr) nella scena finale. È molto importante, perché viviamo in un periodo, da circa dieci anni, in cui il nazionalismo è tornato in auge e, come diceva Jean Jaurès, «nazionalismo significa guerra di tutti contro tutti».
Qual è l’obiettivo di questo suo film?
È quello di metterci in guardia dalla banalizzazione della guerra e dei suoi orrori. La guerra è come un boomerang: quando la lanci, prima o poi ti ritorna indietro, in un modo o nell’altro. «J’Accuse» vuole ricordare al pubblico gli orrori della guerra e lo fa con un’installazione immersiva che parte dall’emozione suscitata dalle ferite sui volti scolpiti, dal silenzio delle sculture che guardano il film, dalle «gueules cassées» presenti nel film, dal personaggio che arringa la folla dicendo: «Siete pazzi a voler ricominciare una guerra». Voglio trasmettere un desiderio di pacifismo e di consapevolezza democratica, per evitare che le nostre società e i nostri governanti ci trascinino in un’altra guerra. Purtroppo, questi temi sono ancora oggi molto sentiti.

Kader Attia
C’è un riferimento al famoso editoriale di Émile Zola, apparso sul giornale socialista «L’Aurore» nel 1898, e al terribile episodio dell’Affaire Dreyfus?
In effetti, questa domanda solleva inevitabilmente la paura che dobbiamo avere della situazione attuale, in cui le guerre, fortemente legate ai nazionalismi, si moltiplicano. Quando il presidente francese François Mitterrand stava lavorando con il suo omologo tedesco Helmut Kohl per perseguire l’unità europea citò Jean Jaurès, come nella mia precedente risposta, rivolgendosi al Parlamento europeo: «Il nazionalismo è guerra. La guerra non è solo il passato, può essere il nostro futuro (...)». Questa mostra cerca di spiegare come non ci sia riparazione senza ferita. E accettare le ferite, mostrarle, fa parte non solo di un processo di catarsi, di un modo di lenire il dolore, ma anche di una consapevolezza contemporanea del rischio di violenza infinita che la guerra e i crimini di massa possono generare.
La guerra in Ucraina ha avuto un ruolo in questo suo lavoro?
Quando ho iniziato a lavorare a questo progetto, due anni fa, pensavo ovviamente alla guerra in Ucraina. L’impatto dell’invasione russa è stato molto pesante dal punto di vista psicologico in Germania, poiché il comunismo sovietico era stato impiantato nella Germania dell’Est per molto tempo. Ma oggi non possiamo parlare solo della guerra in Nagorno-Karabakh, Ucraina o Yemen, dobbiamo pensare anche a Gaza e alla situazione in cui si trova il suo popolo. Nel momento in cui le rispondo, i morti sono quasi 32mila (solo identificati). Non possiamo tralasciare questo argomento per due motivi. In primo luogo, per umanità, ed è questo l’obiettivo del mio lavoro: quando dico che non c’è riparazione senza ferita, mostro in un certo senso la vulnerabilità della vita. Inoltre, è un conflitto che ha un impatto considerevole sull’opinione pubblica mondiale perché, come possiamo vedere in Occidente, è un conflitto che polarizza sia gli intellettuali sia la popolazione in generale, sia i politici. Eppure, ogni volta che abbiamo vissuto conflitti globali, questi sono stati generati da una conflagrazione che ha diviso le società al di là dei confini del conflitto stesso.
L’arte può essere un antidoto alle guerre?
L’arte è senza dubbio l’unico luogo, l’unico spazio-tempo che permette a tutte le società umane, in tutte le loro differenze, di incontrarsi, di commuoversi, di considerare la vita non basandosi sulla forza ma sulla bellezza, sull’estetica, sull’etica, sulla libera volontà e la scelta, quella dello spettatore, di essere in grado, in un dato momento, qualunque sia il suo punto di vista politico, il suo genere, la sua religione, la sua lingua, ecc. ... di trovarsi in un’esperienza che lo sublima e che gli permette, attraverso questa sublimazione, di connettersi con altri individui che sono fondamentalmente diversi da lui. Credo che il senso dell’esperienza catartica di visitare una mostra, e in particolare un’installazione come questa, sia che c’è un cemento sociale, che io chiamo «riparazione», che lega gli individui tra loro per formare un individuo collettivo che, attraverso questo messaggio critico della guerra, spero che imparerà dai suoi errori. Purtroppo stiamo vivendo in un’epoca in cui sembra che l’umanità non abbia imparato dai propri errori, ma l’arte, attraverso le opere politicamente impegnate che cercano di portare il soggetto umano a confrontarsi con gli errori del passato, può salvare il mondo, può riparare la polarizzazione e la frammentazione della società umana.

«The Object’s Interlacing» (2020), di Kader Attia, veduta della mostra alla Kunsthaus Zürich, 2020. © Per gentile concessione dell'artista e della Galerie Nagel Draxler Berlin/ Cologne/ Munich, Foto: Franca Candrian.
Articoli precedenti
Un’artista di punta della Performance art trasforma l’Historische Halle dell’Hamburger Bahnhof in un paesaggio vivente
Nell’Haus der Kunst sei decenni di attività dell’artista tedesca
60 dipinti e 50 disegni allestiti alla Alte Nationalgalerie per la più importante mostra nell’anniversario della nascita del massimo pittore romantico tedesco
Le nuove generazioni di fotografi originari del centro America puntano l’obiettivo sul «qui ed ora»