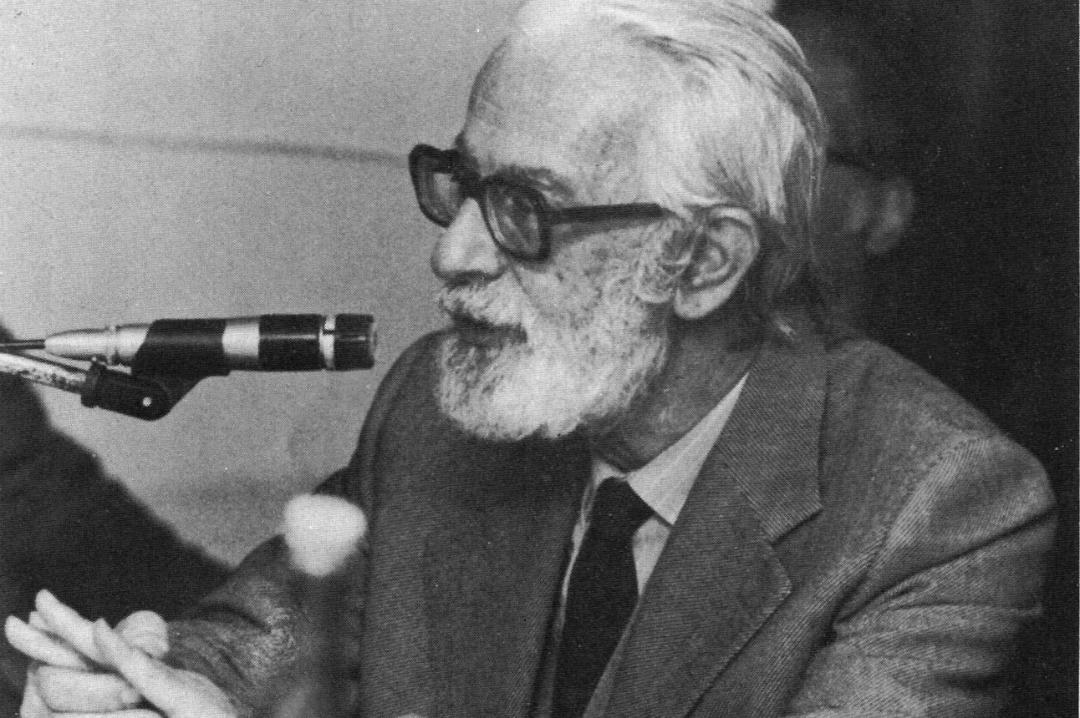Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Carlo Avvisati
Leggi i suoi articoliPompei (Napoli). Una Tac (Tomografia assiale computerizzata) per i calchi dei pompeiani uccisi dall’eruzione il 24 agosto del 79 d.C.
Le prime cinque delle 86 forme umane (di recente restaurate) ricavate facendo colare gesso liquido negli spazi lasciati tra i lapilli e la cenere dalla decomposizione dei corpi, sono entrate ieri nel tubo radiogeno allestito all’interno degli scavi, in un capannone posto di fianco all’Anfiteatro, per una analisi tomografica finalizzata a indagare gli scheletri, la loro età e le patologie di cui soffrivano in antico.
L’apparecchiatura, una Tac multistrato in grado di effettuare scansioni volumetriche total body in soli 100 secondi, è stata messa gratuitamente a disposizione della Soprintendenza archeologica speciale di Pompei dalla Philips Spa Healthcare.
Il sistema di postelaborazione dei dati, attraverso software specifici, servirà poi a
ricostruire in 3D gli scheletri. I calchi sui quali verrà fatta l’analisi saranno selezionati tra quelli che potranno entrare nel tubo radiogeno. Per gli altri verrà comunque eseguita la scansione del cranio e del torace.
A lavorare per la ricerca di patologie specifiche sui dati risultanti dalle indagini sarà una équipe formata da Giovanni Babino, responsabile della radioprotezione; Elisa Vanacore, specialista odontoiatra dell’Azienda ospedaliera di Salerno, Ruggi d’Aragona; Roberto Canigliula, referente della Philips Spa, Estelle Lazer, antropologa; e Stefano Vanacore, direttore del Laboratorio di restauro della Soprintendenza e direttore del cantiere dei calchi.
«Non ci aspettavamo, ha puntualizzato Babini, di riuscire a vedere all’interno di questi
corpi, quello che poi davvero siamo riusciti a vedere: ovvero dentature, il
cranio, gli scheletri. Ci siamo dovuti inventare e validare un
protocollo tecnico di uso dell’apparecchiatura del tutto nuovo e specifico per
queste strutture». Ma in alcuni casi si è anche scoperto che nei calchi non
c’era alcunché: la forma di gesso era vuota. «Una maniera di procedere
normale, nell’Ottocento, per gli archeologi di allora, ha specificato il soprintendente Massimo Osanna, che eliminavano le ossa perché il calco non fosse inquinato».
Anche questo risultato tuttavia ha una sua rilevanza in quanto consente di far sapere con certezza quali calchi contengano resti ossei. Così, ad esempio, si è riusciti ad
accertare che uno dei calchi eseguiti dall'inventore della tecnica, nel 1863, l'archeologo Giuseppe Fiorelli, quello della «donna incinta», in realtà non conservava alcuno scheletro
di feto.
Importante sarà anche lo studio delle dentature. «Da esse, spiega infatti Elisa Vanacore, si ricavano informazioni di grande importanza per identificare il soggetto dell’indagine. È da qui che sono emerse sia indicazioni sull’età delle vittime sia circa le abitudini e gli stili di vita, visto che sono conservati persino gli “ottavi” o “denti del giudizio” e dunque avevano una alimentazione ricca di frutta, ortaggi, verdure e pochi zuccheri. E sicuramente sono state individuate tracce di usura perché i denti sono stati anche strumenti di taglio e dunque hanno avuto delle funzioni che ne hanno causato il consumo».
I primi calchi vennero effettuati durante uno scavo di un vicolo posto tra le insulae VII, IX e VII, XIV: gli operai che stavano liberando l’area dai lapilli e dalla cenere si
imbatterono in una cavità in fondo alla quale si intravedevano delle ossa. Avvertirono subito il direttore Fiorelli che immediatamente bloccò lo scavo e dispose che attraverso alcuni fori approntati di proposito, nella buca fosse colato del gesso liquido. Poche ore dopo, quando si ritenne che il gesso si fosse asciugato, fu ripreso lo scavo e, sotto la crosta di pomici e cenere, si scoprì che le forme riprodotte era ben quattro.
Assieme alle forme umane, sono stati sottoposti a Tac anche quelle di alcuni animali. In particolare la tomografia ha interessato il calco del maialino, trovato a Villa Regina di Boscoreale, e quello del «cane alla catena», individuato nell’area sud degli scavi.
Articoli correlati:
Flebo e stampanti 3D per i calchi di Pompei
I legami tra Pompei e l'Egitto: una piramide per i calchi dei pompeiani sepolti dall'eruzione del Vesuvio

Il calco di un fanciullo

Da sinistra il soprintendente Massimo Osanna, Stefano Vanacore, responsabile del laboratorio di restauro di Pompei, l'odontoiatra Elisa Vanacore e il radiologo Giovanni Babino

I calchi del maialino e del cane

L'apparecchiatura di ultima generazione è stata messa gratuitamente a disposizione della Soprintendenza archeologica speciale di Pompei dalla Philips Spa Healthcare

Il calco di un adulto morto a Pompei nell'eruzione del Vesuvio del 24 agosto del 79 d.C.
Altri articoli dell'autore
Nel Palazzo Reale, al primo piano, si inaugura oggi la biblioteca della Soprintendenza Archeologia e Paesaggio per l’Area Metropolitana in quella che negli anni Sessanta fu la dimora del soprintendente partenopeo
Riaperta dopo vent’anni e dopo accurati interventi di restauro una delle domus più interessanti del Parco Archeologico di Pompei
Ritrovato vicino al Parco di Pompei, servirà un anno per restaurarlo
Nel portico orientale della Palestra Grande illustrato il concetto di venustas