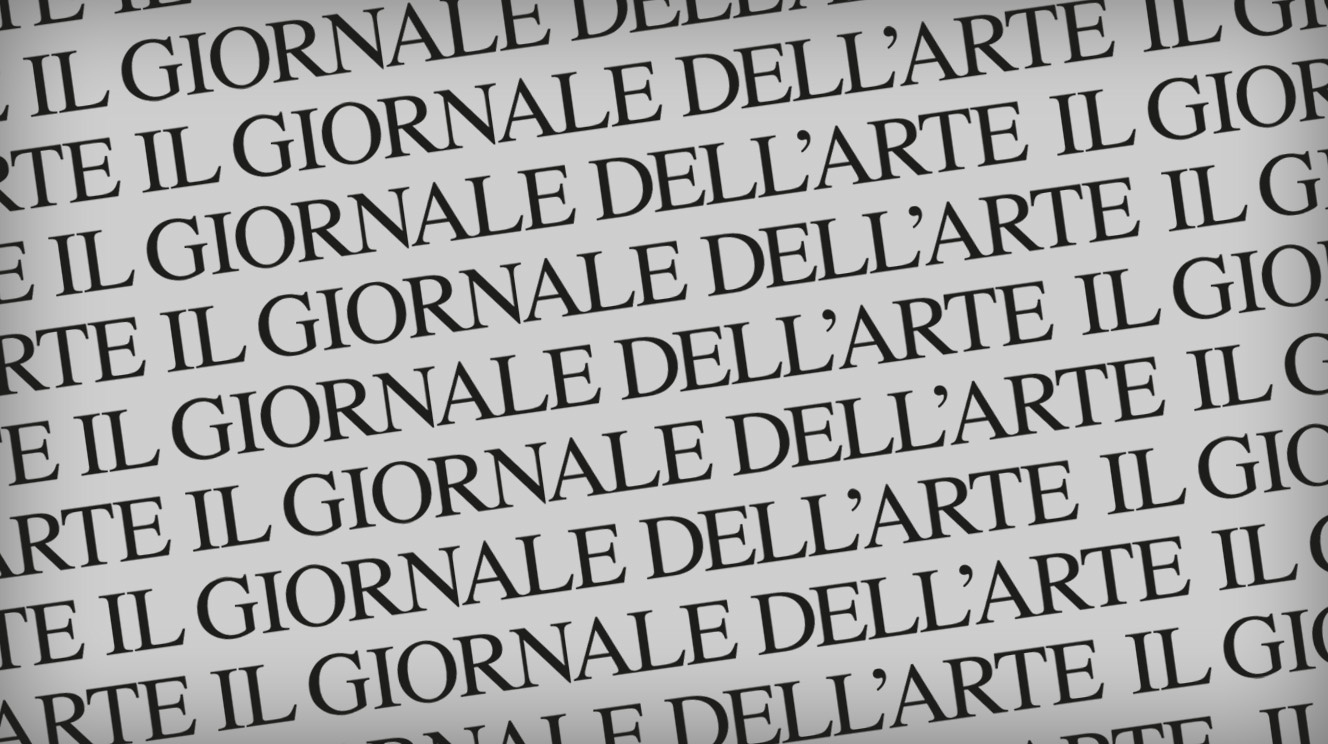Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Federico Florian
Leggi i suoi articoliL’infanzia, la guerra nell’ex Jugoslavia e la famiglia nelle opere di Petrit Halilaj: all’HangarBicocca l’autobiografia s’interseca con la macrostoria
All’HangarBicocca è allestita dal 3 dicembre al 31 marzo una mostra personale di Petrit Halilaj. Il titolo «Space Shuttle in the Garden» allude all’opera installata all’esterno, un razzo spaziale dipinto al suo interno di blu Klein, che ospita delle galline. Lo spazio all’Hangar si trasforma in un luogo incantato, abitato da una casa sospesa (quella della famiglia dell’artista a Pristina, in Kosovo), da gioielli in metallo giganteschi (quelli appartenuti alla madre), da una foresta di sculture suonabili, a forma di ocarine.
La mostra, a cura di Roberta Tenconi, raccoglie opere che raccontano ed esorcizzano un passato traumatico, quello della guerra tra Serbia e Kosovo, alla fine degli anni Novanta, in cui la biografia personale dell’artista, nato 29 anni fa, rappresenta un costante spunto creativo. Il risultato è un’arte universale, capace di parlare del passato così come del futuro, intrisa di poesia e di speranza.
Petrit Halilaj, «Space Shuttle in the Garden» è la sua prima mostra in un’istituzione italiana, se si eccettua la sua partecipazione alla Biennale di Venezia del 2013, dove ha rappresentato il Padiglione del Kosovo. Che cosa significa per lei esporre a Milano, la città dove si è formato come artista studiando in Accademia?
Si tratta, per me, di un ritorno in Italia dopo cinque anni. La mostra include lavori rivisitati appositamente per lo spazio dell’Hangar e lavori prodotti negli ultimi cinque anni. È la prima volta che posso guardare tutte queste opere esposte insieme. Nelle mie mostre, compresa questa all’Hangar, tornano spesso vecchi interessi e ossessioni. Sono curioso di vedere come le storie innescate dai lavori esposti dialoghino tra loro e che cosa comunichino oggi.
Alcune, perciò, sono opere concepite anni fa ma ripensate per la mostra milanese?
Sì. Uno di questi è il progetto che ho presentato alla Biennale di Berlino nel 2010, «The places I’m looking for, my dear, are utopian places, they are boring and I don’t know how to make them real», per cui ho ricostruito in scala reale la struttura portante della casa di famiglia a Pristina, la capitale del Kosovo. Qui a Milano l’impalcatura perde compattezza: le stanze occupano diversi livelli all’interno dello Shed. Questa nuova installazione fa da cornice ai lavori in mostra, li unifica all’interno dello spazio. Inoltre essa rispecchia la situazione attuale della mia famiglia. Ora ciascun membro della famiglia ha una propria vita e una propria casa. Si tratta di un lavoro «vecchio», la cui nuova foggia consente di inquadrare e comprendere una situazione presente.
Ci racconti di più della sua casa di Pristina.
È la casa che io e la mia famiglia abbiamo costruito dopo il conflitto tra Kosovo e Serbia. È sempre stato un desiderio dei miei genitori andare a vivere in una città più grande, con più possibilità. È un sogno che avevano sempre avuto ma che non si era mai realizzato. Nel 2010, quando Kathrin Rhomberg mi invitò a partecipare alla Biennale, ho pensato di soddisfare questo desiderio di famiglia, costruendo una casa vera e propria appena fuori Pristina e, contemporaneamente, il suo fantasma, la sua impalcatura a Berlino. L’installazione evoca un’assenza: rappresenta la casa che al tempo ancora mancava, pur essendo in fase di costruzione. È una struttura sospesa, spettrale. Quando abbiamo deciso di costruire la casa, la mia famiglia non era al corrente della mia omosessualità. Vivevo a Berlino, dove mi trasferii nel 2008, e la mia vita aveva assunto un nuovo corso. Costruire una casa insieme era forse il modo più semplice per conoscerci meglio. È stato il principio di un lungo processo di comunicazione e di avvicinamento.
I suoi lavori nascono da ricordi e memorie spesso legate alla sua infanzia e al suo Paese natale, il Kosovo. L’importanza delle sue opere sta nel fatto che conferisce forma materiale a tali ricordi, li rende universali e capaci di parlare anche del nostro presente.
Spesso leggo che il mio lavoro è connesso alla memoria, alla mia infanzia in parte trascorsa in un campo profughi in Albania. Il conflitto ha senz’altro influenzato me come individuo. Ma credo che anche le conseguenze della guerra, le trasformazioni che ad essa hanno fatto seguito, mi abbiano ugualmente influenzato. Ciò che rende speciale questa mostra è il fatto di essere in Italia, a Milano. Per me trasferirmi in Italia ha significato capire chi fossi e da dove venissi; mi ha permesso di assumere quella distanza critica che mi consente di adottare un nuovo punto di vista. Certamente i miei lavori nascono dal passato; eppure vivono nel presente e posseggono uno slancio verso il futuro. Uno dei lavori in mostra, ad esempio, è «Cleopatra», una luce il cui movimento riproduce quello degli insetti attratti da una fonte luminosa. Quest’opera è parte di un progetto più ampio sul Museo di Storia Naturale di Prihtina; è connessa in particolare alle «defunte» collezioni di insetti e farfalle del vecchio museo. Dopo la guerra, esso è stato trasformato in un museo etnologico; le collezioni naturali sono state trasferite in un deposito sotterraneo e abbandonate a se stesse. Quando andai a esplorare i depositi, mi resi conto che l’80% del materiale del vecchio museo era rovinato e non più utilizzabile. In quel preciso momento della storia del Kosovo la priorità era avere un museo che raccontasse la diversità e la specificità dei kosovari. La natura, una risorsa comune nella quale possiamo tutti identificarci, è stata messa da parte, dal momento che non raccontava alcuna diversità. Per questo, in occasione della mia mostra recente alla Bundeskunsthalle di Bonn, ho deciso di ricreare la mia personale versione del Museo di Storia Naturale di Pristina: un’installazione composta da animali scolpiti con un impasto di terra, erba ed escrementi. È stato fantastico quando, quest’anno, ho ricevuto un’email da uno studente della Università di Costanza: un team di biologi albanesi e tedeschi mi invitava a partecipare alla realizzazione di un nuovo museo di storia naturale, ora chiamato Kosovo Environmental Education and Research Center. Per tornare al mio lavoro, questo è un esempio di come la mia pratica tragga origine dal passato, in questo caso il defunto Museo di Storia Naturale, per poi condizionare concretamente la realtà presente grazie allo slancio verso un miglioramento futuro.
Uno degli aspetti più affascinanti delle sue opere sono i titoli. Sono spesso lunghe frasi in cui lei sembra rivolgersi a un interlocutore immaginario o all’opera stessa. Come nascono i suoi titoli?
Quando vivevo in Italia scrivevo molto, in particolare tra il 2007 e il 2008. Molti dei miei titoli più lunghi e complessi provengono da questi testi. È incredibile il fatto che estratti da testi scritti diversi anni fa possano adattarsi in modo così naturale a nuovi lavori. L’anno scorso ho raccolto questi scritti in un libro, accompagnati da alcuni disegni, perlopiù di uccelli (il libro è Of course blue affects my way of shitting, Chert e Motto Books, 2014, Ndr).
Si racconta un aneddoto legato alla sua infanzia. Durante la guerra in Kosovo, quando si trovava in un campo profughi in Albania, all’età di 13 anni, chiese a un volontario due matite colorate, quando a ogni ragazzo ne veniva consegnata una sola. Insistette per averne due, sostenendo di essere ambidestro e, perciò, di essere in grado di disegnare contemporaneamente con entrambe le mani. È una leggenda o è accaduto per davvero?
Accadde veramente. Il volontario in questione, cui chiesi due matite anziché una, è Giacomo Poli, un italiano di Bozzolo, in provincia di Mantova, dove ora ho il mio studio. Giacomo è la mia seconda famiglia. Nel campo profughi, tra me e lui, nacque una profondità complicità; ogni giorno mi invitava a disegnare e a dialogare con lui. Mi invitò in Italia a studiare arte nel 2004: per questo sono arrivato a Milano.
All’Accademia di Brera ha frequentato il corso di Alberto Garutti. Come ricorda quel periodo?
Mi sento estremamente fortunato a essere stato suo allievo. All’inizio, per me, le sue lezioni furono uno shock completo. Vi era un reale scambio di opinioni tra studenti e professore; ci esortava continuamente a vedere quello che succedeva nel mondo, al di fuori dall’ambiente dell’accademia. È stato un incoraggiamento straordinario.
I suoi lavori parlano spesso di casa e riportano alle sue origini. Il Kosovo, l’Italia o la Germania: quale di queste definirebbe «casa»?
La vera «casa» è quella che vive dentro di noi. È la sola che possiamo portarci dietro ovunque decidiamo di andare.
Altri articoli dell'autore
In occasione del centenario della nascita del maestro cinetico più celebre al mondo, anche un convegno internazionale, oltre a mostre in tutta Europa
La prima edizione della Triennale di arte contemporanea della città francese è un prototipo per una rassegna alternativa: attenta a una dimensione locale più che globale, nasce dal desiderio di relazionarsi attivamente e genuinamente con il tessuto urbano e la comunità dei cittadini
All’Eye Museum di Amsterdam la personale della raffinata artista e filmmaker greca
La sua prima retrospettiva istituzionale negli Stati Uniti, al MoCA di Los Angeles, è una profonda riflessione del rapporto tra verità, spettacolo e rappresentazione