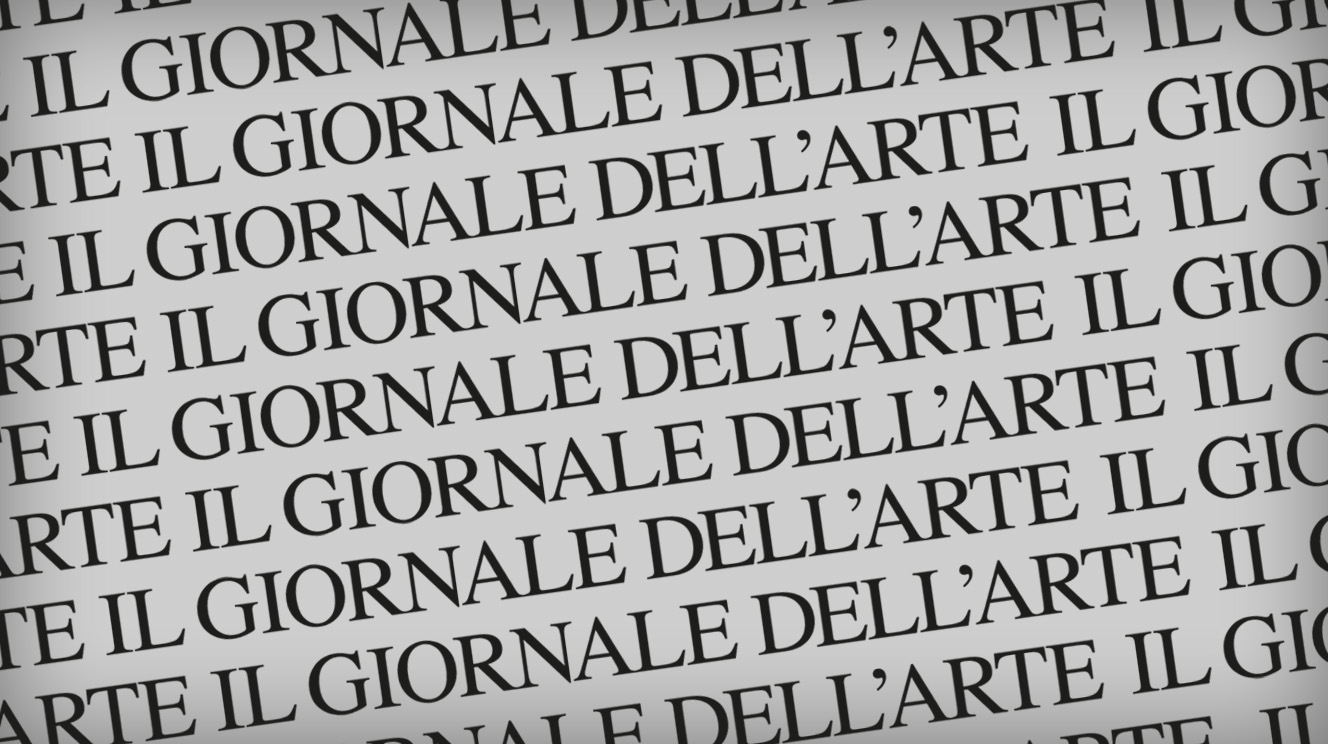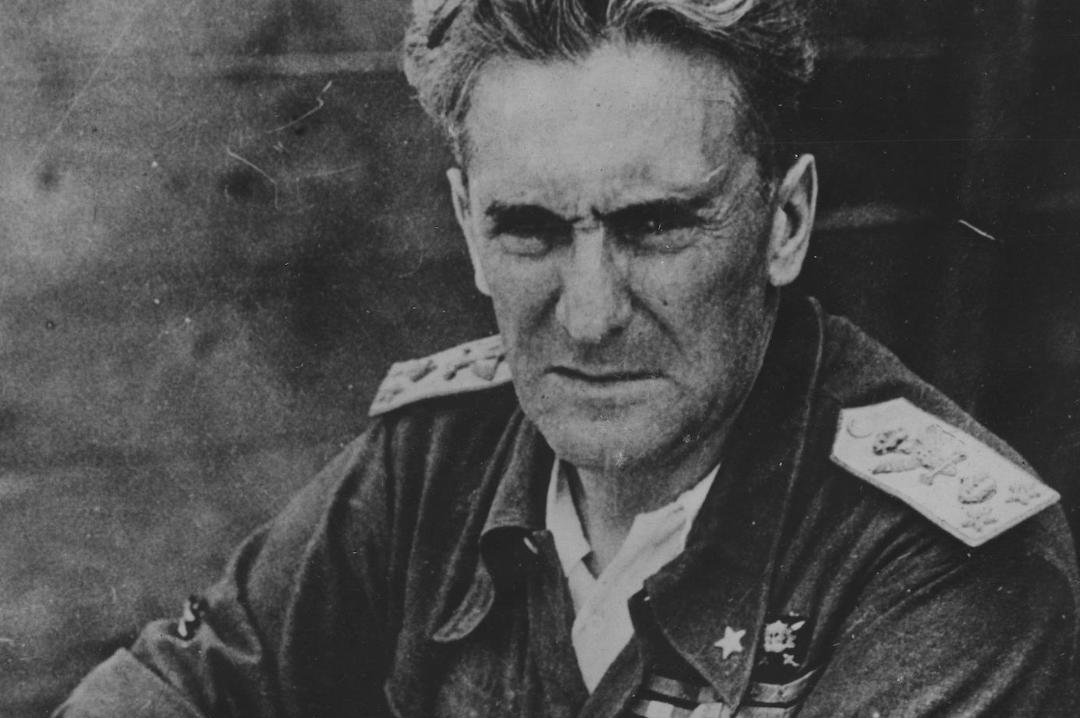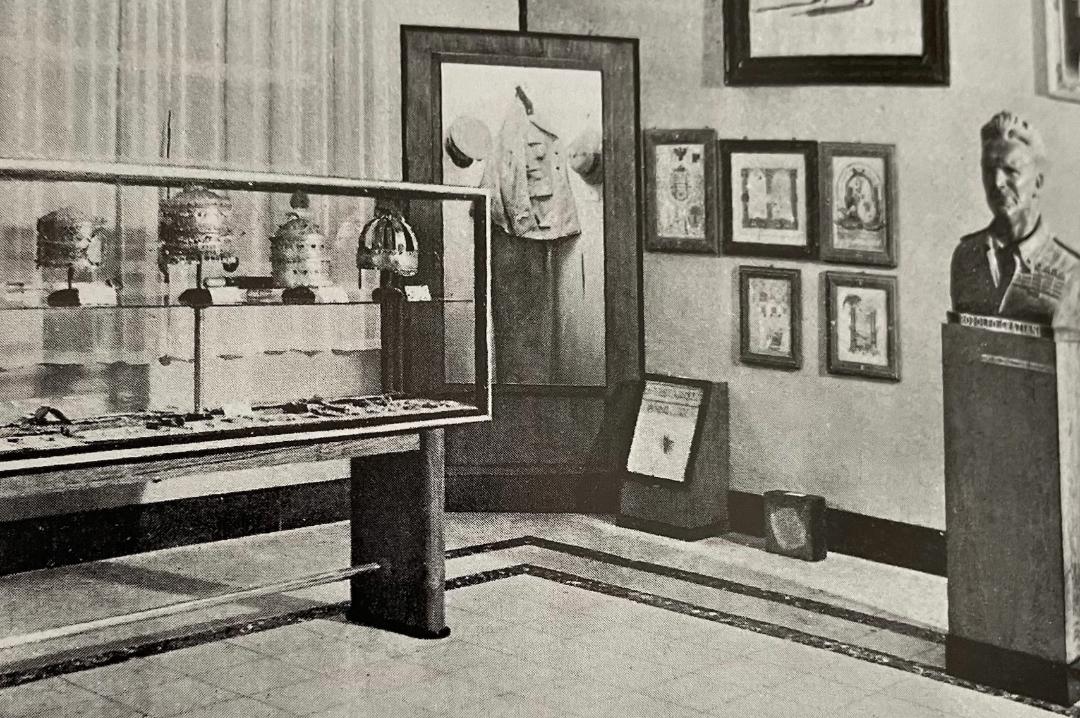Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Edek Osser
Leggi i suoi articoliRoma. Drammatiche immagini di distruzione nel Museo di Mosul, il secondo dell’Iraq, il 26 febbraio 2015. Le mazze e i martelli pneumatici dell’Isis hanno ridotto in briciole una quantità di sculture conservate nelle sale. Un colpo gravissimo al patrimonio culturale iracheno, eppure i danni potevano essere ben maggiori. L’archeologo Franco D’Agostino, docente all’Università la Sapienza di Roma, impegnato da anni in missioni di scavo nel Sud dell’Iraq, nella provincia di Nassiriya (cfr. lo scorso numero, p. 1), conferma infatti che i reperti più importanti e preziosi, da tutti i musei provinciali iracheni, erano stati messi in salvo nei depositi del Museo di Baghdad dal governo di Saddam Hussein prima della guerra del 2003. Secondo dati Unesco, dal Museo di Mosul erano stati trasferiti a Baghdad circa 1.500 oggetti, ma non quelli più ingombranti o troppo pesanti. Reperti in gran parte scavati entro le mura dell’antica Ninive, capitale assira sotto il Regno di Sennacherib (VII secolo a.C.) oggi inglobata nella città di Mosul. Nell’aprile 2003, poco dopo la caduta di Saddam, il Museo di Mosul era stato saccheggiato, distrutto e una parte di suoi tesori, tra i quali 30 pannelli di bronzo della Porta di Balawat, erano finiti all’estero. Da allora la città è insicura, tanto che il museo è interdetto anche agli studiosi stranieri. Il sopralluogo ufficiale più recente resta quello di una missione Unesco che nel 2009, dopo due brevi visite, ha redatto un report sullo stato dell’edificio (costruito nei primi anni ’70 dalla Fondazione Gulbenkian e bisognoso di interventi strutturali) e dei reperti rimasti.
Dalla relazione risulta che già nel 2009 nelle sale non rimaneva molto: c’erano ancora reperti importanti, nelle sale semivuote e nei depositi, quasi tutti dal parco archeologico degli scavi dell’antica Ninive, e parecchie copie in gesso di originali, soprattutto sculture dell’antica città di Hatra iscritta nel Patrimonio mondiale dell’Umanità (scavate da una missione dell’Università di Torino), che risalgono al primo periodo islamico, trasferiti a Baghdad. Sono chiaramente tra quelle fatte a pezzi dai miliziani dell’Isis, sbriciolate nelle cadute e sotto i colpi di martello.
Non esiste un catalogo o un inventario del patrimonio del museo. Nel report 2009 della missione Unesco, guidata da Stuart Gibson, viene però chiarito che il museo era semivuoto, lasciato alla buona volontà di un gruppo di custodi e di pochi archeologi senza compiti definiti. Il saccheggio del 2003 era avvenuto negli stessi giorni di quello di Baghdad. Dopo sei anni nulla era stato fatto e da allora tutto era rimasto com’era.
Museo e città vengono descritti dal report come «isolati dal resto dell’Iraq e dalle istituzioni museali del Paese» e così sono rimasti fino ad oggi. La mancanza di un inventario consente di immaginare anche scenari diversi da quello di una esemplare distruzione basata su principi «religiosi»: la facciata propagandistica di un’azione in difesa della «pura» fede, messa in mostra davanti al mondo dall’Isis, potrebbe nascondere un furto massiccio di quanto di prezioso restava nei depositi del museo. Dunque si tratterebbe di un definitivo saccheggio dei reperti più adatti alla vendita sul mercato clandestino internazionale. Del resto, è noto che l’Isis si finanzia anche con l’esportazione di tesori d’arte che stanno invadendo i mercati, soprattutto asiatici, in cambio di denaro e armi. Questa interpretazione non diminuisce la gravità dei danni esibiti davanti alle telecamere.
La distruzione più grave è probabilmente quella dei due tori androcefali assiri, geni protettori che sopravvivevano a guardia di una delle Porte di Ninive. Quando erano state fatte saltare alcune parti delle mura della città antica, l’archeologo Daniele Morandi Bonacossi, che in quei giorni del mese scorso era al lavoro con la sua missione dell’Università di Udine nel Kurdistan iracheno (cfr. lo scorso numero, p. 1), aveva anticipato il rischio imminente di un’azione nel museo, nelle mani dell’Isis dal giugno 2014. «Era ormai questione di tempo», conferma ora Morandi. Sono infatti arrivati gli altri assalti, alla biblioteca, a una moschea (cfr. il box a fianco) e infine al museo. Franco D’Agostino cerca di inquadrare la vicenda dal punto di vista della popolazione irachena e curda: «I locali, spiega, considerano la storia come ragione fondante della loro identità e della loro stessa esistenza. Come Roma rappresenta per noi l’unità nazionale, per loro gli Assiri al Nord, i Babilonesi al Centro e i Sumeri al Sud, li rappresentano come popolo. Sono pochi quelli che la vedono in modo diverso. Insomma, in Iraq esiste una radicata identità culturale. C’è una forte opposizione alla minoranza che si riconosce nell’Isis, anche se nell’attuale clima di guerra e di violenza ha difficoltà a emergere. E non mancano informazioni su quanto sta accadendo nelle aree del conflitto». D’Agostino spiega le distruzioni con una interpretazione estremista di alcune parti del Corano, propria della setta Salafita. Non si tratta di eliminare tutto quello che riguarda le religioni precedenti all’Islam, l’Isis distrugge tutto quello che allontana dall’unica fede e realtà che conta: Allah. Quindi le statue assire, come alcune moschee o le tombe dedicate ai diversi profeti islamici vengono considerate forme evidenti di idolatria. «Ciò che ci colpisce ancora una volta, dice D’Agostino, non è soltanto la gravità della distruzione. È sempre più chiaro che l’Isis non ha alcun rispetto per la storia delle persone e per il Paese che vorrebbe governare. Come reagire oggi: per me il modo migliore è continuare a lavorare in Iraq assieme agli iracheni, L’unica cosa che si può fare, fondamentale, è coinvolgere la popolazione locale, e anche l’Unesco lo sta facendo. La mia missione archeologica è italo-irachena, non italiana. Sono loro a voler salvare il patrimonio culturale e noi siamo lì per aiutarli a proteggere ciò che appartiene alla “loro” storia».
Altri articoli dell'autore
Nel 2015 una selezione delle opere più importanti è stata esposta in una sede provvisoria, in attesa di tornare nel Castello che ospitava l’istituzione prima del sisma
Il mausoleo dedicato al «più sanguinario assassino del colonialismo italiano» appena fuori Roma è criticato da molti, ma rimane
Si dà la precedenza agli oggetti per cui sono arrivate le richieste dagli etiopi, per ora senza grandi successi
L’eccidio e saccheggio di Debre Libanos in Etiopia fu «il più grave crimine dell’Italia». Oggi con difficoltà si cerca di rimediare all’«amnesia collettiva» che ha cancellato la memoria dell’ordine di sterminio illimitato per il quale il colonialismo italiano si macchiò dell’infamia più vergognosa. Ora si impone la complicatissima ricerca di opere e oggetti razziati o ricevuti in dono, andati dispersi. Dove sono?