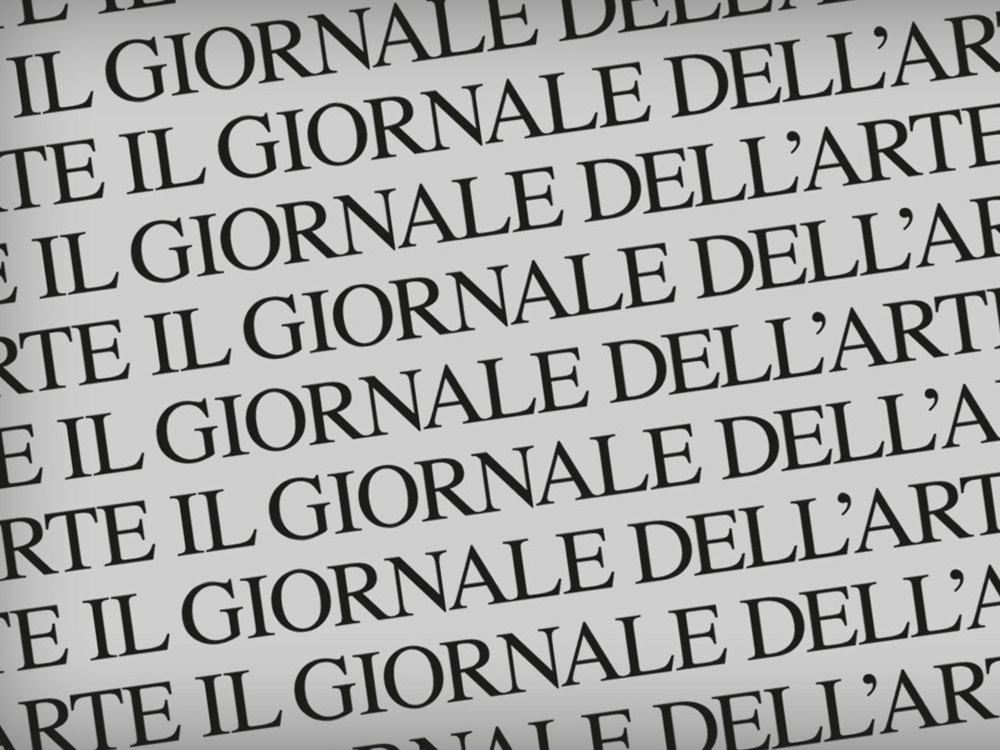Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Nicolas Ballario
Leggi i suoi articoliGiuliano Ferrara è senza ombra di dubbio uno degli uomini più discussi del giornalismo italiano. Romano, classe 1952, suo padre era senatore comunista e sua madre segretaria personale di Togliatti. Ha fatto il sessantottino, il consigliere comunale a Torino, il ministro. Ha fondato «Il Foglio» (lasciandone la direzione qualche mese fa al giovane Claudio Cerasa) e realizzato una mezza dozzina di trasmissioni tv. Dal 1987 è sposato con la critica cinematografica e scrittrice Anselma Dell’Olio: «Un amore senza riserve, afferma, una storia davvero molto bella, che ha nutrito la mia vita, e anche la sua spero».
Qualcuno lo odia perché è stato comunista, qualcuno perché è diventato anticomunista, altri lo odiano e basta. Fatto sta che ha attraversato la storia italiana offrendo il punto di vista dell’intellettuale controverso e sfrontato, che non ha paura di farsi vedere in «mutande ma vivo», con il rossetto, mentre improvvisa un rap come appello a Silvio Berlusconi. Questa non è stata l’unica performance musicale di Ferrara: nel 1967 ha cantato in un’opera rock, e questa è la prima cosa che gli chiediamo quando lo raggiungiamo nel suo ufficio sul Lungotevere.
È vero, al Piper. Successe che Tito Schipa Jr decise, con un americano che si chiama Mario Faves, di fare un’opera beat su testi e musica di Bob Dylan. Io ero noto come cultore di Dylan, come conoscitore delle sue canzoni, e quindi mi chiamò. Avevo 15 anni e fu poco più che una comparsata, anche se il Piper Club era molto in voga all’epoca.
È questa la sua musica?
Beh, Bob Dylan l’ho ascoltato fino allo stremo per alcuni decenni e l’ho imparato quasi tutto a memoria. Poi ho smesso, ma naturalmente se capita lo ascolto. Mi interessa seguire che cosa fa e lo considero un mostro sacro, come i Beatles e gli Stones. Dopodiché ho saltato tutta quella musica degli anni ’70 che ha preparato un futuro che ha fatto a meno di loro.
Per mantenere intatto il ricordo?
No, in realtà l’ho saltata perché avevo molto da fare. Poi mi sono molto appassionato alla musica del ’700, dell’800 e dei primi del ’900.
Parliamo di arte visiva invece. Chi salva di quella generazione, dell’età di Dylan o Jagger?
Kiefer mi sembra importante. Ho visto una sua bellissima mostra a Parigi di recente, al Centre Pompidou. Con un finale sorprendente.
E delle «superstar» dell’arte contemporanea che ne pensa?
Si riferisce ad artisti come Hirst o Koons? Non mi interessano. Cioè, capisco che la performance sia una forma d’arte e capisco persino il senso di questo artigianato esplosivo e un po’ folle, alla Hirst per intenderci. Ma d’altronde tutto ha un senso. Pure la «Merda d’artista» ha un senso. Però poi è in Picasso che vedi un talento pazzo, che ha dentro persino il folklore, che ha dentro una sensualità irriducibile. Poi tante altre cose sono prese da modelli di arti primitive, africane, che mi interessano meno.
Qui sotto il suo ufficio c’è l’enorme opera di Kentridge, che ha creato scompiglio nell’estate romana del Lungotevere, quando le bancarelle volevano invaderlo e coprirlo.
Il Lungotevere per me è off limits. Da quando i piemontesi hanno costruito questi benedetti argini, che ci consentono di non tenere i piedi a mollo ogni autunno e ogni primavera, ogni tanto salta fuori qualcuno che vuole riqualificare il Tevere. Ma che vogliono riqualificare? È un bellissimo fiume, d’oro, che scorre tra i muraglioni, ma ne è impossibile qualunque fruizione.
Qual è la politica culturale che Roma dovrebbe adottare?
Roma non ha bisogno di politica culturale. Anzi a Roma potrebbero abolire tranquillamente persino la carica di sindaco, finita oggi nelle mani peggiori del mondo, e fare com’è stato a Parigi prima di Chirac. Dopodiché avrebbe bisogno di un impegno dell’esecutivo. Roma non ha il senso della comunità, non si individua come Città. Le case dentro sono tutte pulite e fuori è tutto sporco. Al contrario di quello che accade nei Paesi nordici, dove fuori è tutto pulito e dentro è sporco. Roma è un’eternità, un’immagine mobile del tempo. E quindi non c’è niente da fare.
Siamo ancora il Bel Paese?
Sì, siamo il più bel Paese del mondo, indiscutibilmente. Però non dobbiamo avere paura. Una volta mi chiesero un parere sui rischi dei grandi eventi, come l’Expo o le Olimpiadi, e io risposi che le città sono fatte per essere calpestate. Devono sopportare il fiato dell’umanità e anche il suo peso. Mi rendo conto che conservare e preservare è importante, ma andrebbe fatto senza quello spirito follemente tecnico che ogni tanto prende il sopravvento. Prenda Pompei: è evidente che sia una città calpestata dal tempo, dagli eventi, dalla lava, dalla pioggia. Non sarà mai la stessa. E non possono metterla sotto una teca. Sono troppi ettari. Voglio dire: se tagliano la Fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona io piango. Però può succedere, perché nel frattempo centinaia di milioni di turisti l’hanno vista.
Troppi?
Non lo so, ma mi chiedo: l’hanno saputa apprezzare? Io su questo sono snob. Detesto il turismo con lo zainetto che guarda le cose ovvie. Però penso che alla fine i diritti della soldataglia, delle ciurme, del cittadino globale, delle masse, dei giapponesi con le loro orrende Rolleiflex o coi telefonini, siano diritti imprescrittibili.
Che cosa pensa di Franceschini?
Lo apprezzo. Perché è un politico che si è silenziato, anche se pare che nell’ombra lavori molto, per mettersi a fare questo mestiere di Ministro della Cultura con una certa sobrietà, con capacità di realizzare. Ho trovato notevole, ad esempio, la sua scelta di personaggi di scuola europea per la guida dei Musei e dei complessi archeologici più importanti, e spero che funzioni. Non per esterofilia, perché è evidente che si potessero scegliere anche persone che stavano all’interno dell’establishment dell’arte italiana e della cultura conservativa. Però uno shock ci voleva, perché l’andazzo era diventato insostenibile. Una classe dirigente di funzionari e soprintendenti, anche bravi, va stimolata, al di là delle qualità personali di ciascuno. Ho conosciuto Gabriel Zuchtriegel, il nuovo direttore del Parco archeologico di Paestum. Questa idea di dare tutto in mano ai tedeschi (ride, Ndr) non è mica male.
Una volta era la Chiesa a dettare le regole del bello. Ora chi le detta?
La Chiesa è passata dal Giudizio Universale al souvenir. È vero che non detta più le regole del bello, ma la verità è che non le detta più nessuno. Anche se qualche chiesa moderna non è male.
Per esempio?
Quella di Fuksas a Foligno a me piace. Per questo sono sempre in polemica con il mio amico Camillo Langone che la detesta, e anche con il mio amico Roger Scruton che sostiene che l’architettura contemporanea è la prima vera negazione diabolica. A me non dispiace, forse perché ho anche un fondo un po’ protestante e mi piacciono queste chiese con poca sofferenza, con poca crocifissione, con poca passione. Penso che poi possano essere riempite di un contenuto importante, anche in questa loro evidente iconoclastia.
Oggi eretici e profeti si confondono?
Sì, perché non c’è un’ortodossia e quindi non c’è l’eresia. Forse ancora si conserva qualcosa di profetico nelle grandi religioni monoteiste. Certamente nell’Islam, sicuramente nell’Ebraismo e forse nel Cristianesimo. Il papa dice «il tempo è superiore allo spazio» e questo dovrebbe dare adito alla possibilità del profetico.
Lei nello stesso giornale ha dato parola a Oriana Fallaci e Adriano Sofri, Camillo Langone e Pietrangelo Buttafuoco e molti altri. Personaggi non facili hanno scritto sulle sue pagine e molti elementi di contraddizione sono stati ospitati. Si sente un po’ eretico?
Mi sento, banalmente, liberale. Io ho fatto un giornale secondo i miei umori, le mie amicizie, e mi sono attenuto alla regola di Arrigo Benedetti, che è stato il promotore di un giornalismo niente male, da «L’Europeo» a «L’Espresso». Una regola che sarebbe potuta essere anche scritta da Longanesi e che vale sempre: se una cosa è scritta bene, se ha una forma preziosa e se esprime un punto di vista sufficientemente radicale per attrarre un’attenzione non devota, ma un’attenzione vivace e reattiva e colta da parte del lettore, va pubblicata. E io aggiungo una cosa, perché non mi prendo troppo sul serio, non me la tiro e non vorrei avere sviato l’intervista con le citazioni di Benedetti e Longanesi: direi che un giornale deve anche pubblicare delle stronzate. Quando capitava, lo dicevo in redazione: «È un pezzo inutile, anzi è disutile. Ma un giornale che esce senza almeno una stronzata non è un vero giornale».
Altri articoli dell'autore
Dai nostri archivi: un’intervista al fotografo milanese recentemente scomparso pubblicata in «Vernissage» nel numero di ottobre 2015
Nati o attivi in Italia, sono aperti al mondo, detestano le classifiche e fanno sistema tra loro: ecco i giovani protagonisti di oggi. La scommessa è capire se tra dieci o vent’anni camperanno ancora d’arte
Scomparsa a Milano all’età di 92 anni la fondatrice dello studio Ballo+Ballo che con i suoi still life ha creato un linguaggio nuovo apprezzato da Mari, Castiglioni, Gio Ponti, Sottsass, Olivetti...
Nicolas Ballario difende la scelta del Museo diretto da Carolyn Christov-Bakargiev di acquistare ad Artissima una tela del giovane Pietro Moretti: «È il lavoro che conta, non il nome. E lui è un bravo artista»