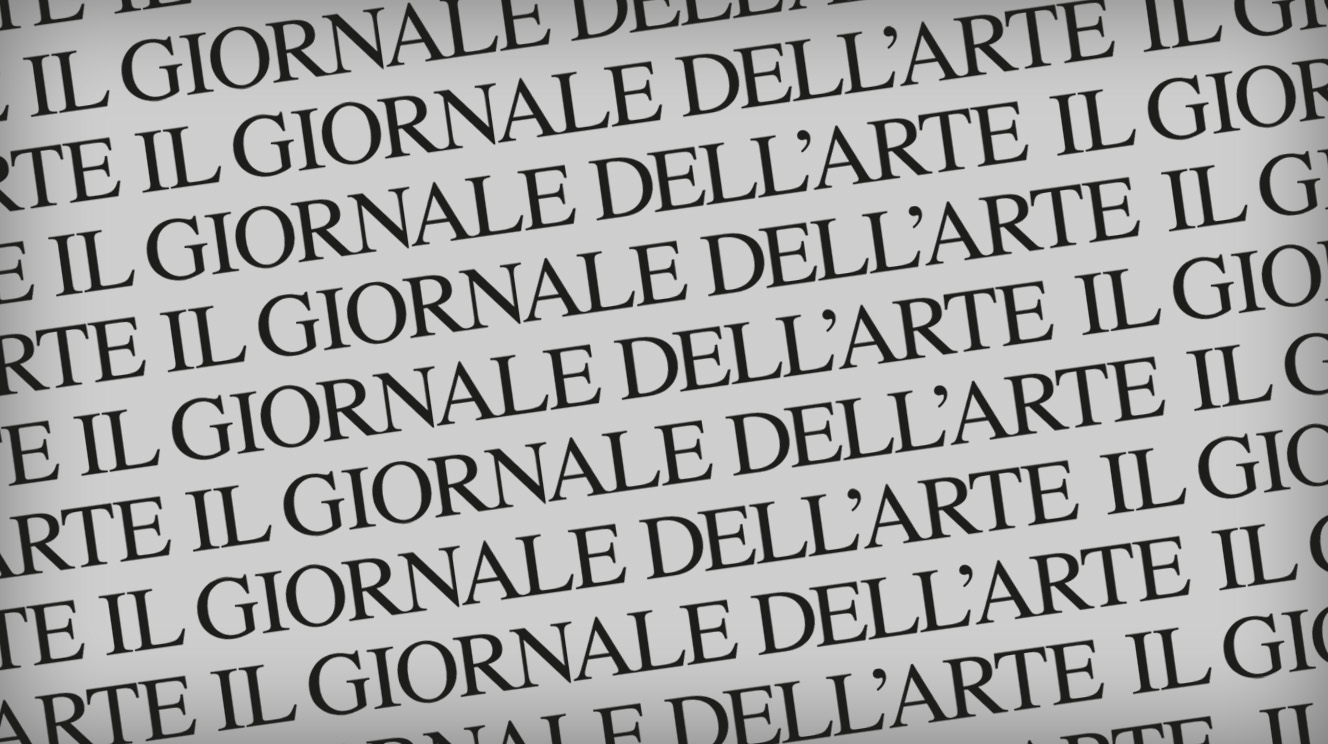Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Laura Lombardi
Leggi i suoi articoliTra le più importanti e prestigiose aggregazioni laicali fiorentine, con sede dal 1383 nel convento domenicano di Santa Maria Novella, la Compagnia di San Benedetto Bianco, estinguendosi dopo alterne vicende, cedette il suo ricco patrimonio artistico alla Curia arcivescovile di Firenze, ora in deposito nel Seminario arcivescovile di Cestello.
La mostra «Il rigore e la grazia», alla Cappella Palatina di Palazzo Pitti nel Museo degli Argenti fino al 17 maggio e a cura di Alessandro Grassi, Michel Scipioni, Giovanni Serafini (catalogo Sillabe), è l’occasione per riscoprire un nucleo di opere quasi interamente proveniente dal patrimonio della Compagnia, donate dai suoi stessi membri, tra cui componenti della famiglia dei Medici, oltre a teologi, filosofi, letterati, scienziati e numerosi pittori.
Sono proprio questi ultimi a tradurre in un linguaggio molto suasivo, che puntava sulla immedesimazione del fedele con gli affetti e i sentimenti di chi fu presente alla passione come la Vergine, san Giovanni o lo stesso Gesù, una spiritualità penitente, tutta concentrata sul sacrificio di Cristo, sommo modello di elevazione spirituale da meditare attraverso penitenze anche corporali (per cui ad esempio la «Flagellazione di Cristo», dipinta da Agostino Melissi nel 1653, era da intendersi in rapporto con l’autofustigazione) e visualizzazioni interiori.
Le tele degli artisti, massimi rappresentanti della scena fiorentina intorno alla metà del Seicento, raffigurano infatti tutti temi legati alla Passione (tra gli altri, Vincenzo Dandini, Matteo Rosselli, Carlo Dolci e il Volterrano).
Ma vi è soprattutto il ciclo unico di otto tele a soggetto biblico dipinte per l’abitazione del confratello Gabriello Zuti, lasciate a San Benedetto Bianco alla morte nel 1680. I soggetti, tratti dal Vecchio Testamento, sono riferiti alla vita familiare del committente, segnata dalla peste del 1630: «Giacobbe ed Esaù» di Lorenzo Lippi, «Giaele e Sisara» di Ottavio Vannini, «Ritrovamento di Mosè» di Jacopo Vignali, «Geroboamo e il profeta Achia» di Vincenzo Dandini, «Ripudio di Agar» di Giovanni Martinelli, «Guarigione di Tobia» di Mario Balassi, «Susanna e i vecchioni» di Agostino Melissi e «Lot e le figlie» di Simone Pignoni.
Senza dimenticare le due tavole di Cristofano Allori, «San Benedetto» e «San Giuliano», alluvionate e restaurate, forse parte della pala che schermava le reliquie nell’enorme altare reliquiario della Compagnia, scenografica macchina per l’ostensione.
Altri articoli dell'autore
Un’intera sala è dedicata al massimo scultore in cera attivo nel capoluogo toscano a fine Seicento: Gaetano Giulio Zumbo
La mostra a Pisa curata da Francesca Dini ripercorre lo sfavillante periodo, a fine Ottocento, in cui Parigi era il centro culturale del mondo. E tra i protagonisti di quel nuovo clima, gli artisti italiani che scelsero la capitale francese come patria d’adozione, tra cui Boldini, De Nittis e Corcos
Nel bicentenario della nascita, i suoi dipinti sono messi a confronto con quelli di altri protagonisti della pittura del Risorgimento, da Giovanni Fattori a Silvestro Lega e Telemaco Signorini
È stata inaugurata la mostra «Icone di potere e bellezza» con le tre teste in bronzo dorato del Museo di Santa Giulia a Brescia, secondo capitolo dello scambio di manufatti tra le due istituzioni gestito da Fondazione Brescia Musei