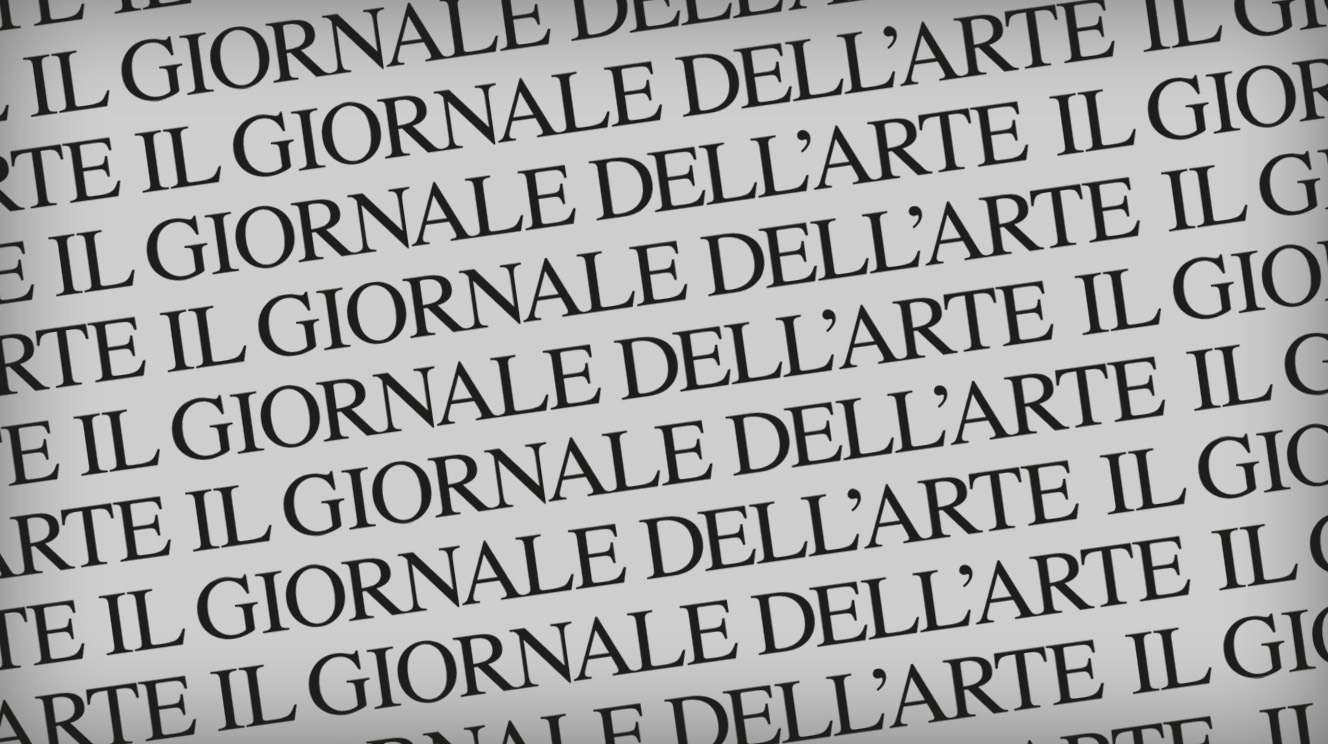Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Federico Florian
Leggi i suoi articoliIn una recente intervista con Ben Eastham, Philippe Parreno (1964; nella foto) ha dichiarato: «Tempo fa avrei preferito essere definito uno scrittore o qualcosa di simile. Allora, associavo la figura dell’“artista” a un tipo vestito di nero, con i capelli lunghi, che faceva dipinti davvero brutti e sniffava colla. Mi piaceva l’idea della colla ma non quella dei capelli lunghi, dato che non me ne erano rimasti molti».
Se l’artista francese non si può definire scrittore in senso stretto (e sicuramente l’ironia della sua conversazione avrebbe reso esilaranti i suoi romanzi), lo si può tuttavia descrivere come un narratore in senso lato: un «romanziere» che, al posto delle parole, dispone le immagini una dopo l’altra, trasformando l’esperienza del visitatore in un percorso costruito lungo un filo narrativo palese e latente allo stesso tempo.
Un racconto, quello attivato nelle mostre di Parreno, che, come ha sottolineato una volta Nancy Spector, curatrice del Guggenheim Museum di New York, è «pura potenzialità, privo di una reale risoluzione». L’artista, non a caso, è solito ribadire che una mostra è «uno spazio che si dispiega nel tempo»: l’apparato dell’esposizione (concepita più come un tutto che come una collezione di singoli lavori) traduce la processualità del racconto narrativo in video, sculture e installazioni.
Oltre che a romanzi, si può pensare alle mostre di Parreno come a dispositivi simili a una partitura per pianoforte: un crescendo piuttosto coerente di accordi, ma a tratti spezzato da drammatici stridii di violino e mai risolto in una chiusura definitiva.
HangarBicocca, dal 22 ottobre al 14 febbraio, ospita un suo nuovo «racconto-partitura-mostra». L’esposizione, dal titolo «Hypothesis», è la sua prima antologica in Italia.
«Lo spazio di Hangar raccoglie lavori preesistenti ma riassemblati in una nuova foggia, così da creare un’unica, inedita ed effimera installazione temporanea», afferma il curatore Andrea Lissoni. L’ipotesi cui si riferisce il titolo, continua, «è quella di un progetto espositivo inteso come esperienza temporale»: di nuovo, una narrazione-sinfonia che si sviluppa nel tempo della fruizione.
Il profilo di una pista da ballo bianca e circolare, parzialmente oscurato da una parete curva rotante, accoglie il visitatore che entra nelle navate del vecchio Hangar. Si tratta di «How Can We Know the Dancer from the Dance», una nota opera del 2013, qui rivisitata per l’appuntamento milanese: la pista pare abitata da danzatori invisibili, dei quali il visitatore può sentire soltanto i passi (diffusi da un altoparlante) mentre eseguono una coreografia di Merce Cunningham; occupa il centro della piattaforma «Set elements for “Walkaround Time”», elemento di scena realizzato da Jasper Johns per una performance di Cunningham del ’68, e composto da cuscini gonfiabili in plastica decorati con iconografie duchampiane.
Fulcro della mostra è una «über-installazione» luminosa, costituita da un sole artificiale che si sposta lungo binari sospesi simulando il passaggio dall’alba al tramonto («Another Day with Another Sun», 2014, realizzata in collaborazione con Liam Gillick) e da una serie di «Marquees», sfavillanti sculture intermittenti ispirate alle insegne cinematografiche degli anni Cinquanta.
Stimoli visivi e uditivi pervadono gli spazi dell’Hangar: fanno da accompagnamento alle «Marquees» composizioni musicali scritte, tra gli altri, dal Thomas Bartlett di Antony & the Johnsons, Nicolas Becker e Robert AA Lowe, mentre l’area del cubo, in cui è installato un sistema di tende mobili, ospita alcuni video dell’artista, tra cui «Marilyn» (2012), una commovente soggettiva di Marylin Monroe nella propria suite all’hotel Waldorf Astoria di New York, e il più recente «The Crowd» (2015), ambientato nella Drill Hall della Park Avenue Armory.
La teatralità dell’impianto espositivo, tipica della pratica di Parreno, s’incontra con l’esperienza del tempo, vissuta in prima persona dal visitatore: il trascorrere delle ore, scandite dalla rotta del sole artificiale e dall’andatura intermittente delle «Marquees», ritma il tempo della narrazione, in una parabola di climax, picchi drammatici e progressioni discendenti sapientemente orchestrata.
Altri articoli dell'autore
In occasione del centenario della nascita del maestro cinetico più celebre al mondo, anche un convegno internazionale, oltre a mostre in tutta Europa
La prima edizione della Triennale di arte contemporanea della città francese è un prototipo per una rassegna alternativa: attenta a una dimensione locale più che globale, nasce dal desiderio di relazionarsi attivamente e genuinamente con il tessuto urbano e la comunità dei cittadini
All’Eye Museum di Amsterdam la personale della raffinata artista e filmmaker greca
La sua prima retrospettiva istituzionale negli Stati Uniti, al MoCA di Los Angeles, è una profonda riflessione del rapporto tra verità, spettacolo e rappresentazione