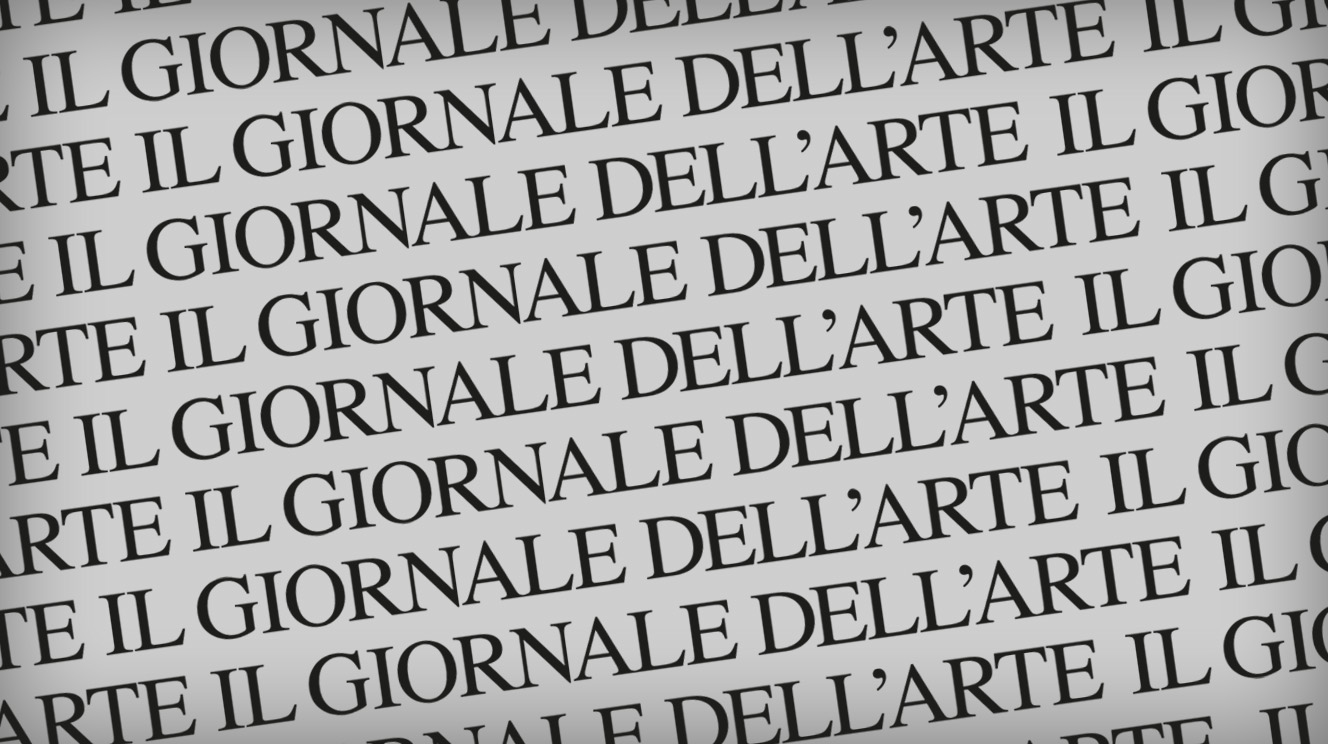Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Federico Castelli Gattinara
Leggi i suoi articoliDa quattro mesi Vittorio Sgarbi (Ferrara, 1952) risiede a Roma in un appartamento degno della fama di chi lo abita: dalle tre terrazze che lo circondano si possono ammirare a distanza ravvicinata la Basilica di Sant’Andrea della Valle, la cupola del Pantheon e il famoso lanternino cuspidato a forma di spirale della Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza di Borromini. È quindi il luogo ideale per conservare parte della bella e affollata collezione che lo storico dell’arte ha iniziato a raccogliere trent’anni fa, e per la quale Sgarbi ha grandi progetti, come spiega in questa intervista.
Caro Sgarbi, iniziamo dalla querelle sulla mostra «Da Cimabue a Morandi» a Palazzo Fava a Bologna, dal 14 febbraio. Perché ce l’hanno con lei?La polemica, offensiva, nasce dalla frustrazione di Daniele Benati che riteneva, essendo quello il suo campo, di dover essere chiamato lui per un progetto del genere. Le sue ostilità sono una delimitazione territoriale, non vuole estranei nel suo campo. Il fatto è che anch’io ho studiato quelle cose, anzi ho fatto più di lui, perché ho riscoperto un pittore che non esisteva più, Antonio da Crevalcore, e ho acquistato la più bella opera d’arte che si potesse trovare sul mercato, la prima versione di «San Domenico» di Niccolò dell’Arca. Il recupero della scultura di una delle maggiori personalità dell’arte italiana, oltre che bolognese, da sola vale tutta la carriera di Benati. I miei titoli quindi sono più che sufficienti per questa mostra.
Che nasce come?
Nasce dalla mia polemica con Fabio Roversi Monaco, presidente di Genus Bononiae, quando contestai in maniera vistosa, come altri ma non Benati, la mostra «La ragazza con l’orecchino di perla», certamente un dipinto importante ma che non avrebbe portato una sola persona in più ai musei bolognesi. Proponevo di mostrare in contemporanea un’opera sola di un grande bolognese, il mio Niccolò dell’Arca, al Museo Civico Medievale che si trova accanto a Palazzo Fava. Naturalmente non se ne fece nulla, ma decidemmo di organizzarla per l’anno dopo. Sarebbe bastato mostrare il mio «San Domenico», del 1474, in dialogo con il «San Domenico» già noto, del 1493, dello stesso autore. Per tacere del fatto che il Vermeer a Palazzo Fava metteva in ombra gli affreschi dei Carracci che invece alla mia mostra metterò in perfetta luce, essendo uno dei monumenti più importanti di Bologna.
Nella lettera contro di lei indirizzata al ministro Franceschini da Benati e sottoscritta da oltre 200 storici dell’arte e studiosi si contestava anche la sede, lo spostamento di dipinti da chiese e musei...
C’è malafede nello scrivere «sede privata» per una fondazione bancaria e pure nel cercare di deprimere quello che Roversi Monaco, che è anche presidente dell’Accademia di Belle Arti, ha fatto per la città. Con lui abbiamo pensato di aggiungere una scelta dei più bei quadri di Bologna da affiancare alla scoperta del Niccolò dell’Arca. Per fare una mostra è assolutamente logico spostare dei quadri. E poi nessuno ha detto niente quando il Cimabue della Chiesa dei Servi è andato alla mostra sul Duecento, né per il Giotto al Museo Medievale e ora all’Expo. Il pomo della discordia, l’«Estasi di santa Cecilia» di Raffaello, è stato a Madrid e Parigi nel 2012, l’anno scorso di nuovo all’estero ma nessuno se ne è accorto. Di più, il prestito concordato da Roversi Monaco col soprintendente Luigi Ficacci sarà proprio in quei mesi in cui le sale della Pinacoteca saranno in restauro, pagato tra l’altro anche con i soldi di Genus Bononiae. La polemica, quindi, è totalmente priva di fondamento.
Eppure hanno firmato anche Bruno Toscano, Antonio Pinelli, Keith Christiansen, Pier Luigi Cervellati, Anna Ottani Cavina e tanti altri.
Molti li conosco bene, come Toscano e Pinelli, e le assicuro che non sanno nulla della mostra, del Niccolò dell’Arca o della Pinacoteca in restauro. Firmano solo perché glielo chiedono. Molti sono vecchi amici, come Cervellati, o Donatella Biagi Maino che si è giustificata dicendo che ce l’aveva con Roversi Monaco. Christiansen poi, che ha comprato la «Negazione di Pietro» di Caravaggio esportata abusivamente, si dovrebbe vergognare! Il loro delirio è un po’ contro di me, un po’ in nome di principi di cui però non si informano. Barilli invece, sul «Corriere delle Sera», ha scritto che è la più bella mostra che si potesse fare, complimentandosi con Roversi Monaco anche per aver scelto me, e dichiarando tutta la sua invidia.
Ma perché ci sono sempre queste levate di scudi sulle sue iniziative?
Fino a un certo punto. La mostra in corso «Da Giotto a Gentile», tra l’altro su una materia che non è propriamente mia specialistica, ha riscosso un successo unanime. Non c’è stato nessun problema perché nelle Marche, dopo la morte di Pietro Zampetti, sono rimasto solo io. Lo ripeto, è una questione di occupazione del territorio. La polemica è pretestuosa, e contro una cosa utile alla città. Se poi si vuol criticare la mostra, lo si faccia dopo averla visitata, non prima. E rimane il fatto che il mio Niccolò dell’Arca nessuno l’ha visto, è una cosa in più per la città con intorno un coro di opere bolognesi. Li ho tutti querelati, non possono scrivere che uso i quadri come soprammobili, che non c’è alcun criterio scientifico, che ho insultato Longhi e Arcangeli. Mentre, guarda caso, ho il placet di Mina Gregori.
A proposito di Mina Gregori, ha visto la nuova versione della «Maddalena» di Caravaggio?
Ho detto subito che era la più convincente tra quelle che conoscevo, che mi riservavo di vederla dal vivo. Ci sono stati orrori ridicoli come l’autoritratto di Leonardo, il sant’Agostino di Caravaggio, tutte bufale, questa è l’unica che non appare tale. La esporrei all’Expo perché vederla ci darà la conferma definitiva, per me già piuttosto compiuta.
Bufala anche il Donatello della chiesa dei Servi a Padova?
Francesco Caglioti fa esattamente quello che fece a suo tempo Giancarlo Gentilini, mio grande amico. Gentilini attribuì il Crocifisso, che poi fu comprato dallo Stato come di Michelangelo, un’opera bella ma senza una prova certa della sua autografia, un pezzo oltretutto senza storia. Questo, attribuito a Donatello, ha il vantaggio di essere nella chiesa, però il documento su cui si sono mossi è una chiosa all’edizione del 1550 delle Vite del Vasari, il quale non cita l’opera. La chiosa quindi, di almeno cent’anni dopo la partenza di Donatello da Padova, è di un interprete a cui sembra di vedere Donatello. Io credo sia un’opera di bottega, non ha la qualità per essere del maestro, non è brutta ma sta a Donatello come il Cristo di Gentilini sta a Michelangelo. Sono di area, ma non c’è certezza né documentaria né stilistica.
Che opinione ha del ministro Franceschini?
Ottima. Ha il vantaggio di essere l’unico politico del governo Renzi, l’unico professionista in un Governo di dilettanti. Io lo conosco da sempre, abbiamo fatto insieme la legge che avevo proposto da sottosegretario per istituire il Museo della Shoah a Ferrara, che poi è nato. Su quest’ultima riforma, la parte dei venti musei non l’ho capita bene, perché dovrà reclutare dei direttori e non so che stipendio gli darà. Io invece da subito gli ho suggerito l’idea di accorpare le Soprintendenze ai Beni artistici e architettonici, per affrontare i monumenti nella loro integrità tenendo conto ovviamente di entrambe le esigenze. Lui ne ha tenuto conto, magari solo per eliminare i 30 dirigenti che gli imponeva la spending review. Poi c’è la detassazione per chi dà contributi; insomma ha dato due o tre segnali e i risultati mi sembrano positivi.
Non pensa di occuparsi di nuovo in politica?
Ho fatto politica in modo anomalo, oggi sono diventato assessore alla Rivoluzione a Urbino, la città più bella d’Italia. E la città si è subito riaccesa, anche se sono lì da appena sei mesi. Solo la «Bella principessa» di Leonardo ha avuto 10mila persone in quattro giorni, e poi Paolo Volponi collezionista, la mostra su Tonino Guerra, la «Natività» del Tintoretto per Natale, Matteo Basilè, Lorenzo Bonechi a vent’anni dalla morte. A Palazzo Ducale vanno trenta persone al giorno, con il Leonardo ne sono arrivate 4.100 solo sabato scorso. L’idea è di riaccendere i luoghi, riportarli alla vita. Politicamente mi sono ristretto in quest’ambito. Le esperienze precedenti sono state quella di assessore alla cultura di Milano, la più positiva, quella di sottosegretario, anch’essa interessante per alcuni principi generali (le cose di cui sono più orgoglioso sono state il vincolo per il porto vecchio di Trieste e la ripresa dei lavori al Petruzzelli di Bari), il sindaco di Salemi, mortificato dallo scioglimento per mafia (un’operazione contro il buon senso, anche perché non hanno sciolto Castelvetrano, Calatafimi, Alcamo...). Fare politica oggi è difficile sul piano nazionale, quindi queste funzioni locali sono ciò che rimane della decisione di tanti anni fa, di cui peraltro non mi pento.
Poi c’è l’Expo.
Con la polemica sullo spostamento dei Bronzi di Riace l’asse d’interesse, da incomprensibile nei suoi contenuti e fin troppo comprensibile nei suoi aspetti criminali, si è spostato sull’arte italiana, cioè se sia giusto o meno spostare le opere. Arriverà comunque una quantità d’arte straordinaria, tra cui le sculture di Nicola e Giovanni Pisano dall’Opera Primaziale Pisana, che è in restauro, la «Bella principessa» sotto il grande affresco del Tiepolo di Palazzo Isimbardi, l’«Albero della vita» di Lucignano, uno dei più bei pezzi di oreficeria del Quattrocento, il dialogo tra il «Quarto Stato» di Pellizza da Volpedo e «Guernica», i Sacri Monti, un po’ ovunque fuochi per far vedere la grandezza di Milano e della sua provincia, per ridare l’idea di una città culla dell’arte. Insomma ricondurre l’Expo alle sue origini di rappresentazione della civiltà italiana, vetrina delle cose che abbiamo. I Bronzi di Riace rientravano in quest’ottica, simboli altissimi di un’Italia universale.
E della sua collezione?
Vorrei affidare il mio nome alla storia, per questo ho speso tutto il denaro guadagnato per una collezione d’arte. È stata esposta a Burgos e Cáceres in Spagna, a Città del Messico, adesso è in Cile, arriverà a Palazzo Litta di Milano per la fine dell’Expo. È iniziata nel 1984 dopo aver comprato la più grande biblioteca d’arte al mondo, 120mila libri, ed è come l’oggettivazione di tutto quello che ho fatto. Il mio desiderio è di allestirla in via permanente al Castello di Ferrara, che è vuoto, con tutti i capolavori: Niccolò dell’Arca, Guercino, Artemisia, Cagnacci, Ribera e così via, oggi circa 500 opere distribuite tra Roma, Ferrara e Milano. Questo credo sia il punto d’arrivo della mia vicenda umana.
Altri articoli dell'autore
Tra Foro Romano e Palatino sono stati ritrovati i resti di una lussuosa dimora con una sala per banchetti a forma di grotta e uno straordinario mosaico impreziosito con conchiglie, vetri e tessere blu egizio
Si inizia con l’enigmatico scultore ateniese. Altre due monografiche saranno dedicate a Prassitele e a Skopas
Stéphane Verger nel chiostro di Michelangelo ha fatto eseguire interventi su sette teste di animali antiche (quattro di età adrianea e tre rinascimentali) e ne ha commissionata un’ottava a Elisabetta Benassi
Lo scavo condotto dalla Soprintendenza speciale di Roma ha riportato alla luce strutture in laterizio e un sontuoso apparato decorativo riconducibili a una committenza di altissimo rango, quasi sicuramente imperiale