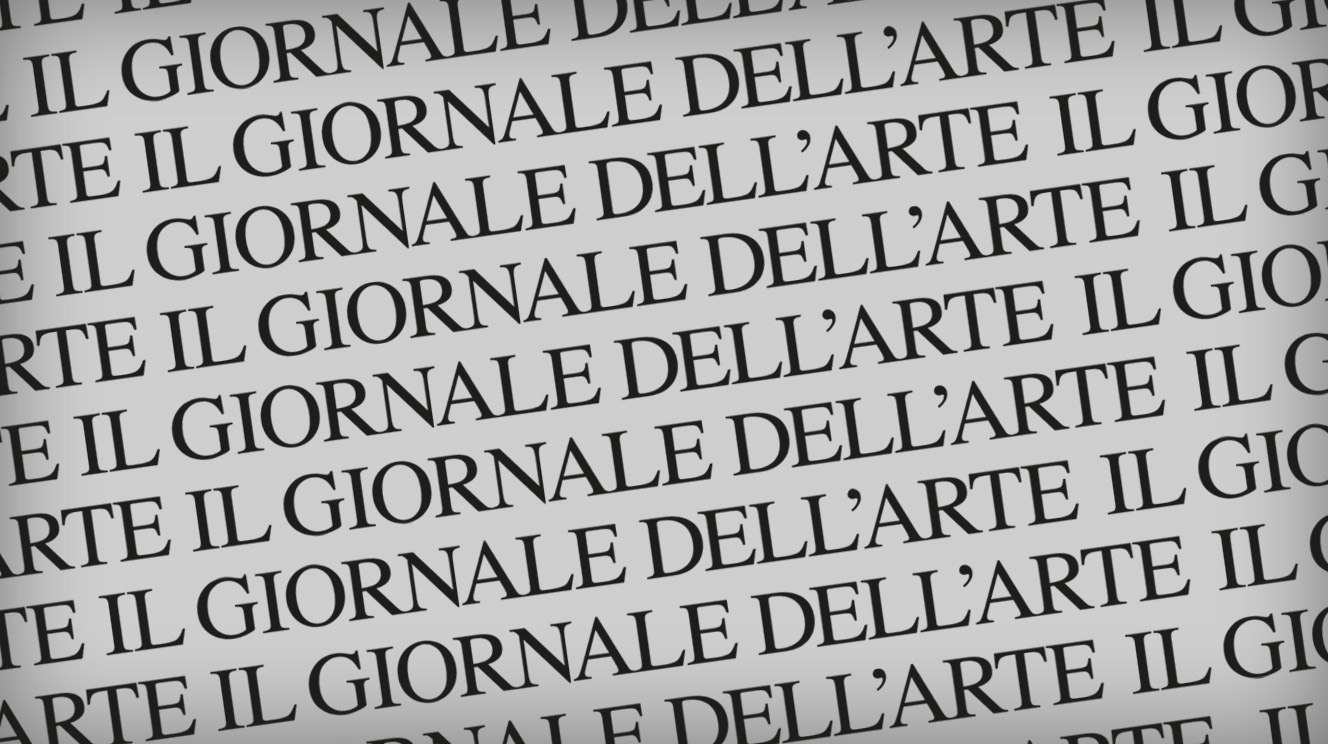Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Laura Lombardi
Leggi i suoi articoliAnche quest’anno la Biennale di Palazzo Corsini è stata una vera concentrazione di capolavori
Col passaggio di testimone da Giovanni Pratesi a Fabrizio Moretti si è inaugurata la 29ma edizione della Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze a Palazzo Corsini sull’Arno, conclusasi il 4 ottobre. Si proponeva più innervata con molti eventi, tra cui la mostra del «padrino» della manifestazione, Jeff Koons, in Palazzo Vecchio, all’insegna di «tutta l’arte è sempre contemporanea».
Con 88 mercanti di cui 27 stranieri la Biennale, che ha voluto presentarsi assai rigorosa nel vetting (in linea con Maastricht), annoverava una concentrazione di capolavori. Moretti non aveva stand ma esponeva solo la «Madonna della Cintola con i santi Benedetto da Norcia, Tommaso, Francesco e Giuliano l’Ospitaliere» di Francesco Granacci, già attribuita perfino a Raffaello. Di fronte a questa pala si apriva lo stand di Giovanni Pratesi, che ha vinto il premio di 10mila euro per la miglior scultura, il «San Ludovico di Tolosa» di Giovanni d’Ambrogio, che andranno al restauro di un’opera del Comune di Firenze, mentre il premio della miglior pittura, assegnato al «San Giovanni Battista» di Nicolas Regnier, da Porcini (€650mila), è destinato a un’opera della Soprintendenza.
Pochissimi arredi, tappeti o oggetti: a far da padroni indiscussi i dipinti e le sculture. Molto clamore hanno suscitato le opere esposte da Mehringer-Benappi: l’«Apostolo» di Arnolfo di Cambio, risalente alla fine del XIII secolo, posto nella lunetta sopra la porta destra del Duomo di Firenze e di proprietà della famiglia Torrigiani dopo lo smembramento nel Cinquecento della facciata, dialogava nello stand con un quadro di Sironi, sottolineandone l’importanza per l’arte del Novecento, ma soprattutto con gli «Angeli dell’Elevatio Animae» di Tino di Camaino, che facevano parte del «monumento sepolcrale del Vescovo Orso» (1321), posto nella controfacciata della basilica di Santa Maria del Fiore: opere il cui valore si aggirava complessivamente intorno ai 3 milioni di euro, e che sarebbe un delitto se non restassero a Firenze, magari proprio nel Museo dell’Opera del Duomo che sta per inaugurarsi.
Notevole il fregio in marmo di Luca della Robbia, con gli «Angeli che recano l’arme Bartolini-Salimbeni e coppie di leoni araldici» da Botticelli Antichità (€200mila), il «Villano» in marmo di Romolo Ferruccio del Tadda (€250mila), da Bacarelli (dove si sentiva la mancanza di Benvenuto Bacarelli, scomparso lo scorso gennaio, cfr. n. 350, feb. ’15, p. 42), ma anche il «Cristo» di Alessandro Algardi da Walter Padovani (€250mila). Vi era poi il raro Leopold Kiesling, «Il Genio delle Arti che svela la Natura come Iside-Artemide», proposto da Carlo Virgilio, eseguito a Roma 1808-09 nell’ambiente di von Humboldt e Thorvaldsen, appartenuto al principe di Liechtenstein (€1,8 milioni). Importante il «Miracolo di san Giovanni Gualberto» di Bicci di Lorenzo da Salomon Old Masters (€260mila), scomparto della predella del polittico realizzato per la chiesa di Santa Trinita a Firenze, commissionato dal banchiere Cante di Giovanni Compagni nel 1434.
Da Carlo Orsi era visibile il desco da parto del Maestro del Giudizio di Paride, raffigurante «La lapidazione dei vecchioni di Susanna» sul recto e «Amore in vesti di paggio» sul verso, datato 1446-47 (tra i 300 e i 400mila euro). Tra i ritratti si segnalavano il «Ritratto di Gabriele della Volta» di Giovanni Bellini da Frascione Arte (€800mila), e il «Ritratto di John Belasyse, poi 1° Lord Belasyse di Worlaby» di Anton Van Dyck da Robilant+Voena, del 1636; fino ad arrivare al «Ritratto di gentiluomo» di Velázquez da Otto Naumann (12 milioni di euro). Da Francesca Antonacci e Damiano Lapiccirella spiccava il bozzetto di Luca Giordano con la «Gloria di sant’Andrea Corsini» canonizzato nel 1629 (€280mila), per la decorazione ad affresco della cupola della cappella di famiglia in Santa Maria del Carmine a Firenze, mentre Longari Arte aveva un crocefisso di Leonardo di Domenico del Tasso datato agli ultimi decenni del XV secolo.
Lo stand di Sperone aveva una rassegna di opere del primo e secondo Futurismo, mentre per l’Ottocento tra le proposte della Società di Belle Arti si annotava il bellissimo Telemaco Signorini «Villa toscana» (€700mila), ma anche il «Piccolo Savoiardo» di Antonio Mancini, che fu esposto a Parigi nel 1935 e ben rivaleggiava col Mancini di Jean-Luc Baroni il «Ritratto di Luigino Gianchetti come suonatore di violino», del 1878 (€500mila). Per l’arte del Novecento notevole lo stand tutto dedicato a de Chirico della galleria Frediano Farsetti e infine, per l’arte contemporanea, la Tornabuoni Arte presentava un grande Boetti, «Mettere al mondo il mondo» (1975), offerto a circa 3 milioni di euro.
Altri articoli dell'autore
È stata inaugurata la mostra «Icone di potere e bellezza» con le tre teste in bronzo dorato del Museo di Santa Giulia a Brescia, secondo capitolo dello scambio di manufatti tra le due istituzioni gestito da Fondazione Brescia Musei
La Sala delle Nicchie ospita la prima di una serie di mostre-allestimento con capolavori di mobilio che testimoniano le diverse dinastie che si sono alternate nel palazzo fiorentino
Da Cecchini a Spoerri, Isgrò, Tremlett e molti altri, edizioni e cataloghi di precedenti mostre sono offerti tra i 100 e i 600 euro
Nelle «Giornate per l’arte contemporanea» sono state presentate la mostra all’UMoCA dell’artista argentino e la nuova installazione permanente di Tobias Reheberger