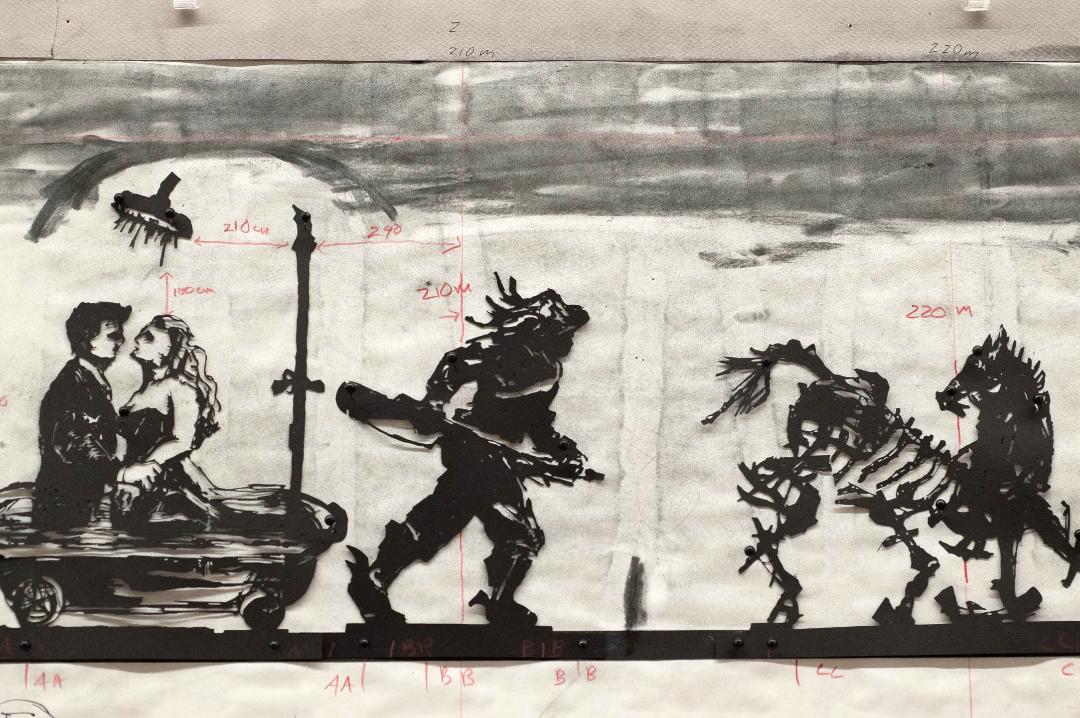Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Francesca Romana Morelli
Leggi i suoi articoliTalvolta Giuseppe Capogrossi ritoccava le «Superfici» esposte nella sala a lui dedicata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea; era autorizzato dalla pugnace soprintendente Palma Bucarelli, anche in virtù dell’amicizia e del lavoro che li univa. Divertito ma ancora più sconcertato, lo raccontava Bruno Mantura, ex vicesoprintendente del museo romano. Quell’esigenza di Capogrossi in realtà non stupisce, perché gli studi e i restauri dei suoi dipinti hanno dimostrato che riutilizzava, non di rado, il verso di dipinti o apportava vistose modifiche a opere segniche anche a distanza di tempo.
Sperimentatore per natura e padrone di una tecnica sviluppata nei tre decenni di militanza nella Scuola romana, all’epoca affilò gli strumenti e le scelte operative che furono le fondamenta della successiva fase informale, quando l’impiego di materiali industriali o prelevati dalla realtà quotidiana è una novità saliente nella ricerca internazionale.
Temperamento saturnino, Capogrossi non ha mai rivelato quello che accadeva nel segreto dello studio, ma ora, per la prima volta, un progetto di ricerca condiviso dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, più precisamente dalla sua Scuola di Conservazione e Restauro presieduta da Laura Baratin, con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, diretta da Cristiana Collu, affiancate dalla Fondazione Archivio Capogrossi di Roma, ha indagato il modus operandi dell’artista e steso una prima campionatura dei materiali distillati dal pittore nella pittura segnica, esaminando lo stato di conservazione di tre grandi «Superfici» del museo, proprietario del corpo di opere capogrossiane più completo tra le istituzioni pubbliche.
Ideato e diretto dalle restauratrici Daphne De Luca, docente della Scuola di Conservazione e Restauro urbinate, e Paola Carnazza del gabinetto di restauro del museo, il progetto è stato focalizzato sulle «Superficie 207» (1957), «Superficie 538» (1961) e «Superficie 553» (1965), vincendo la call di accesso ai laboratori Mo-Lab e Fixlab (2017) e coinvolgendo dal Dipartimento di Chimica dell’ateneo romano La Sapienza al Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa, dall’Istituto di Cristallografia del Cnr (Roma) all’Istituto per i Sistemi Biologici Isb-Cnr. La campagna diagnostica è stata finanziata in larga parte dal nodo italiano dell’infrastruttura di ricerca E-Rihs (European Research Infrastructure for Heritage Science), supportato dal Miur.
La «Superficie 207» s’incardina su una griglia di grandi segni neri lucidi che sembra proseguire oltre i limiti della tela e fa da filtro a una sottostante superficie strutturata da tasselli di colore-luce, originando così una raffinatissima scatola spaziale. La composizione è allettata su un dipinto preesistente, a sua volta steso su una preparazione industriale e un’ulteriore imprimitura. Dalle indagini è emerso un altro elemento importante: «Si è scoperto un disegno preparatorio tracciato a grafite, che divide lo sfondo in vari riquadri, spiega la De Luca, Inoltre alcuni ideogrammi sono delineati a matita direttamente sulla pellicola pittorica.»
Il ruolo del disegno nelle pratiche informali è una questione basilare. Capogrossi chiarì che il disegno può recare in nuce l’idea poi sviluppata nelle «Superfici». Non ha mai eseguito un bozzetto per un suo quadro, nemmeno nella fase figurativa, ma disegnava molto, producendo una messe copiosa nel caso di alcuni soggetti, su cui spesso tornava a distanza di anni. Invece l’impiego del disegno direttamente sul supporto pittorico è discontinuo, motivato dalle caratteristiche della composizione.
Ma quali materiali impiegava? «Negli ideogrammi tracciati con nero d’avorio abbiamo rilevato una resina alchidica, mentre nelle campiture colorate un’acrilica in emulsione: quest’ultima è ipotizzabile che l’abbia mescolata con i pigmenti in polvere, spiega la De Luca. Più verosimilmente, si è servito di vernici destinate all’edilizia, disponibili anche nella storica ditta Poggi, che serviva Capogrossi e altri artisti». Nei segni è stata rinvenuta una vernice acrilica brillante, che doveva servire a creare contrasti tra le parti lucide dei segni e le parti opache dei riquadri colorati dello sfondo.
Guglielmo Capogrossi, presidente della Fondazione, ricorda che lo zio dedicò studi mirati alla variazione della brillantezza delle stesure pittoriche, come dimostra anche la «Superficie 538». Questa, caratterizzata da un piano nero bidimensionale, sembra risentire delle tendenze monocrome intorno al 1960. L’essenziale composizione s’incardina su rapporti e forze in atto nello spazio del piano, potenziati dalle proprietà del colore e da sottili gradi di luminosità e di opacità dei pigmenti neri.
La superficie è tagliata diagonalmente da una fenditura bianca, su cui esercita una forza dinamica, una combinazione di segni neri e due più grandi arancioni, che sembrano scaturire da sotto il piano scuro. Il supporto è una tela industriale su cui Capogrossi ha steso un’imprimitura bianca piuttosto spessa e granulosa, caratteristiche anche di alcune campiture cromatiche, che lasciano supporre l’impasto dei pigmenti con inerti, forse finissima pietra pomice.
Ottenuto con rosso o arancio di cadmio schiariti, il segno arancione, focale nella composizione, ha subito vari ripensamenti. Altri pentimenti si sono riscontrati nelle stesure bianche, causa di crettature su cui l’artista ha steso una nuova campitura. Nel tempo la prima campitura si è ingiallita, rendendo più evidenti le due stesure differenti.
Se la «Superficie 207» e la «Superficie 538» sono state soltanto indagate, l’iconica «Superficie 553» (1965), frutto della stagione più matura del maestro, è stata anche restaurata. Segni neri, altri vuoti o appena accennati si incastrano tra di loro, prendendo forza da una macchia rosso di cadmio a olio in basso a sinistra. La riflettografia Ir ha rinvenuto una quadrettatura a matita, che suddivide lo spazio e delinea alcune parti dei segni.
Al nero d’avorio dei segni è aggiunto olio e blu di Prussia. Il pigmento nero d’avorio era quello preferito da Capogrossi, come rivela una busta di lettere nel Fondo Capogrossi del museo romano su cui l’artista ha annotato una lista di «colori tempera piccoli tubi», compreso quel colore. Il contorno dei segni è stato smorzato con una miscela di bianchi, come ha fatto in altre «Superfici».
Nelle campiture nere e in quella rossa è stata rinvenuta della cera, all’epoca utilizzata da artisti come Jasper Johns, ma nel caso di Capogrossi appresa negli anni Trenta, quando furono scoperte delle pitture a encausto a Pompei. La «Superficie» è firmata due volte, prassi non infrequente, il cui scopo era di indicare un secondo consistente «rimaneggiamento»: la firma in alto a destra appartiene al primo orientamento orizzontale della composizione, quella in basso a destra, con la data «1965», è coerente all’orientamento attuale.
La visibilità dell’imprimitura sui bordi della tela dev’essere frutto di un ripensamento sulle dimensioni del dipinto da parte dell’autore, che lo ha disancorato dal telaio originale e montato su un altro poco più grande. Eseguita da Eleonora Maniccia, la pulitura ha comportato la rimozione dei depositi di sporco, lo spianamento delle deformazioni del supporto evidenti negli angoli e l’applicazione di un prodotto deacidificante per rallentare il degrado delle fibre tessili.
Alla campagna d’indagini e conservativa è dedicato il volume, a cura di Daphne De Luca e Paola Carnazza, Le opere di Giuseppe Capogrossi. Indagini, studi e restauri, che uscirà entro l’estate (Edizioni Tab, Roma).

Giuseppe Capogrossi, «Superficie 553», 1965
Altri articoli dell'autore
Una sessantina di opere di 51 artisti (da Parmigianino a Schiele, da Boetti a Kentridge), entrate nella collezione dell’istituto romano grazie a tre milioni finanziati dallo Stato, sono ora visibili a Palazzo Poli
Un’antologica nel Casino dei Principi a Villa Torlonia e al Mlac di una delle artiste più moderne e complesse del Novecento
L’allestimento da Tornabuoni è una continua scoperta all’interno dell’emisfero artistico e umano dell’artista torinese
Dopo cinque anni il direttore saluta il Macro di Roma con una collettiva di oltre trenta artisti che intende «restituire uno sguardo dinamico al visitatore»