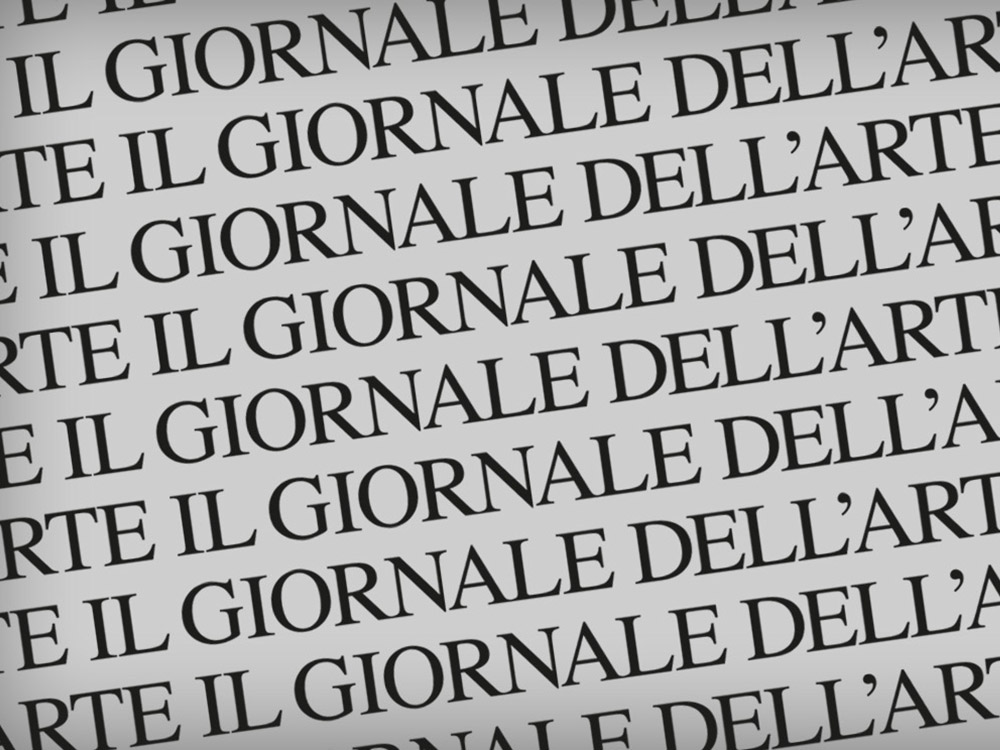Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Silvia Mazza
Leggi i suoi articoliPredecessori e successori politici, burocrati, tecnici, persino la Chiesa, e poi giornalisti delle testate siciliane affetti da «feticismo delle cifre», degni adepti di un «modello Stella che ha attecchito in Sicilia in modo esponenziale e con l’aggiunta di una notevole dose di approssimazione». Sì, proprio lo stesso Stella che una mattina di gennaio le regala, scrive sul suo sito, «un bel risveglio» con la prima recensione del suo libro, occasione dell’intervista che ha rilasciato al GdA sul n. di marzo, L’eradicazione degli artropodi: titolo cacofonico, tutto sommato adeguato a un libro di dubbia correttezza, sia perché pieno di errori e travisamenti di fatti e leggi, sia perché viene meno al fair play professionale. Diciamolo francamente: speravamo di esserci anche noi del GdA, cui negli ultimi dieci anni si devono le maggiori inchieste sui Beni culturali in Sicilia ̶ tra le ultime anche una che la vede protagonista ̶ tra i destinatari degli strali multidirezionali che uno dei 56 assessori delle quattro giunte Crocetta, Mariarita Sgarlata, seconda delle cinque meteore ai Beni culturali, lancia nel libro. Lei, l’assessore «tecnico», l’archeologa (è anche docente universitario) che ha fallito proprio con i parchi archeologici ancora elevati nel libro ad emblema di un presunto successo, lei che si è guardata bene pure dal reinsediare il Consiglio Regionale per i Beni culturali e ha nominato l’ennesimo commissario al posto del Consiglio del Parco della Valle dei Templi, con tutte le questioni spinose che attanagliano i beni culturali in Sicilia, cosa fa? una crociata su un (mal posto) problema dei custodi, cavalcando ribalte televisive («Le Iene», seguite a ruota da «L’Arena» di Giletti).
Insomma, sembrava che il nostro giornale fosse utile solo per citare Georges-Henri Rivière (p. 80), anche quando una fonte bibliografica sarebbe stata decisamente più consona per chi pratica la filologia. Ma la delusione ci è stata alleviata dalla lettura del primo capitolo, «Il sistema dei beni culturali in Sicilia», che ai nostri articoli sembrerebbe in gran parte ispirato. Della riorganizzazione del Dipartimento BBCC in vigore dal luglio scorso la Sgarlata scrive: «si tratta della quarta riforma, da quando le già citate Leggi Regionali 80/1977 e 116/1980 hanno normato l’amministrazione dei Beni culturali in Sicilia, rivoluzionando il vecchio ordinamento ministeriale con l’istituzione, al posto delle soprintendenze tematiche, di quelle uniche su base provinciale» (pp. 34-35).
Singolare coincidenza vuole che nella nostra intervista all’allora assessore Purpura (ed. online del 10 ottobre 2015, pubblicato sul n.358, nov. ’15, p. 12) si legga: «si tratta della quarta, a partire dalla fine degli anni Settanta, quando le leggi regionali n. 80/1977 e n. 116/1980 disegnarono l’amministrazione dei Beni culturali in Sicilia, rivoluzionando il vecchio ordinamento ministeriale con l’istituzione, al posto delle Soprintendenze tematiche, di quelle uniche su base provinciale». Come sarà un caso che, dopo aver riscontrato la nostra stessa successione di argomentazioni (legge n. 10/2000 «Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana», nuovo assetto nel 2010, aggiustamenti di tipo organizzativo-amministrativo nel 2013), ritroviamo un altro passaggio che ci suona familiare: «sono state le norme legislative contenute nella Legge Regionale di Stabilità del 2015 a guidare i decreti con cui è stata riorganizzata la governance dei beni culturali (…). L’articolo 49 della Legge di Stabilità prevede infatti una riorganizzazione dell’apparato amministrativo attraverso la riduzione, non inferiore al 30%, delle strutture intermedie e delle unità operative» (p. 35). Confrontiamolo con quanto ci dichiarava Purpura: «la riorganizzazione avverrà prevalentemente attraverso decreti che attuano norme legislative in parte contenute nella Legge Regionale di Stabilità 2015. Mi riferisco, ad esempio, alla norma (art. 49) che prevede la riorganizzazione dell’apparato amministrativo attraverso la riduzione, non inferiore al 30%, delle strutture intermedie e delle unità operative». Nell’articolo si usa il tempo futuro perché la riorganizzazione era allora ancora in fase di concertazione, mentre la Sgarlata usa il passato… perché ci sta leggendo? Sia come sia, mentre noi possiamo documentare questa nostra precedenza cronologica, essendo stati i primi ad introdurre un’approfondita riflessione comparata tra sistema siciliano e quello ministeriale post-riforma (cfr. anche ed. online 7 sett. ’15, e n. 361, feb. ’16, p. 9), l’ex assessore non può inserire in nota nessun riferimento a propri interventi precedenti al libro, perché evidentemente non ha mai affrontato prima questi argomenti.
Ma proseguiamo con qualche altro esempio, perché le sovrapposizioni non si fermano qui, e per diverse altre osservazioni rinviamo all’allegato in calce a questa Lettera. «Ispirate» ai nostri articoli sembrerebbero pure le considerazioni sulle modalità di aggregazione dei siti e musei all’interno dei nuovi poli. Nel libro si legge di nove poli, perché all’epoca della nostra intervista (ottobre 2015) ammontavano a tale numero, mentre con l’assetto definitivo sono diventati 12. Di questa nuova organizzazione abbiamo scritto, invece, in un altro lungo articolo online del 31 luglio 2016 (cfr. anche n. 367, sett. ’16, p. 12), dove il confronto riforma Mibact ̶ «riforma» siciliana riceve ben altro approfondimento. Di questo articolo e della suddetta intervista a Purpura, l’intero paragrafo «Riforma chiama riforma» sembrerebbe debitore. Alla professoressa Sgarlata, però, è sfuggito un altro articolo, quello sull’inaugurazione del piano terra del Salinas (cfr. edizione online, 27 luglio 2016). Se lo avesse letto l’autrice saprebbe che i musei di rilevanza nazionale come il Salinas o l’Orsi, sebbene confluiti nei poli museali, non sono stati affatto «declassati» a unità operative come lei sostiene (pp. 38 e 39), ma assurti a perno di questi poli, restando dei «servizi». Altro che «macroscopico errore» (p. 39). Ma è solo una delle tante inesattezze disseminate nel libro, la cui ultima pagina è stata scritta sicuramente dopo la chiusura del Museo di Buscemi (agosto 2016) e il prestito dell’Antonello da Messina alla mostra a Palazzolo Acreide (17 agosto-16 ottobre 2016), che possiamo considerare dei termini post quem (p. 177 e p. 204). A quella data la riorganizzazione dipartimentale era già operativa e la Sgarlata avrebbe dovuto sapere come si erano, alla fine, inquadrati i due musei archeologici. Per inciso, riteniamo in qualche misura di poterci ascrivere il merito di aver contribuito a questa soluzione finale, che ha recuperato una qualche dignità ai più antichi istituti museali dell’isola, dal momento che ai precisi quesiti posti nel 2015 la risposta dell’allora assessore fu di apertura: «la posizione dei grandi musei (…) sarà oggetto di specifico approfondimento».
Un’ultima osservazione in proposito. Questa crociata pro Salinas e Orsi fa dire all’autrice che «oggi rappresentano le due realtà museali più estese e importanti non solo della Sicilia, ma di tutta l’Italia meridionale dopo Napoli» (p. 39). «Realtà museali», scrive. Non circoscrivendo il confronto agli altri musei archeologici, significa ignorare che sul podio, dopo Capodimonte, c’è il nuovo Museo regionale interdisciplinare di Messina, seguito (grazie al recente ampliamento) dal Museo nazionale di Reggio Calabria e, quindi, da Palazzo Arnone a Cosenza (cfr. edizione online, 15 dicembre 2016 e n. 371, genn. ’17, pp. 31 e 33).
Ma torniamo all’«attenzione» di cui abbiamo l’impressione di essere stati fatti oggetto. In un altro passaggio della nostra intervista a Purpura scrivevamo: «E come mai si va in controtendenza rispetto alla recente riorganizzazione ministeriale con il mancato riconoscimento dello status di grandi musei alle poche ma importanti e antiche istituzioni museali isolane che, sia per dimensioni sia per patrimonio conservato e gestito, sono ben al di sopra di musei come quelli di Reggio Calabria o Taranto?». Per una nuova singolare coincidenza alle pp. 38-39 del libro leggiamo: « fino ad ora tutte le decisioni prese sono andate in controtendenzarispetto alla recente riorganizzazione ministeriale: una tra tutte è proprio il mancato riconoscimento dello status di grandi musei alle più antiche e rilevanti istituzioni museali isolane che, sia per dimensioni sia per qualità del patrimonio, superano di gran lunga Musei come quelli di Reggio Calabria o Taranto». Coincidenza doppia, visto che l’autrice ripropone lo stesso passaggio appena due pagine dopo (p. 41), e questa volta proprio sotto la formula interrogativa con cui l’avevamo usato noi: «in linea con il riassetto nazionale del Mibact, non sarebbe quindi il caso di attribuire al Salinas e al Paolo Orsi lo status di musei dotati di autonomia gestionale e amministrativa, come peraltro riconosciuto ad altre istituzioni museali dell’Italia meridionale quali i due Musei Archeologici Nazionali di Reggio Calabria e Taranto?».
E, ancora, altri brani sembrano «ispirati» ai nostri. Per esempio, dove scrive dell’aggregazione e articolazione interna di musei e siti archeologici in poli museali (p. 37, da confrontare con ed. online, 10 ottobre 2015, e n. 358, nov. ’15, p. 12), mettendo in rilievo quelle che come noi chiama «incongruenze» della riforma siciliana; mentre traduce le funzioni «fungibili» di cui ci diceva Purpura (ivi, e ed. online, 31 luglio 2016) in funzioni « passepartout» (p. 37). In entrambi i nostri articoli fin qui citati scrivevamo anche che «questo scenario, che prevede un’aggregazione su base provinciale e non per ambiti geografico-territoriali (che potrebbero anche non coincidere con i confini amministrativi), non tiene più conto quindi del legame identitario tra istituti e luoghi della cultura presenti nel territorio di competenza». Che nel libro sembrerebbe parafrasato in: «secondo questo nuovo schema, i musei regionali vengono accorpati a prescindere dalla loro storia, dall’entità dell’istituzione, dalle dimensioni» (p. 37).
Proseguendo in questo confronto sinottico, passando alla pagina successiva ci imbattiamo ancora in nuove coincidenze. La Sgarlata scrive:«si inserisce nella Legge di Stabilità una norma che prevede la mobilità territoriale del personale nel raggio di 50 km dalla sede di primaria afferenza; quindi si assegnano al polo i custodi, prima incardinati in un singolo sito, in modo che possano essere spalmati e impiegati in tutti i musei e siti che ricadono nel perimetro territoriale del suddetto polo. Per garantire la flessibilità del personale di custodia (…)» (p. 38). Noi scrivevamo: «Il personale prima incardinato in ciascun sito viene assegnato al “Polo” per essere organizzato e impiegato guardando alle esigenze complessive dei siti che ricadono nel perimetro territoriale del Polo medesimo. Aumenta, quindi, la flessibilità dell’organizzazione del lavoro che è da ritenere essenziale per raggiungere incrementi consistenti di produttività di tutto il sistema. Vale la pena ricordare, a questo proposito, la complementarità di questa misura con la norma inserita nella legge di stabilità che prevede la mobilità territoriale del personale nel raggio di 50 km dalla sede di primaria afferenza» (dall’intervista dell’ottobre 2015). E anche questo: «Il personale, prima incardinato in ciascun sito, è assegnato ora al polo, secondo gestioni che l’ex assessore Antonino Purpura definiva «fungibili», ossia non strettamente legate alle specificità culturali dei siti medesimi. In altre parole, personale prima inquadrato in un museo adesso può essere trasferito, a seconda delle necessità, ad altro istituto, secondo una mobilità territoriale di 50 km dalla sede di primaria afferenza» (dall’inchiesta del luglio 2016).
Infine, a conclusione del capitolo, «i Poli Museali sono dotati di autonomia tecnico-scientifica, ma non di quella finanziaria e gestionale» (p. 42) sembra proprio una delle domande che ponevamo nel 2015 a Purpura: «I poli saranno, poi, dotati di autonomia tecnico-scientifica, ma non finanziaria e gestionale?». E mentre la nostra intervista non è citata, guarda caso l’ultima nota di questo capitolo rimanda proprio a un’altra intervista a Purpura (lapsus freudiano?), sul «Quotidiano di Sicilia», del 5 febbraio 2015, dove, però, l’assessore rispondeva su tutt’altre questioni. Solo che in questo caso le parole del suo successore sono doviziosamente tra virgolette. Buone solo per favorirle una battuta finale, non essendoci altra attinenza con quanto aveva fin lì scritto.
Non ci resta dunque che consolarci: le sue libere «ispirazioni» la scrittrice non le nega neppure allo stesso Giuliano Volpe (si cfr. anche l’allegato), presidente del Consiglio Superiore BBCCP, nonché curatore della collana che ospita il libro: «Progetti di sviluppo del territorio, così devono essere intesi i piani paesaggistici regionali che assecondano una visione dinamica e non statica del paesaggio, associando alla corretta azioni di tutela e apposizione di vincoli una strategia di pianificazione in linea con la storia sociale dei luoghi» (p. 114). Brano che, cambiando l’ordine degli addendi e con qualche «fedele trascrizione», sempre dimenticando di citare la fonte, ricalca questo di Patrimonio al futuro: «i Piani Paesaggistici Regionali che superano la logica del mero vincolo per adottare una strategia progettuale, passando da una tutela vincolistica a regole di trasformazioni coerenti con le peculiarità locali, cioè da una visione statica a una dinamica: sono, di fatto, progetti di sviluppo del territorio» (p. 96).
Per il resto stiamo parlando di un libro in cui le inesattezze sono davvero tante. Dall’istituzione del parco della Valle dei Templi che sarebbe avvenuta nel 2005, invece che nel 2000 (ma forse l’ex assessora confonde istituzione e attivazione, che avvenne, comunque nel 2002: avrebbe dovuto leggerlo nel libro di Adriano Varrica (p. 10; p. 14), dato che lo cita in nota a p. 124; cosa pensare, peraltro, del fatto che scambi, a p. 137, per il titolo di questo libro quello del quarto capitolo al suo interno?) alla confusione tra sponsorizzazione, mecenatismo e crowdfunding e al fatto che ignori l’esistenza di una circolare (del 16 dic. ’15 n. 25, cfr. n. 362, mar. ’16, p. 2), che regolamenta anche in Sicilia la materia, anche se lei è convinta che «siamo ancora all’anno zero» (p. 221).
Di quanto si sia lungi dal poter considerare un’«occasione centrata» (p. 137, convinzione ribadita anche nell’intervista che ha rilasciato al collega Stefano Milani del GdA) quella per il sistema dei parchi archeologici lo abbiamo raccontato nell’inchiesta, in cui abbiamo passato in rassegna gli otto decreti da lei firmati, potendo concluderne che la legge in materia (20/2000) sia stata interpretata in modo incredibilmente variabile, cosicché ogni decreto presenta procedure diverse l’una dall’altro! Dalla carenza del parere del Consiglio dei Beni culturali al decreto di perimetrazione una volta sì, l’altra no, per cui questi atti corrono «il serio rischio di essere annullati», ci ha spiegato l’avvocato di Legambiente, Corrado Giuliano, ricordando «esempi di riserve naturali istituite e poi dopo magari un lustro annullate dalla giustizia amministrativa, come i pantani di Pachino o Isola delle Correnti». Ma c’è ben altro. Mentre la Sgarlata non ha dubbi - per il parco di Siracusa «sono scattate le norme di salvaguardia a tutela del bene e questo è certamente un successo» (p. 111) - il Tar di Catania ha stabilito che il decreto è inefficace (a limitare contro-interessi dei privati) ai fini della tutela, per il semplice fatto che si tratta solo di uno step di un procedimento amministrativo in itinere. Eppure, anche nell’intervista che ha rilasciato al collega, ci è dato leggere di questa sordità a ciò che viene chiarito in un’aula di tribunale: «con questi primi decreti, che alcuni tendono a delegittimare (solo noi? o anche il Tar? o l’avvocato Giuliano? o un altro avvocato, Salvo Salerno, dirigente regionale, che pure segnalò l’irrilevanza ai fini della tutela? Ndc.), scattano le norme di salvaguardia entro i 200 metri dal perimetro, impedendo le concessioni edilizie». Nella foga, poi, di rivendicare a tutti i costi un primato al suo mandato, si dimentica che in Sicilia la prima concessione di un sito a un’associazione no profit avvenne nel 1999 (giardini della Kolymbetra al Fai) e la prima sponsorizzazione di peso nel 2003 (quella di Würth per il restauro della Cappella Palatina di Palermo).
Su una cosa, però, siamo d’accordo con l’autrice: «un patrimonio culturale diffuso non può essere governato da una politica confusa». Principio inappuntabile: sempre che, almeno questo, non sia frutto di «ispirazione». In conclusione, a parte il trattamento che ci è stato riservato, un istant-book che vorrebbe celebrare 12 mesi (più sei al Territorio e Ambiente) che non si segnalano in modo particolare nella storia dei beni culturali in Sicilia, può assolvere dalle sviste e imprecisioni che contiene, figlie della fretta con cui è stato evidentemente licenziato? Ma, poi, perché l’ex assessora che, a distanza di due anni dalla fine della sua parentesi politica, si è risolta giusto ora a condividere con i lettori le sue memorie palermitane, va di fretta? Forse che il libro non sia altro che uno strumento di propaganda in funzione delle elezioni regionali del prossimo ottobre?
Articoli correlati:
Errori e travisamenti
Altri articoli dell'autore
La proposta di legge Orlando-Franceschini è passata alla Camera
Pronta la nuova agorà del Museo Salinas in restauro da dieci anni
Cronaca e progetti a cinquant’anni dal sisma
Polemiche per la trasferta di una tavoletta del pittore messinese, tra le 120 opere scelte dal critico d'arte per il Castello Ursino di Catania.