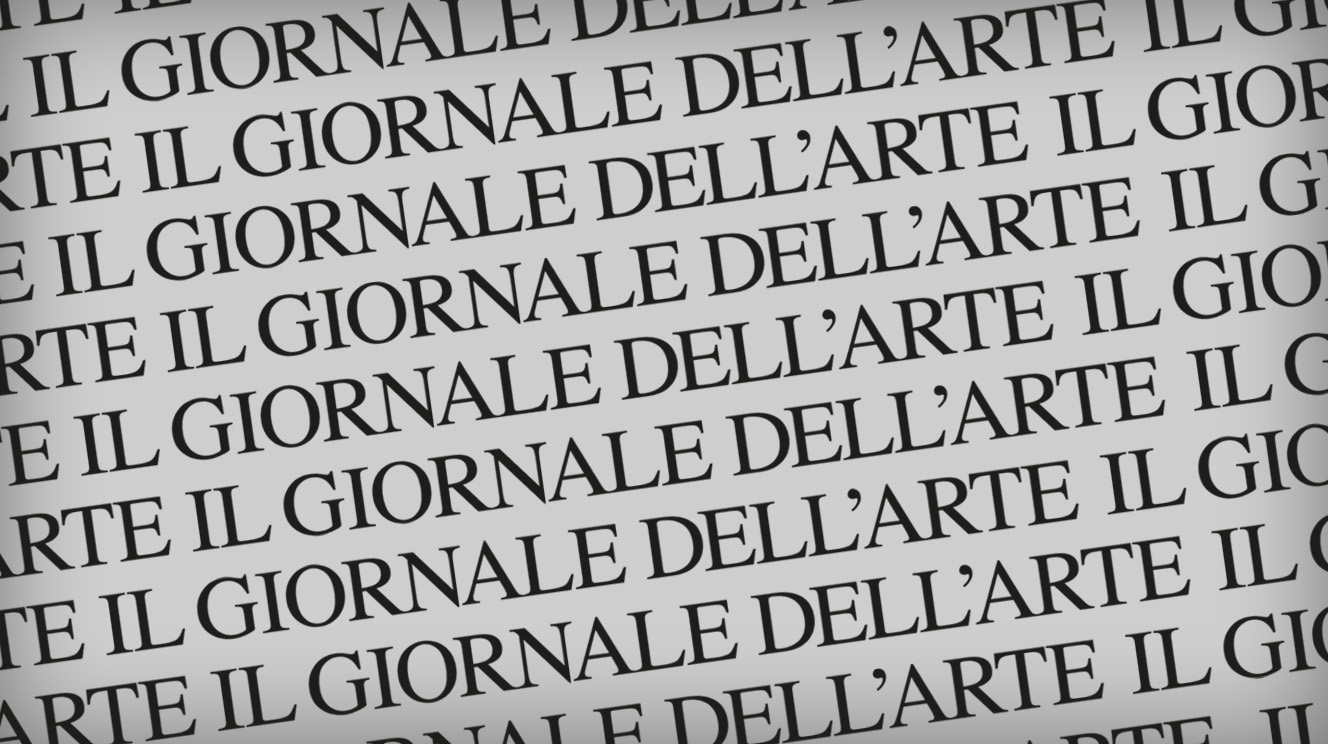Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Federico Castelli Gattinara
Leggi i suoi articoliUrge risolvere alcuni aspetti critici gestionali della chiesa di Santa Maria della Pace, capolavoro architettonico di Pietro da Cortona che vanta il celebre chiostro di Bramante e custodisce opere di Andrea Bregno, Raffaello, Rosso Fiorentino, Baldassarre Peruzzi, Orazio Gentileschi, Carlo Maratta, Carlo e Stefano Maderno, Lavinia Fontana e Francesco Albani. L’orario di apertura è limitato a tre mattine a settimana, e solo fino a mezzogiorno, lo stupendo pronao semicircolare è un’incomprensibile giungla di vasi di oleandri dentro e fuori dalla cancellata (montata dopo che nel 1979 fu arso vivo un giovane somalo che vi dormiva) e brutti paracarri di marmo compromettono ulteriormente la veduta della chiesa. «Il nostro sogno è trasformare lo slargo in un’isola pedonale», spiega Lucia Calzona, responsabile di zona dell’ex Soprintendenza Spsae e Polo Museale di Roma nonché curatrice del restauro della cappella presbiteriale (5 mesi di lavoro, 70mila euro) che verrà presentato 18 giugno.
Abbandonato dalla fine dell’Ottocento fino ai lavori di Paolo Marconi nel 1968-70 (essenzialmente nel chiostro del Bramante), il complesso versava in pessime condizioni.
I pesanti ma necessari interventi in chiesa avvennero però molto più tardi a partire dalla cappella, restaurata nel 1985-86, cui seguì il rifacimento delle coperture. La cappella, un tempo uguale alle altre della tribuna ottagona, nel 1611-14 era stata allargata e interamente ridecorata su committenza della famiglia Rivaldi. A distanza di trent’anni però l’umidità di risalita aveva intaccato i dipinti di Domenico Cresti detto il Passignano (1559-1638) sulle due pareti laterali. Erano ritornate le efflorescenze saline già presenti prima del 1985, aggravate dal sottostante commesso marmoreo che spinge in alto l’umidità. In particolare l’«Annunciazione» era danneggiata anche dal sole penetrante da una finestra sulla parete opposta, che presto sarà chiusa da un tendaggio hi-tech. Il restauro, eseguito dalla C.B.C., è andato molto più a fondo rispetto a quello di trent’anni fa. Soprattutto si è intervenuti non come se si trattasse di dipinti murali, bensì come se fossero dipinti a olio, quali effettivamente sono, per quanto su una preparazione in cocciopesto e una rifinitura pigmentata di fondo che il Passignano sfruttò come base per il colore. Le due scene hanno ritrovato lucentezza e cromia originarie (il pittore usò addirittura due rossi differenti per le vesti di Maria, più tenue nell’«Annunciazione» e più intenso nella «Natività») e lo splendido e voluto «effetto lavagna». La volta e il catino absidale dell’Albani, che nel 1985 non erano stati neanche toccati, ora sono tornati leggibili per quanto rovinati. Si tratta dell’unica committenza diretta che il pittore ebbe a Roma, mentre lavorava per i Carracci a Palazzo Farnese. La cappella nel suo complesso ha ritrovato la freschezza perduta: le lavagne del sottarco con le sante e i piccoli tondi coi ritratti dei Rivaldi dipinti da Lavinia Fontana, le statue di virtù (Pace e Giustizia) di Stefano Maderno, i preziosi commessi marmorei in 14 marmi diversi, le porte lignee intarsiate, i metalli già ricoperti da un’argentatura meccata. Infine la Madonna miracolosa, di primo Quattrocento, rifilata e rimaneggiata alla fine di quel secolo, col trono sostituito da un cielo di nuvole e angioletti.
Altri articoli dell'autore
Tra Foro Romano e Palatino sono stati ritrovati i resti di una lussuosa dimora con una sala per banchetti a forma di grotta e uno straordinario mosaico impreziosito con conchiglie, vetri e tessere blu egizio
Si inizia con l’enigmatico scultore ateniese. Altre due monografiche saranno dedicate a Prassitele e a Skopas
Stéphane Verger nel chiostro di Michelangelo ha fatto eseguire interventi su sette teste di animali antiche (quattro di età adrianea e tre rinascimentali) e ne ha commissionata un’ottava a Elisabetta Benassi
Lo scavo condotto dalla Soprintendenza speciale di Roma ha riportato alla luce strutture in laterizio e un sontuoso apparato decorativo riconducibili a una committenza di altissimo rango, quasi sicuramente imperiale