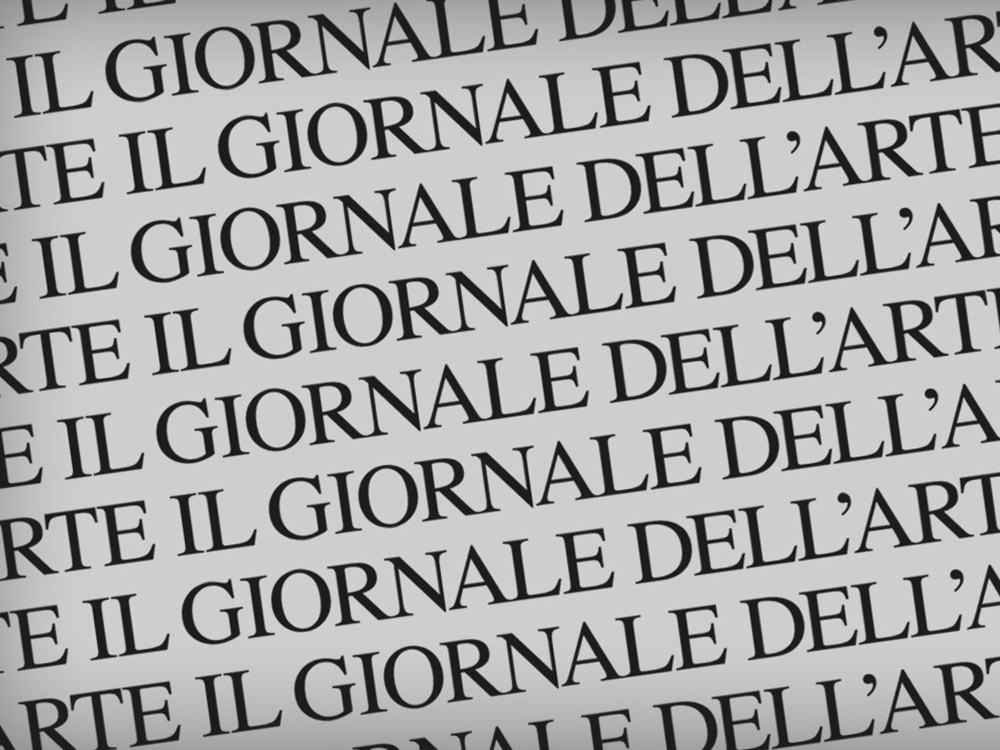Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
.jpeg)
Flaminio Gualdoni
Leggi i suoi articoli<!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 11.0px; font: 8.5px 'Franklin Gothic Std Condensed'} span.s1 {font-kerning: none} span.s2 {font: 8.5px Helvetica} -->
Kentridge inaugura la sua grande epopea romana, Christo i suoi «Floating Piers» sul Lago d’Iseo. In poche settimane nulla rimarrà sullo specchio del lago, mentre lungo il Tevere passeranno giusto un po’ di mesi perché una nuova patina nera inghiotta tutto. Opere importanti, impegnative, costosissime, che appaiono e scompaiono.
Non per incuria: chi le ha concepite ha calcolato già la loro esistenza breve. L’effimero non è certo un fenomeno nuovo: è dal ’400 che gli artisti realizzano cose meravigliose (gli apparati di Leonardo per il matrimonio Sforza Aragona, i tableaux vivants di Hugo van der Goes, la Pompa introitus Ferdinandi di Rubens, per dirne alcune strepitose) destinate a durare un tempo limitato. Poi le avanguardie, soprattutto quelle riottose al mito del museo e all’«imperialismo del mercato» (espressione, ognun sa, abusatissima in certi anni) hanno fatto dell’opera non durevole un simbolo di purezza, di libertà, di poesia eccetera.
Ed è cominciata la metamorfosi: la non durevolezza dell’opera ha cominciato ad andare di pari passo con la sua immediata mitizzazione mediatica. Il capolavoro è tale perché si fa solo memoria e discorso, al più documento, e tutto ciò è la vera opera, accettata come sostituto legittimo della sua matrice fisica. Se ne parla molto, e questo è l’essenziale. La gratuità e la fragilità aggiungono fascino irresistibile. Oggi, con il web, se ne straparla e si strafotografa addirittura: «Dismaland» di Banksy lo conosce anche il mio giornalaio, anche se non l’ha visto quasi nessuno.
Le opere effimere si sono gonfiate di conseguenza, divenendo monumentali secondo la logica banale del gigantismo. Qualcuno finanzia questo po’ po’ di roba e c’è chi si chiede perché, magari non calcolando che ottenere gli stessi risultati planetari con normali campagne di pubblicità, o con qualche sfilata, costerebbe assai di più: ora che l’arte è considerata una specie di vetrinismo dell’intelligenza, è in realtà un fatto perfettamente sensato.
Proprio Christo, tra l’altro, è un pioniere e sin dagli inizi ha insegnato a molti come si finanziano le sue grandi operazioni.
E Kentridge sulle sottigliezze spettacolari in tutti i sensi non lo batte nessuno. Il fatto che intorno nasca un can-can a sua volta gigantesco, è effetto previsto e ottenuto. Tanto ci sono Instagram, i libri, i documentari: soprattutto i discorsi intorno a.
E poi, diciamoci anche questo: è meglio evocare, anche se solo a parole e con qualche vecchia foto, l’«Ambiente nero» di Fontana, o guardarsi tutti i giorni l’ammasso di ferraglie di «Orbit» di Kapoor (la torre di 115 metri nel Parco Olimpico di Londra, Ndr), che, purtroppo, è destinata a durare a lungo?
Altri articoli dell'autore
Il Criptico d’arte • Conosciuto anche come Vasco dei Vasari, l’architetto italiano fu un personaggio anomalo: nonostante il suo contributo al Futurismo, indagò il modo in cui l’anarchia influenza l’arte
Il Criptico d’arte • La vicenda della Banana di Cattelan: da provocazione sul mercato a oggetto di gesti insensati e fuorvianti
A Milano una collettiva di 12 artisti omaggia in altrettante puntate il capoluogo culla della tecnica artigianale e artistica in grado di passare da generazione in generazione
La grande mostra sul movimento artistico voluta dall’ex ministro Sangiuliano in realtà arriva dopo settant’anni di studi specialistici sull’argomento. Ma l’Italia non è futurista