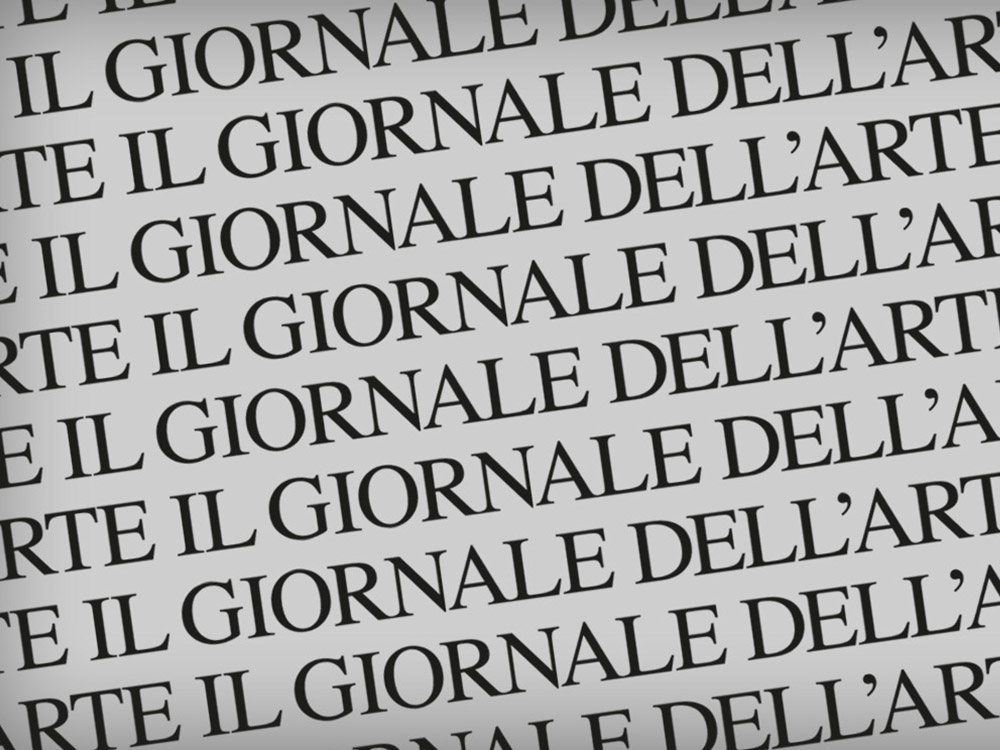Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Lidia Panzeri
Leggi i suoi articoli103 artisti espongono per la prima volta alla Biennale: «Un segno, ha dichiarato il presidente Paolo Baratta, che la Biennale è in grado di proporre gli eventi nel momento in cui nascono». È una mostra ispirata all’umanesimo, che concepisce l’opera d’arte come un atto di resistenza, di liberazione e di generosità». «A distanza di un anno dalla mia nomina, gli ha fatto eco Christine Macel, con tutti gli sconvolgimenti che sono seguiti in questo arco di tempo, si conferma la validità della mia proposta», a cominciare dal titolo scelto. L’alto numero di esordienti non si deve tuttavia a un eccesso di giovanilismo. Anzi, a volte si risarciscono artisti che non hanno avuto il dovuto riconoscimento. È il caso, ad esempio, del torinese Giorgio Griffa, classe 1936, anche se il record della longevità spetta ad Anna Halprin, nata negli Stati Uniti nel 1920.
Numerosi gli ottuagenari, 14 gli artisti scomparsi. Il tutto sviluppato in nove «transpadiglioni», nove capitoli o famiglie di artisti. Il Padiglione centrale ai Giardini, quello degli artisti e dei libri, dell’«otium» e del «negotium», vede Franz West sdraiato su un divano contrapposto a Olafur Eliasson che da Berlino trasferisce qui il suo laboratorio in cui lavorano trenta giovani, alcuni immigrati, a creare oggetti, tra i quali lampade. Segue il Padiglione delle Gioie e delle Paure, con Firenze Lai, da Hong Kong, e la sua claustrofobia. Il Padiglione dello Spazio Comune ha come epicentro una performance di Maria Lai, «poco conosciuta all’estero», chiosa la Macel, con la sua capacità di coinvolgere l’intera popolazione di Ulassai in azioni significative. Il Padiglione della Terra ha tra i protagonisti l’artista brasiliana Erika Verzutti con la sua denuncia sulle torture degli animali.
Il Padiglione delle Tradizioni recupera antichi riti come quelli dei Maori, mentre quello degli Sciamani propone l’artista come missionario; è l’esperienza di Ernesto Neto, condivisa per due anni con le tribù dell’Amazzonia: ne porterà una folta rappresentanza, un centinaio di persone, nei giorni della vernice. Il Padiglione Dionisiaco è incentrato sul corpo della donna con la sua aggressiva sessualità esibita nelle foto di Eileen Quinlan. Il Padiglione dei Colori ha tra i suoi protagonisti il già citato Griffa e Riccardo Guarneri. A conclusione, il Padiglione del Tempo e dell’Infinito.
Grande rilievo è dato alle performance: ben venti quelle in coincidenza con la vernice. Gli artisti sono inoltre invitati ad autorappresentarsi con un breve video che sarà messo in streaming a breve e fino all’inaugurazione: per incontrarli in carne e ossa, anzi per condividere, insieme, un pranzo, l’appuntamento è ogni venerdì e sabato per tutta la durata dell’esposizione. «Tavola aperta» è il titolo dell’iniziativa. Quanto alle partecipazioni nazionali, sono 85 i padiglioni, quasi tutti a carattere monografico: è il caso di Anne Imhof per la Germania e di Mark Bradford per gli Usa. Quattro i Paesi presenti per la prima volta: Antigua e Barbuda, Kiribati, Nigeria e Kazakistan. Drasticamente ridotti infine gli eventi collaterali, cosa che ha suscitato più di un mugugno.