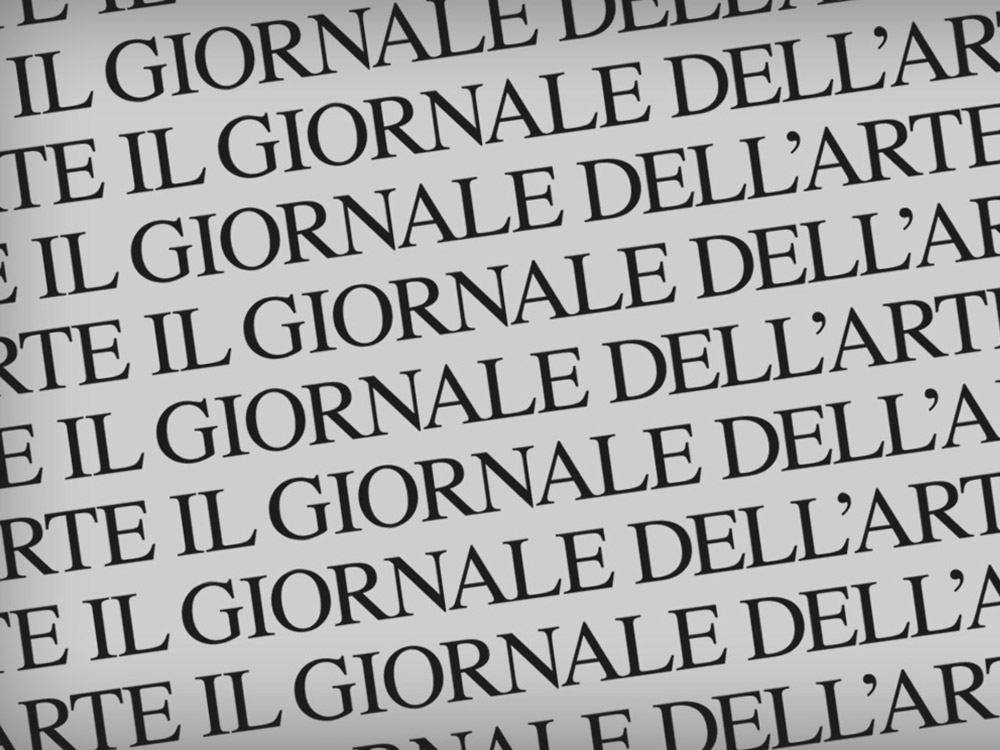Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Lidia Panzeri
Leggi i suoi articoliA conclusione del quinto centenario della morte di Giovanni Bellini (1433 ca-1516), dal 25 febbraio al 18 giugno Palazzo Sarcinelli accoglie la mostra «Bellini e i belliniani. Dall’Accademia dei Concordi di Rovigo». È il quarto appuntamento, promosso dal Comune di Conegliano e da Civita Tre Venezie, di rivisitazione della pittura veneziana e veneta tra Quattrocento e Cinquecento, dopo il «Cinquecento Inquieto» (2014), «Carpaccio Vittore e Benedetto» (2015) e i «Vivarini» dell’anno scorso. La curatela è sempre di Giandomenico Romanelli, che abbiamo intervistato.
Fulcro della mostra è la collezione di 29 opere della Pinacoteca dei Concordi a Rovigo. Come si è formata?
All’inizio dell’Ottocento, per iniziativa del conte rodigino Giovanni Francesco Casilini che acquista con intelligenza e gusto nell’allora fiorente mercato veneziano. Alla sua morte destina le sue opere in parte all’Accademia dei Concordi e in parte al Seminario. Negli anni Settanta del Novecento queste opere sono state tutte unificate all’Accademia.
Qual è il criterio espositivo scelto?
Tutto ruota attorno al ruolo della bottega, anche se di Bellini sono presenti due capolavori, una «Madonna con il Bambin Gesù» e l’intenso «Cristo Portacroce». Il visitatore può esaminare come da un prototipo del Giambellino si arriva all’imitazione: se partendo da un modello in cartone, con la tecnica dello spolvero; se da una sagoma ritagliata o se dal disegno, che nei seguaci è particolarmente accentuato.
Che cosa è emerso dalle vostre ricerche?
Si è capito che spesso il processo imitativo si basava sulla riduzione delle dimensioni del prototipo, com’è evidente da un confronto sullo stesso soggetto della «Circoncisione» di Marco Bello, immagine guida della mostra, o in altri esempi di Girolamo da Santacroce. Un altro modo si basava sull’accentuazione del colore, dissonante rispetto alla trasparenza tonale del maestro.
Esistono delle tipologie di soggetti?
Certamente: la «Madonna con Bambino», che Bellini aggiorna dalla tipologia bizantina; poi la «Devota Meditazione», termine che preferisco a quello più in uso di «Sacra Conversazione», dove a fianco della Madonna con Bambino compaiono altri santi. In entrambi i casi si tratta di quadri e tavole realizzati per una committenza privata. Questo secondo soggetto si evolve, in Bellini, nella pala d’altare, destinata a una committenza pubblica, in primis i circoli domenicani. La prima pala di Bellini del 1475 fu distrutta da un incendio, ma rimangono esempi nella pala di San Giobbe e in quella di San Zaccaria. Ancora per quanto riguarda la figura di Cristo, Bellini rimane un modello, come si vede nella «Flagellazione» di Palma il Vecchio. Altra tipologia di soggetti è quella del ritratto profano, documentato in mostra dalle quattro teste virili di scuola tintorettiana. Chiude il percorso la tematica mitologica, in realtà poco amata da Bellini, di cui si conosce solo il «Festino degli dei» della National Gallery di Washington.
Tra tanti artisti veneti figurano anche i ferraresi Dosso e Battista Dossi.
Sì, con una «Madonna con il Bambino e santi». Non è che i Dossi si possano definire allievi, ma sono importanti per capire lo sviluppo della pala d’altare.
Quanto dura l’influenza di Bellini?
Per certo versi fino all’Ottocento, ma ho voluto circoscrivere il periodo al Cinquecento, includendo nel repertorio anche Palma il Vecchio. Poi ci sono i riscontri con la pittura nordica, da un «Adamo ed Eva» tratto da Albrecht Dürer alla «Vanitas» di Mabuse.