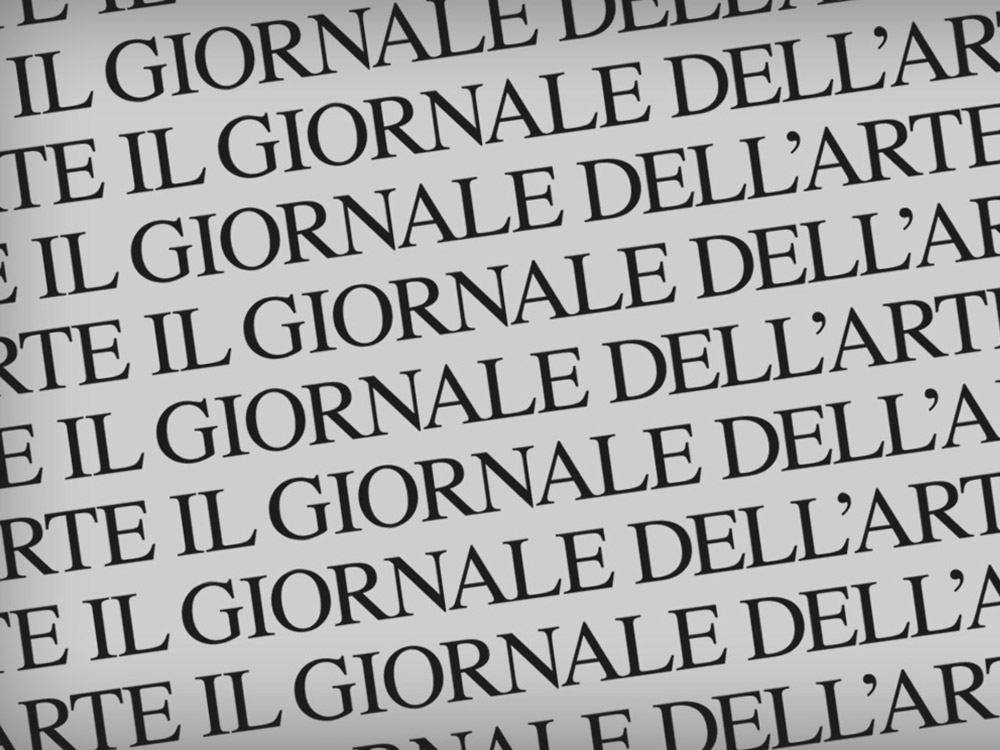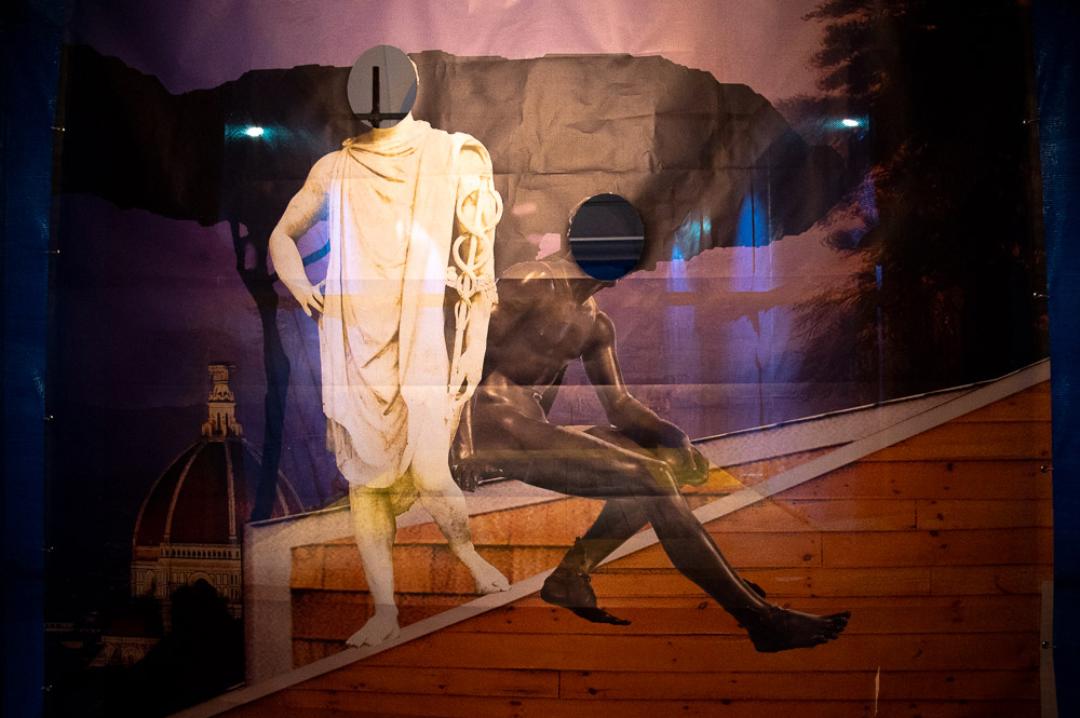Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Laura Lombardi
Leggi i suoi articoli
La Galleria Il Ponte, in collaborazione con Paola De Angelis e la Galleria Milano, dedica una mostra all’attività di Giulio Turcato (1912-95) negli anni Sessanta, mettendo in luce una stagione importante di uno dei maggiori esponenti dell’Astrattismo e poi dell’Informale in Italia.
Protagonisti sono due cicli di opere: i «Tranquillanti», del 1961, pitture e collage di pastiglie di tranquillanti su tela, dove i medicinali nello spazio della tela creano l’effetto di una galassia e le «Superfici lunari» pittura a olio e tecnica mista stesi su una superficie di gommapiuma realizzate nel 1964, esposti due anni dopo alla Biennale di Venezia, in cui la gomma scelta per le superfici lunari, ha, per definizione dell’artista stesso, un «crostone scabroso pieno di avvenimenti nuovi e di meraviglia».
L’arte di Turcato sta a cavallo tra due dimensioni, la realtà e la sua decantazione, fino a compiere una metamorfosi che riflette un modo di agire più profondo, che travalica l’aspetto formale per svelare la bellezza insita nei banali oggetti quotidiani o le potenzialità della materia stessa, o indagando quelle del colori oltre lo spettro, come il marrone e l’amaranto.
A questi cicli si aggiungono in mostra due «Superfici malate» del 1957 e 1961, mentre nella lounge room è la scultura «La porta» (1973), affiancata da cinque carte su colore del 1961. In occasione della mostra è pubblicato il catalogo con testo introduttivo di Walter Guadagnini.
Altri articoli dell'autore
«Il mio lavoro non è politico, ma piuttosto sociale, perché in politica ci si rivolge a un periodo troppo breve, mentre io mi occupo di questioni più esistenziali», spiega l’artista belga
Il programma espositivo, realizzato con l’American Academy in Rome, mette in relazione le ricerche di T.J. Dedeaux-Norris e Heather Hart con i materiali d’archivio dello scrittore William Demby
Un’intera sala è dedicata al massimo scultore in cera attivo nel capoluogo toscano a fine Seicento: Gaetano Giulio Zumbo
La mostra a Pisa curata da Francesca Dini ripercorre lo sfavillante periodo, a fine Ottocento, in cui Parigi era il centro culturale del mondo. E tra i protagonisti di quel nuovo clima, gli artisti italiani che scelsero la capitale francese come patria d’adozione, tra cui Boldini, De Nittis e Corcos