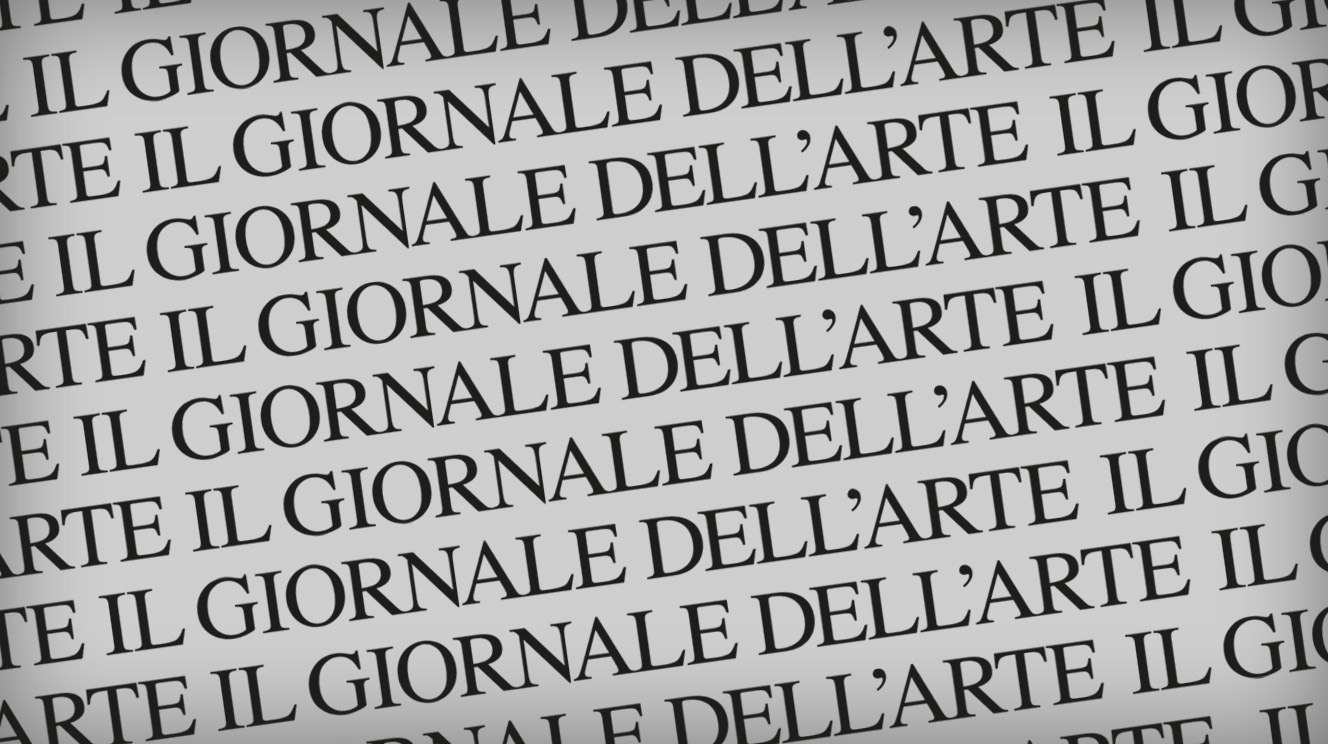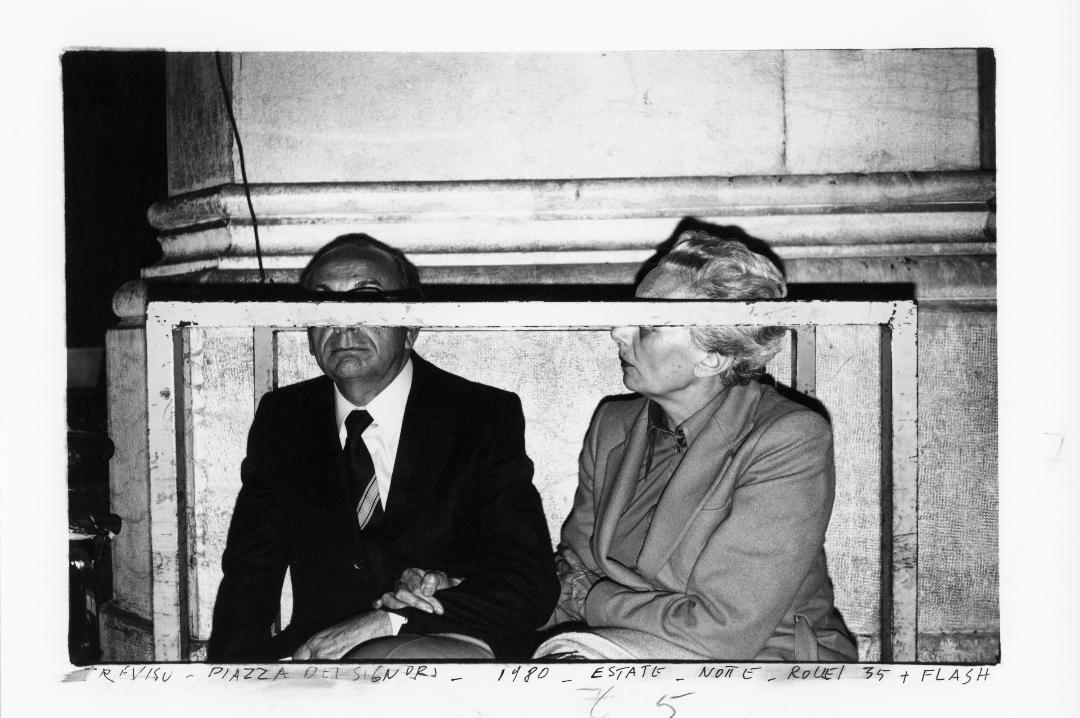Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Risale al 1983 l’ultima grande mostra dedicata da Milano a Francesco Hayez, nato a Venezia nel 1791 da una famiglia poverissima, ma milanese doc per quasi 60 anni, dal 1823 fino alla morte, nel 1882. Fu a Milano che Hayez, dopo gli studi all’Accademia di Venezia e il perfezionamento (e le prime commesse, di segno ancora neoclassico) a Roma, sotto l’ala di Antonio Canova, colse i primi veri successi, vincendo nel 1812 con il «Laocoonte» il Grande concorso di Pittura dell’Accademia di Brera. E fu a Milano che la sua fama esplose nel 1820, all’esposizione annuale di Brera, con l’acclamato dipinto storico «Pietro Rossi», seguito nel 1821 dal non meno osannato «Conte di Carmagnola» (dalla tragedia di Manzoni), due opere fondative della nostra pittura romantica. A Milano, poi, tenne per lungo tempo la cattedra a Brera, esponendovi anno dopo anno con un successo crescente, e a Milano sarebbe morto, carico di gloria e di onori. A oltre trent’anni da quella rassegna, sono le Gallerie d’Italia-Piazza Scala a dedicargli, dal 7 novembre al 21 febbraio, un nuovo omaggio, curato sempre da Fernando Mazzocca (con il coordinamento di Gianfranco Brunelli), ma diverso da quello, grazie all’avanzamento degli studi e ai numerosi inediti ritrovati nel frattempo. «La mostra, ci spiega Mazzocca, ha un impianto cronologico e si propone di evidenziare la versatilità di questo maestro, che sapeva creare capolavori nella pittura di storia, mitologica o orientalista come nel ritratto o nella pittura sacra. In questi anni è poi emerso un “Ecce Homo” su tavola che pare un’opera di Raffaello: la prova di come cercasse anche di recuperare il primato, ormai perduto, della pittura italiana. Del resto, al contrario di molti artisti del tempo, Hayez possedeva un sicuro mestiere, al quale si sommava in lui un’attitudine poetica non comune». Sono 120 le opere in mostra (tre delle collezioni delle Gallerie di Piazza Scala): non manca nessuno dei capolavori che fecero di lui, con Giuseppe Verdi e Alessandro Manzoni, il cantore dei valori risorgimentali e l’inventore di un linguaggio in cui l’Italia intera potè riconoscersi ben prima che l’unità politica si compisse. Tra gli altri, oltre ai famosi ritratti, non manca la «Maria Stuarda», figura allora vissuta come una martire cristiana, da lui dipinta però con le fattezze della sua amante (la protagonista delle sue molte, piccanti opere erotiche) e circondata da una folla di personaggi in cui figura l’intera classe dirigente milanese d’allora, quasi si trattasse di una festa in costume. Con essa, le tre versioni del celeberrimo «Bacio» e quelle, non meno amate, della «Malinconia» e della «Meditazione», accostate a sculture di Canova, alle quali Hayez guardò, e a statue di Vincenzo Vela, che invece rivelano il loro debito con i suoi dipinti.
Altri articoli dell'autore
Dal 30 aprile nel comune di Bellano trova casa, grazie alla donazione della famiglia, l’intero corpus grafico e un centinaio di dipinti dell’artista scoperto nel 1983 da Giovanni Testori
Per molti anni ripudiate dai critici e dagli stessi designer («escluse le “tre M” Mari, Munari e Mendini), le affinità elettive tra design e arte sono indagate dall’istituzione milanese
10 Corso Como dedica al maestro romagnolo una mostra incentrata sulla realtà più labile che esista, selezionando scatti in cui si aprono riflessioni sugli statuti della fotografia e sull’atto stesso del fotografare
Con un convegno in programma il 22 e 23 maggio sarà presentato il restauro degli affreschi realizzati nella Chiesa di San Salvatore nel 1375 dal Maestro di Lentate