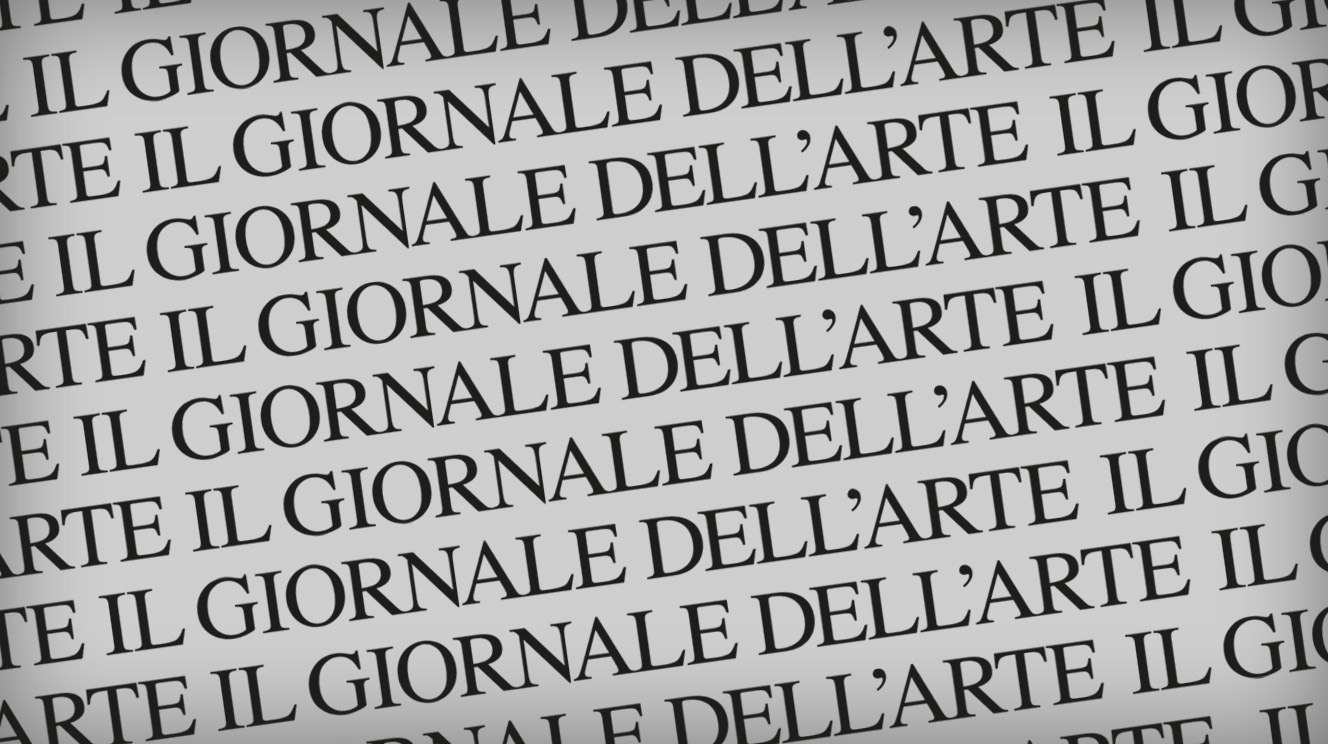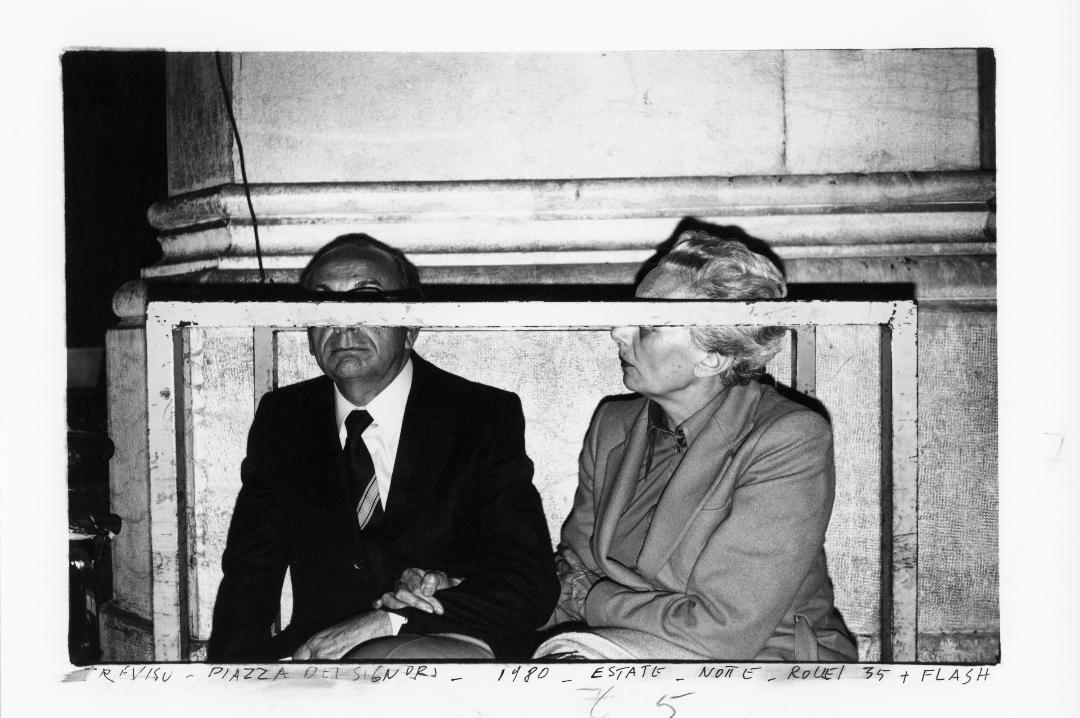Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Sono trascorsi cento anni da quando, entrata in guerra l’Italia nel 1915, Giorgio de Chirico e il fratello Alberto Savinio dovettero lasciare Parigi, dove stavano conoscendo i primi successi, e rientrare in patria. Arruolati nell’esercito, furono distaccati a Ferrara e fu qui che, grazie all’incontro con Filippo de Pisis e poi con Carlo Carrà, ricoverato nel 1917 nell’ospedale psichiatrico militare Villa del Seminario, e ai contatti con Giuseppe Raimondi e Giorgio Morandi nella vicina Bologna, prese forma la Metafisica come movimento artistico strutturato. In realtà essa aveva visto la luce anni prima, nei dipinti stranianti realizzati da de Chirico sin dalla fine del 1909 tra Milano e Firenze, e dalla metà del 1911 a Parigi, ma la fama di queste opere era rimasta circoscritta. Ecco perché i manuali di storia dell’arte sono soliti datare (un po’ superficialmente, a ben vedere) al 1915 la «nascita della Metafisica», che ora festeggia dunque il secolo di vita.
Per celebrare l’anniversario, la Fondazione Ferrara Arte con la Staatsgalerie di Stoccarda e con la collaborazione dell’Archivio dell’Arte Metafisica presenta dal 14 novembre al 28 febbraio in Palazzo dei Diamanti la mostra «De Chirico a Ferrara. Metafisica e avanguardie», curata da Paolo Baldacci e Gerd Roos.
Paolo Baldacci, perché la mostra del centenario della Metafisica verte sul solo periodo ferrarese?
Perché si sentiva la necessità di mettere a fuoco questo periodo: non si era mai fatta prima d’ora una rassegna soltanto su questi anni. Poi perché va sfatato il pregiudizio in cui siamo caduti in molti, secondo il quale il periodo ferrarese, se si escludono opere come «Le muse inquietanti» o i grandi «manichini», sarebbe una sorta di appendice minore della stagione parigina. Questa mostra lo smentisce senza ombra di dubbio e fa emergere con evidenza che non esiste una sola Metafisica. Se ne possono infatti individuare tre: quella elaborata dai due fratelli a Milano e Firenze, che traduce in forme plastiche certe idee filosofiche di Nietzsche; quella sviluppata a Parigi che, sullo sfondo ideale di Torino e del Risorgimento, mette in scena quelli che de Chirico chiamava gli «enigmi sabaudi», cioè le metafore della sua conquista di un’identità di patria e di cultura. Infine c’è la Metafisica ferrarese, profondamente diversa, che anticipa la rivoluzione dadaista: i grandi temi autobiografici della malinconia e della nostalgia diventano meno importanti e de Chirico concentra lo sguardo sulle cose ordinarie e quotidiane, sulla materia stessa, che insieme alla guerra che lo circonda gli appare il segno più evidente della «grande pazzia» dell’universo. Ogni quadro ferrarese è un accumulo scultoreo protodadaista, ma privo di violenza distruttiva e anzi capace di trasformarsi in un «evangelico» annuncio poetico di grande forza classica, nel quale confluiscono le tradizioni magiche e sapienziali delle culture semitiche e mediterranee volte al controllo delle forze fatali ed enigmatiche del cosmo. Molte opere di questi anni esercitarono un enorme fascino sui contemporanei: esemplare il caso di «Objet Indéstructible», il metronomo con l’occhio di Man Ray, che cita quasi letteralmente la composizione dell’«Angelo ebreo».
Quante sono le opere in mostra del de Chirico «ferrarese»?
A Ferrara de Chirico dipinse 52 quadri. Uno è scomparso, altri sette-otto sono minuscoli. Qui ne abbiamo 28 dei maggiori, compresi «Ettore e Andromaca» e «Le muse inquietanti», non più visti da quarantacinque anni: non era mai accaduto, nemmeno al MoMA nel 1981, dove le opere ferraresi erano diciannove.
La Metafisica ferrarese può però contare su più protagonisti.
Certamente. E in questa mostra si può assistere al confronto Carrà-de Chirico a un livello irripetibile. Dei 13 dipinti di Carrà del periodo ferrarese, 11 sono in mostra, tra i quali almeno un paio non si vedono da quasi cinquant’anni. Ci sono poi opere fondamentali di Morandi, che provano come sarebbe arrivato anche da solo all’isolamento metafisico degli oggetti. Naturalmente c’è de Pisis (tra gli altri, i suoi «Pesci sacri», a confronto con quelli di de Chirico). E ci sono, con opere importantissime, tutti coloro che in Europa guardarono ai temi e alle iconografie ferraresi di de Chirico e Carrà, dal già citato Man Ray a Raoul Hausmann, George Grosz, René Magritte, Salvador Dalí e Max Ernst.
Altri articoli dell'autore
Dal 30 aprile nel comune di Bellano trova casa, grazie alla donazione della famiglia, l’intero corpus grafico e un centinaio di dipinti dell’artista scoperto nel 1983 da Giovanni Testori
Per molti anni ripudiate dai critici e dagli stessi designer («escluse le “tre M” Mari, Munari e Mendini), le affinità elettive tra design e arte sono indagate dall’istituzione milanese
10 Corso Como dedica al maestro romagnolo una mostra incentrata sulla realtà più labile che esista, selezionando scatti in cui si aprono riflessioni sugli statuti della fotografia e sull’atto stesso del fotografare
Con un convegno in programma il 22 e 23 maggio sarà presentato il restauro degli affreschi realizzati nella Chiesa di San Salvatore nel 1375 dal Maestro di Lentate