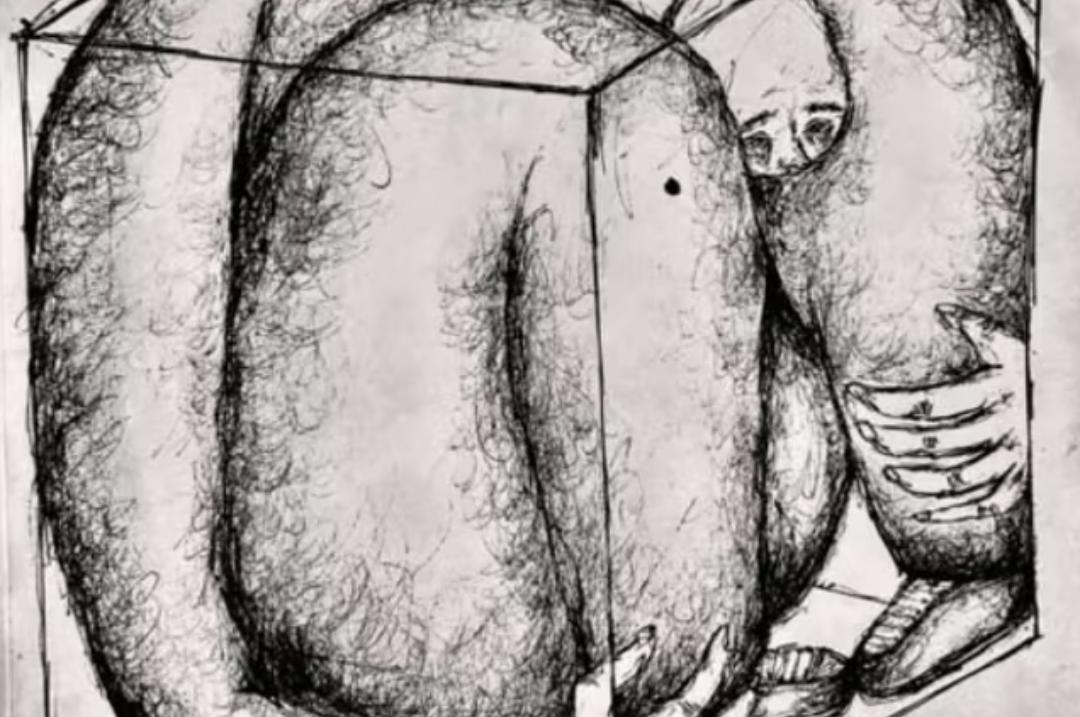Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Sarvy Geranpayeh
Leggi i suoi articoliLa guerra civile del Sudan, originata da una lotta per il potere tra le Sudanese Armed Forces (Saf) e le Rapid Support Forces (Rsf), ha devastato il Paese negli ultimi due anni. Organizzazioni per i diritti umani, tra cui le Nazioni Unite, parlano di crimini di guerra, tra cui stupri di massa e massacri etnici. Decine di migliaia di persone sono state uccise e quasi 13 milioni sfollate.
Le istituzioni culturali non sono state risparmiate. Molti dei principali musei del Paese sono stati saccheggiati o distrutti, mentre i siti archeologici si stanno deteriorando a causa della mancanza di fondi e dell’insufficiente sostegno internazionale. Nonostante le estreme difficoltà e la limitata assistenza nazionale e non, molte figure culturali (spesso sfollate esse stesse) continuano a lavorare per salvaguardare il patrimonio.
Abbiamo parlato con tre operatori del mondo dell’arte e del patrimonio attivi in Sudan perché ci raccontassero le loro esperienze.
Omayama Abdel Rahman Mohammed Al-Sanosi
Omayama Abdel Rahman Mohammed Al-Sanosi ha dedicato gran parte della sua carriera alla salvaguardia del patrimonio culturale del Sudan. Nel 2023, quando è scoppiata la guerra, lavorava da oltre un decennio al Sudan National Museum, a Khartoum, e faceva parte del suo team curatoriale. La sua vita è poi precipitata.
Quando la presenza delle Rsf è aumentata nel suo quartiere di Khartoum Nord e la zona è diventata sempre più pericolosa, lei e la sua famiglia si sono trasferite nello Stato del Nilo. Lì, temendo che il museo di Damer potesse essere attaccato, Al-Sanosi e i suoi colleghi hanno impacchettato la collezione del museo e l’hanno portata al sicuro.
Ma la vita quotidiana rimane una lotta. Sebbene riceva ancora un «piccolo stipendio», questo copre a malapena le necessità di base in mezzo all’impennata dei prezzi. Le medicine sono scarse e costose. Al-Sanosi, che ha subìto un’operazione a cuore aperto diversi anni fa, dipende da medicinali sempre più difficili da trovare. Si preoccupa anche del futuro del figlio di 11 anni.
La sua casa a Khartoum Nord, che ora è sotto il controllo dell’esercito, è stata saccheggiata. «Anche gli armadietti sono stati portati via», racconta la donna. Spera di poter tornare dopo gli esami del figlio e iniziare a ricostruire la sua vita.
Il saccheggio del Museo Nazionale, invece, l’ha colpita più duramente. Quando lo scorso marzo sono emerse foto e video della collezione saccheggiata, è rimasta sconvolta. «Ho pianto tutto il giorno. Sono rimasta in una stanza per due giorni, non potevo parlare con nessuno, racconta. Questa era la nostra cultura, questa era per tutta l’umanità». Il museo ospitava una delle collezioni archeologiche più significative dell’Africa settentrionale, con reperti che vanno dall’età della pietra ai regni islamici, tra cui pezzi del sultanato Funj di Sennar, che governò il Sudan nilotico dal XVI secolo al XIX. Al-Sanosi e i suoi colleghi hanno visitato il Museo Nazionale a maggio, nell’ambito degli sforzi in corso per valutare l’entità dei danni. «Non saprei descrivere i miei sentimenti quando ho visto il museo in quelle condizioni: l’intero edificio era distrutto».
Dopo due anni di conflitto e nessun segno di cessazione della crisi, Al-Sanosi afferma che se le venisse data la possibilità di lasciare il Sudan, non esiterebbe a farlo.
Sami Elamin
Sami Elamin, direttore dell’Ufficio per le Antichità dello Stato del Nord del Sudan e responsabile del sito del Jebel Barkal, Patrimonio dell’Umanità Unesco, si stava preparando a tornare al suo posto a Karima, a 400 chilometri a nord di Khartoum, quando nell’aprile 2023 è scoppiata la guerra civile.
Quando le Rsf si sono impadronite della capitale, la città è stata bombardata e l’accesso ai beni di prima necessità, come denaro, elettricità e comunicazioni, è stato interrotto. Elamin ha perso i contatti con i genitori anziani e malati per due settimane. Ha quindi attraversato i posti di blocco in tutta la città per prenderli e portarli a casa sua. «Sono stato abbastanza fortunato a raggiungerli vivi», racconta a «The Art Newspaper».
Con l’intensificarsi della violenza, ha evacuato la sua famiglia a Karima in minibus, un viaggio che descrive come «molto spaventoso». Si sono sentiti al sicuro solo tre ore dopo, nel deserto. «Riesci a immaginarlo? Si può essere al sicuro nel deserto e non in città», dice.
I suoi genitori, come molti altri sudanesi, si sono recati in Egitto per ricevere cure mediche. Anche altri parenti sono fuggiti dal Sudan alla ricerca di un’istruzione per i loro figli, dato che la qualità della scuola nel Paese è crollata: alcune classi hanno 80 alunni e operano a turni alterni per far fronte all’afflusso di famiglie sfollate.
Nonostante le difficili circostanze, Elamin ha scelto di rimanere. «Non posso andarmene così. Ci dovrebbe essere qualcuno qui per tenere le cose in ordine, per risolvere i problemi, dice. Non dico di risolvere tutto, ma con il mio staff e i miei colleghi siamo riusciti a mantenere la situazione stabile a Jebel Barkal».
In assenza di sostegno da parte del Governo, Elamin e i suoi colleghi si sono affidati a una collaborazione di lunga data con l’Università del Michigan, negli Stati Uniti, e al suo progetto archeologico Jebel Barkal. Il sito, parte di una vasta area di 60 chilometri che comprende templi, piramidi, tombe e palazzi dei periodi Napatano (900-270 a.C.) e Meroitico (270 a.C.-350 d.C.), soffre di impatti ambientali come inondazioni e afflusso di sfollati. «La maggior parte dei problemi esisteva già prima della guerra, ma sono diventati sempre più pericolosi per il sito dopo la guerra», spiega Elamin.
Con il sostegno dell’Università e di altre organizzazioni, Elamin ha introdotto misure di protezione di base come l’assunzione di guardie, l’installazione di dissuasori e la rimozione dei rifiuti. Ma lo scorso marzo, un’altra battuta d’arresto è arrivata quando i tagli agli aiuti esteri dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump hanno interrotto una sovvenzione cruciale del Fondo degli ambasciatori statunitensi per la conservazione culturale, che veniva distribuita attraverso l’Università. Quello che rimaneva, circa 100mila dollari, avrebbe sostenuto il team di Elamin per un altro anno.
Nel frattempo, il caos della guerra ha incoraggiato gli opportunisti. Ad esempio, le autorità locali hanno approvato lavori di costruzione nella zona cuscinetto del sito Unesco. Elamin è intervenuto, sporgendo denuncia alla polizia, ed è riuscito a bloccarli. La prospettiva di una possibile condanna al carcere non lo scoraggia. «Non ho paura, dice. Troverò la mia strada».
Mahmoud Suleiman Bashir
Mahmoud Suleiman Bashir, direttore dell’Ufficio per le Antichità dello Stato del Nilo e responsabile del sito dell’Isola di Meroe, il secondo sito del Sudan dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è rimasto per proteggere il cuore dell’antico regno di Kush. Afferma che le piramidi, i palazzi, i templi e le zone industriali di Meroe, risalenti all’ottavo secolo a.C. e al quarto secolo d.C., sono ora vulnerabili all’aumento dei visitatori e ai cambiamenti climatici.
A due mesi dall’inizio della guerra civile, i soldati delle Rsf rapido hanno preso d’assalto la casa di Bashir a Khartoum Nord, rubandogli l’auto, il telefono e «tutto». L’incidente lo ha spinto a trasferirsi a Karima, a cinque ore di macchina dal suo ufficio.
Ora, le interruzioni di corrente e le interruzioni dell’acqua sono diventate più frequenti, poiché gli attacchi dei droni prendono di mira le infrastrutture urbane. La famiglia di Bashir è rimasta senza acqua potabile per due mesi, e procurarsi l’acqua dal fiume Nilo è ora il suo principale compito quotidiano. «Non posso lasciare la mia famiglia e andare in ufficio: nessuno può fornire loro l’acqua», dice, spiegando che tutti soffrono dello stesso problema.
Visita la sede di Meroe ogni volta che riesce a trovare i fondi per viaggiare. Poiché l’ufficio si trova in un’area remota senza elettricità né acqua corrente, deve anche trovare il carburante per il generatore e la manutenzione del pozzo. «È molto difficile lavorare da casa, dice. Questa è una delle sfide più grandi che devo affrontare».
Come molti sudanesi, Bashir dipende ora dal sostegno finanziario dei familiari che vivono all’estero; suo fratello in Germania paga l’affitto. «Abbiamo dimenticato l’elettricità», dice. Si usano metodi tradizionali per lavare e stirare i vestiti e pannelli solari per ricaricare i telefoni.
Non c’è una tempistica per il ritorno alla sua casa a Khartoum Nord. Fotografie recenti mostrano che l’edificio è stato completamente saccheggiato, persino le tubature dell’acqua sono state rubate.
Nonostante le pressioni, Bashir si rifiuta di andarsene. «Sono responsabile del sito dell’Unesco. Non potevo andarmene, dice. Non abbiamo ricevuto alcun sostegno per controllare le visite, nonostante la segnalazione di tutte queste minacce all’Unesco e ad altre organizzazioni impegnate nella protezione del patrimonio archeologico durante i conflitti».
Afferma che ci sono state numerose promesse di assistenza non mantenute e che le richieste di finanziamento sono impantanate nella burocrazia. È molto preoccupato per le condizioni del sito, dove la sabbia continua ad accumularsi con l’avvicinarsi della stagione delle piogge, con l’allarme di inondazioni ancora più gravi degli anni precedenti: una combinazione disastrosa.
Aggiunge che solo la Sudan Archaeological Research Society e il British Museum di Londra hanno fornito un sostegno costante all’Isola. Sono urgentemente necessari altri finanziamenti.
«Ho perso alcune delle nostre speranze e dei nostri sogni, ma la comunità locale conta su di me. Ho pensato che questo è ciò che potevo offrire al mio Paese: rimanere e fare tutto il possibile per proteggere questi siti e tenerli al sicuro», dice Bashir. Aggiunge che, anche se non è in grado di fermare il degrado, può almeno continuare a segnalarlo al mondo.
Altri articoli dell'autore
Arthur Brand ha ritrovato un tesoro di testi sottratti anni fa dall’istituzione dell’Aia, ignara dei furti. Tra i 25 pezzi riemersi da uno scatolone in una soffitta, anche il primo diario di bordo di Michiel de Ruyter, leggendario ammiraglio del Seicento
Secondo quanto riportato dai media locali, sono stati attivati protocolli di emergenza per salvaguardare i beni culturali e i siti storici nel contesto del conflitto con Israele
Un organismo investigativo indipendente delle Nazioni Unite ha pubblicato i risultati la scorsa settimana
Mentre la crisi umanitaria peggiora ulteriormente, anche gli artisti e gli operatori culturali di Gaza stanno ormai perdendo la speranza. Sullo sfondo del blocco israeliano della Striscia «le condizioni sono ormai disperate», dicono