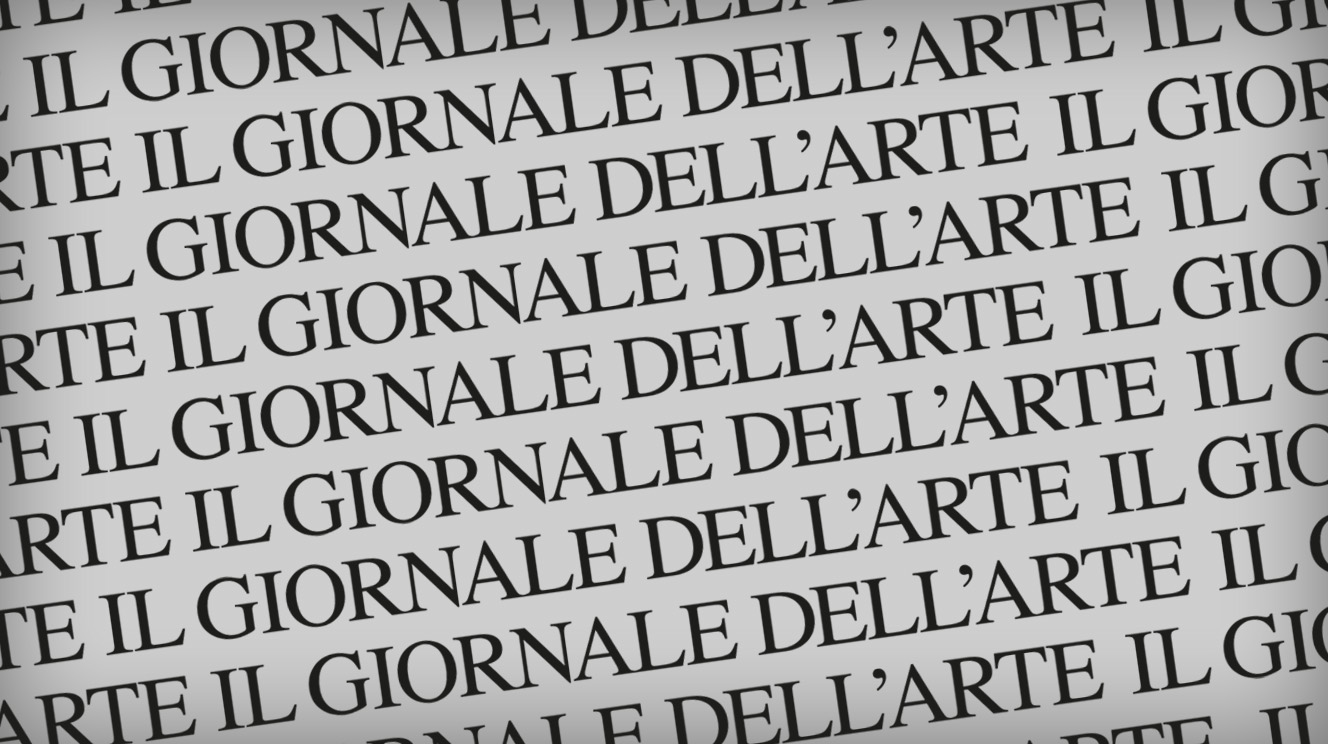Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Federico Castelli Gattinara
Leggi i suoi articoliRoma. Oltre 150 opere e un’autorevole specialista come curatrice, Maria Cristina Bandera (nella foto), per la mostra «Giorgio Morandi 1890-1964» al Complesso del Vittoriano dal 27 febbraio al 21 giugno: è la prima grande antologica morandiana a Roma, da quella, celebre, del 1973 curata da Cesare Brandi alla Galleria Nazionale d’arte moderna. La Bandera, direttrice della Fondazione Longhi, ha voluto allestire una mostra «il più possibile completa, dove non solo il numero ma anche la qualità e l’importanza delle opere è eclatante», con una non scontata attenzione alla storia collezionistica dei dipinti (un centinaio gli oli esposti), molti di privati, «tele che non si vedono mai ma che io, prima di decidere, sono andata a cercare ad una ad una, perché il mio non è un progetto fatto sui libri».
Maria Cristina Bandera, Morandi, al di là della sua notorietà, non è un pittore «facile». Quali sono i dipinti che, all’inizio del percorso, introducono il visitatore alla sua opera?
Apro con una natura morta del Centre Pompidou del 1914, una tela strepitosa anche per le misure. All’inizio ho voluto riassumere tutti i temi morandiani, con questa natura morta cubofuturista, un paesaggio del 1916 già nella collezione di Mino Maccari, gli unici due acquerelli con le «Bagnanti» del 1918, l’autoritratto del Corridoio Vasariano, che è il più significativo, due nature morte metafisiche da Brera più altre due da collezione privata e dal Museo Morandi. Poi ancora un acquarello con i fiori, uno dei suoi primissimi, da collezione privata.
Le opere dei primi anni sono rare?
Di solito la fase giovanile di un artista è un periodo formativo, così come gli ultimi anni segnano una parabola discendente. Non nel caso di Morandi, da subito pittore strepitoso e lucidissimo, «una corda ben tesa» per usare le parole di Longhi. L’artista stesso eliminò preventivamente le opere che non gli piacevano.
Come ha concepito l’allestimento?
Ogni tema è affrontato a sé, sempre in un rigoroso ordine cronologico. C’è poi l’accostamento delle varianti, che Morandi eseguiva per paura di ripetersi. Sono opere affini per tematica ma con sottilissime variazioni compositive, di orchestrazione cromatica, tonali, di pennellate che sembrano quasi la trama di una garza giustapposta. La sua pittura è estranea a qualsiasi forma di ripetitività; lo scopo era raggiungere l’essenza. In mostra ci sono diverse variazioni, per esempio una natura morta su un piatto ovale dei Musei Vaticani anticipata, lo stesso anno, da una della collezione Sandro Pertini.
Lei sostiene che Morandi non fosse ripetitivo, ma nell’immaginario comune è «il pittore delle bottiglie»...
È la vulgata che più mi irrita. Pittore sottile, complesso, misterioso, le sue non sono bottiglie ma un fatto mentale, una lenta presa di distanza dalla realtà, forme architettoniche su un palcoscenico. Non a caso Sydney Pollack ha accostato una sua natura morta a un edificio di Frank Gehry. Gli artisti moderni, più sensibili, lo capiscono meglio. Nel catalogo, a proposito, c’è uno scritto breve ma molto acuto di Giulio Paolini.
Com’è rappresentata la produzione acquafortistica?
C’è una trentina di fogli, la metà dei quali affiancati dalle matrici in rame prestate dall’Istituto Nazionale per la Grafica. Si parte proprio da lì, perché la prima opera esposta da Morandi fu un’incisione del 1915, una piccola natura morta cubofuturista. Ci sono poi acquerelli importanti e disegni.
Ha avuto difficoltà per i prestiti?
Al contrario, ho riscontrato grandissima disponibilità. Le fondazioni Longhi e Brandi, i due massimi storici dell’arte che si sono occupati del pittore, prestano anche lettere e documenti, oltre ai due dipinti che Brandi aveva nella sua villa a Vignano lasciata alla Soprintendenza di Siena. Ci sono le opere già di Ragghianti, Alfredo Casella, della principessa Marguerite Caetani, prestiti di grandi istituzioni come la Camera dei Deputati, la Banca d’Italia e la Rai, i pezzi scelti da Adriano Olivetti oggi della Telecom, i dipinti del Mart già di Augusto Giovanardi, di Soffici, di Lamberto Vitali, della Fondazione Giovanni Spadolini che concede una natura morta e varie incisioni e opere da collezionisti privati della prima ora, in molti casi scelte da loro o a loro destinate da Morandi stesso.
Altri articoli dell'autore
Tra Foro Romano e Palatino sono stati ritrovati i resti di una lussuosa dimora con una sala per banchetti a forma di grotta e uno straordinario mosaico impreziosito con conchiglie, vetri e tessere blu egizio
Si inizia con l’enigmatico scultore ateniese. Altre due monografiche saranno dedicate a Prassitele e a Skopas
Stéphane Verger nel chiostro di Michelangelo ha fatto eseguire interventi su sette teste di animali antiche (quattro di età adrianea e tre rinascimentali) e ne ha commissionata un’ottava a Elisabetta Benassi
Lo scavo condotto dalla Soprintendenza speciale di Roma ha riportato alla luce strutture in laterizio e un sontuoso apparato decorativo riconducibili a una committenza di altissimo rango, quasi sicuramente imperiale