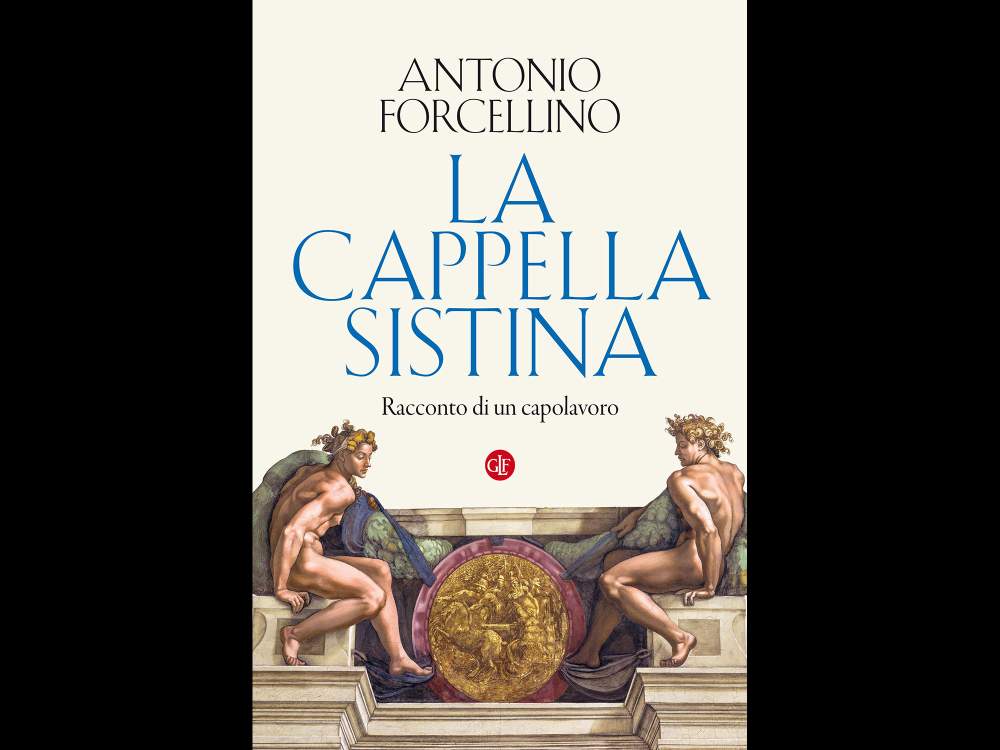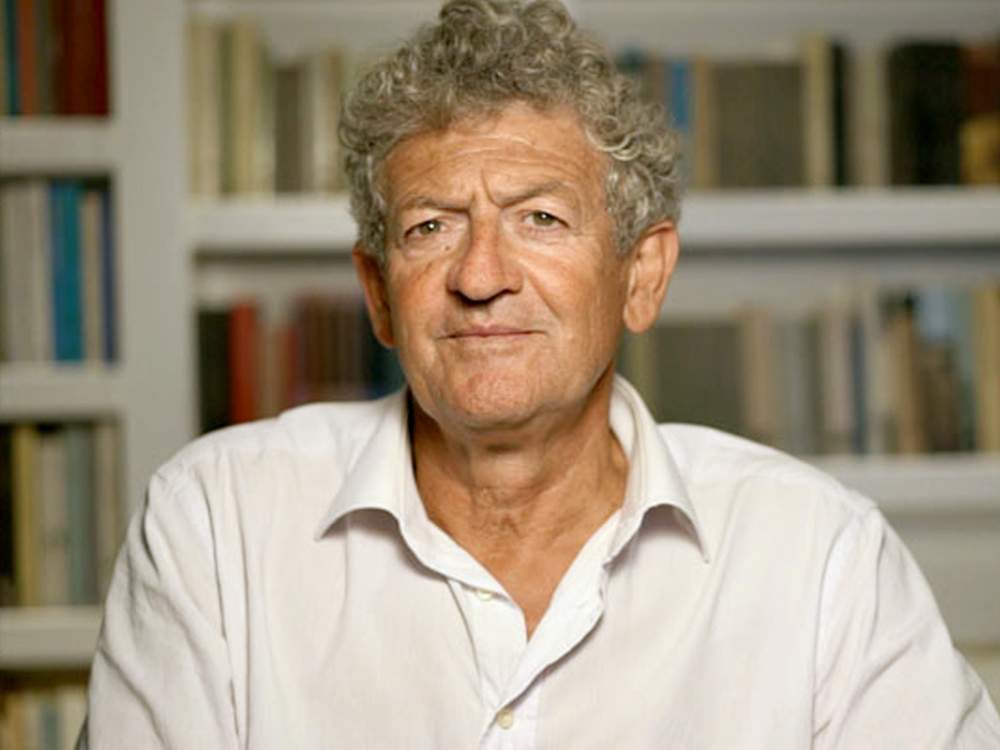Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Antonio Forcellino
Leggi i suoi articoliÈ molto difficile oggi immaginare la tristezza che avvolse Roma una sera di 500 anni fa, quando si sparse per la città immersa nei riti solenni del Venerdì Santo la notizia della morte prematura di Raffaello Sanzio. Il Papa aveva di continuo mandato i suoi famigli a casa dell’artista a prendere notizie sulla sua salute e molti si turbarono al punto da leggere nelle circostanze di quella morte (Raffaello era nato di Venerdì Santo) un segno sovrannaturale.
Oggi per noi, in conseguenza di una sfortuna critica che nell’ultimo secolo ha molto ridimensionato la sua figura, Raffaello è solo il pittore eccellente che ha resuscitato la bellezza e la grazia classica facendone un attributo commovente della devozione cristiana. Il pittore che riusciva a ritrarre uomini più simili a loro stessi nei suoi ritratti che in persona. Ma Raffaello era molto di più di tutto questo, era l’uomo che aveva saputo raccogliere le aspirazioni intellettuali di una intera società e trasformarle in immagini e in progetti di grande respiro.
Il più importante di questi progetti era quello di restituire la pianta antica di Roma, che significava penetrare consapevolmente non solo nell’arte antica ma nel Mondo Antico alla cui grandezza e felicità aspirava la Roma dei suoi giorni. Raffaello ci stava provando con l’aiuto del papa Leone X e dei maggiori studiosi di letteratura antica come scrive un testimone il giorno dopo la sua morte: «Dolse la morte sua precipue alli litterati, per non haver potuto fornire la descrittione e pittura di Roma antiqua che ’l faceva, che era cosa bellissima, pro perfettione della quale haveva ottenuto un breve del Papa che niuno poteva cavare in Roma, che non lo facesse intravenire».
I letterati piangono per primi la morte di un artista che era andato molto al di là del ruolo di artigiano a cui i pittori erano stati incatenati per secoli, diventando il punto di riferimento di tutti coloro che nella rinascita di Roma Antica vedevano le premesse necessarie per la costruzione di una società più giusta felice e pacifica, qualcosa che andava ben oltre la produzione di immagini seppure meravigliose. Come era potuto accadere tutto questo? Non possiamo dare una risposta semplice alla domanda, proprio perché Raffaello nell’ultimo secolo è stato mutilato della sua complessa personalità da una pubblicistica di massa a cui si è sottomessa anche la critica più raffinata.
A partire dalla metà dell’Ottocento, l’arte rinascimentale è stata riproposta al grande pubblico attraverso il racconto biografico degli artisti e in questo racconto i suoi grandi competitori, Leonardo e Michelangelo, hanno avuto la meglio perché le loro vite faticose risultavano più avvincenti rispetto alla vita solare di Raffaello. Ma a differenza degli altri due grandissimi artisti, Raffaello spinse molto più in là i territori dell’arte, investendo l’intera società della sua ricerca, iniziando per primo una condivisione intellettuale che lo portò a essere amico dei maggiori «letterati» del suo tempo.
Primo dei moderni, Raffaello aveva intuito che nella ricerca artistica si rispecchiavano esigenze più profonde di cambiamento e di conoscenza ed è per questo che celebrarlo solo come pittore oggi sarebbe diminuirne il valore. Nessun artista è mai stato al centro di una rete di relazioni tanto importanti come fu Raffaello; Leone X, Agostino Chigi, Castiglione e Bembo, sono solo alcune delle grandi figure che in quegli anni ne condivisero l’intimità e l’avventura.
Questa condivisione era già il segno di una rivoluzione intellettuale che dobbiamo all’intelligenza e alla sensibilità di questo giovane «veramente divino» come si diceva allora. Non c’è documento cinquecentesco che non accenni alla gentilezza e alla socievolezza di Raffaello, capace di suscitare quell’affetto che traspare da una lettera di Castiglione a sua madre: «Io sono sano, ma non mi pare essere a Roma, perché non vi è più el mio poveretto Raphaello».
Una intera città si identificava con l’artista il cui carattere amabile gli fu d’aiuto nel tessere le relazioni che fecondò con la sua intelligenza, facendo sì che le competenze di ognuno concorressero al progresso intellettuale di tutti, un’abilità che mise in atto con risultati straordinari, anche nel proprio atelier sviluppando il talento di assistenti che divennero poi grandissimi artisti. Questa capacità di eliminare i conflitti non solo nei suoi dipinti, dove tutto sembra confortare l’uomo e spingerlo verso orizzonti più alti e felici, ma nella sua attività intellettuale, è la qualità più straordinaria di Raffaello e oggi la meno celebrata, e questo è un grandissimo peccato, perché è la sua eredità più importante.
Questa aspirazione esaudita a una pienezza vitale è il grande lascito di Raffaello di cui oggi avremmo estremo bisogno per aggrapparvi quelle speranze di felicità individuale e collettiva che sembrano minacciate da una società che valorizza solo il conflitto e mai la sua ricomposizione. Le immagini di Raffaello per secoli sono stati gli argini eretti dal pensiero positivo contro il baratro dello sconforto e della disperazione a cui tutti, uomini e società, sono tentati di cedere nel corso della propria esistenza e tali restano a 500 anni dalla sua scomparsa.
Antonio Forcellino è architetto, restauratore e scrittore (Raffaello. Una vita felice, Laterza, 2009; Il fermaglio di perla. La grazia di Raffaello, Harper Collins, 2020)
Altri articoli dell'autore
Gli auguri della casa editrice con opere scelte dai suoi autori | Nell’«Adorazione dei Magi» per la confraternita dei Bianchi a Città della Pieve, la sostanza e la poesia del pittore umbro per i compaesani
Vi si cimentarono i massimi artisti del Rinascimento. Uno studio di Antonio Forcellino
Approvata dopo 24 anni una prima megalista di 6.600 restauratori