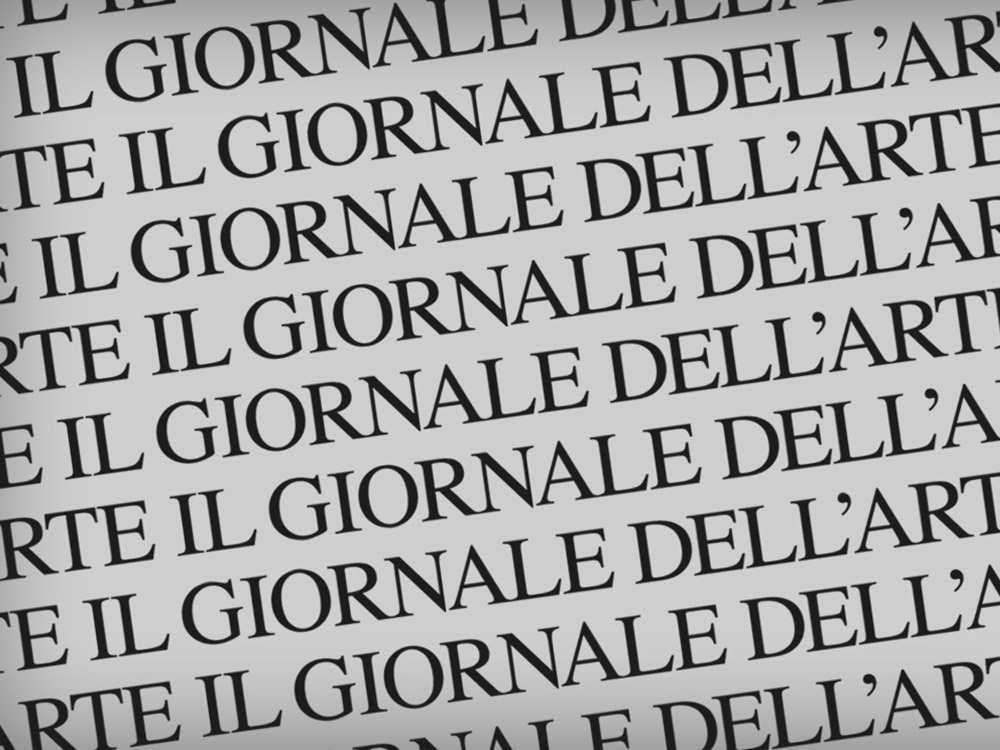Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Federico Castelli Gattinara
Leggi i suoi articoliRiapre il 17 marzo dopo 36 anni uno dei monumenti più importanti al mondo per la storia dell’arte altomedievale e bizantina, Santa Maria Antiqua al Foro Romano, chiusa al pubblico nel 1980 (a parte qualche sporadica visita straordinaria)
La chiesa ha una vicenda complessa e particolarissima: costruita alla metà del VI secolo venne abbandonata tre secoli dopo a causa del terremoto dell’847, quindi dimenticata, sepolta e riscoperta circa mille anni dopo da Giacomo Boni nel 1900, a parte l’accidentale ritrovamento dell’abside documentato da un famoso acquarello di Francesco Valesio del 1702. Boni demolì la soprastante chiesa barocca di Santa Maria Liberatrice, tirò fuori l’antica chiesa, la protesse con un tetto a capriate e restaurò gli affreschi, una raccolta di 250 mq di intonaci decorati sovrapposti, relativi principalmente ai papi Martino I, Giovanni VII, Zaccaria e Paolo I, con tracce di pitture romane, impiantandosi la chiesa nell’ampliamento della domus Tiberiana creato da Caligola e ricostruito da Domiziano alla base del Palatino.
I restauri recenti partono nel 1984 (fino al 1989) durante la Soprintendenza di Adriano La Regina e a occuparsene sono gli architetti Giuseppe Morganti, grazie al quale oggi si riapre, insieme a Francesco Scoppola, attualmente a capo della direzione generale Belle arti e Paesaggio. Allora si rivedono le coperture per eliminare le tante infiltrazioni, si rinforza e impermeabilizza il tetto degli anni Dieci, la terrazza intorno, gran parte degli infissi, le gronde, le tettoie per proteggere gli affreschi restaurati dall’Iccrom ma rimasti all’aperto nell’atrio antistante alla chiesa.
Il discorso si riapre nel 2001, con finanziamenti statali e del World Monuments Fund. Da allora e fino al 2013 si risanano tutti gli affreschi. Dai brani staccati e restaurati da Boni vengono tolte le stuccature in cemento e rifatti i supporti in fibra di carbonio, quindi rimontati in situ in maniera del tutto mimetica. Nella cappella a sinistra del presbiterio, dedicata a Teodoto, tutta la parte bassa della parete meridionale staccata nel 1947 e nel 1954 per via dell’umidità e conservata nell’Antiquarium forense di Santa Maria Nova (Santa Francesca Romana) è ritornata al suo posto.
A livello strutturale, si è affrontato il problema dell’umidità di risalita, specie nella zona presbiteriale che sorge a ridosso degli Horrea Agrippiana (i magazzini di Agrippa), risolto definitivamente solo di recente con l’aiuto di Ippolito Massari, grande esperto del campo: vexata quaestio (il colle è composto da uno strato di argilla sormontato dal tufo), come dimostra il «taglio» alla base delle murature domizianee con una lastra di travertino, ben visibile nell’atrio. Rifatti anche infissi e coperture della zona di fondo (l’abside e le cappelle), sistemata la grande aula occidentale tradizionalmente identificata come il templum Divi Augusti, su cui però ci si potrà solo affacciare, riaperto il collegamento tra la chiesa, che Giovanni VII probabilmente usò come cappella palatina, e la rampa di Domiziano, che ospiterà dei reperti. Sì, perché l’apertura sarà affiancata da una mostra (fino all’11 settembre) ideata da Maria Andaloro e curata da lei insieme a Giulia Bordi e Giuseppe Morganti.
Per la prima volta torneranno l’icona della chiesa oggi a Santa Maria Nova (per tre mesi) e il frammento d’intonaco con sant’Agata attualmente in collezione privata, pubblicato da Toesca e vicino alle pitture dell’attiguo Oratorio dei Quaranta Martiri. E ancora busti dei personaggi dell’epoca, quattro dei dieci mosaici dell’ex oratorio di Giovanni VII di San Pietro ora divisi tra Vaticano e Santa Maria in Cosmedin, video ricostruttivi delle decorazioni parietali e altro.
Alla collaborazione con l’Università della Tuscia di Viterbo si deve il restauro recentissimo dei cinque sarcofagi romani interni alla chiesa, di riutilizzo medievale. Nel corso degli interventi dal 2001 a oggi non ci sono state novità eclatanti, ma importanti acquisizioni sia sulla successione delle fasi e l’attribuzione ai vari pontefici dei singoli strati, sia sul piano delle tecniche esecutive, come nel caso delle tracce d’oro zecchino sulle figure della celebre parete palinsesto.
Conclusa la chiesa, i lavori futuri riguarderanno l’atrio, di cui a oggi sono stati revisionati gli affreschi e verificate le murature. Prossimi passi, le pitture mai restaurate di quando l’aula fu convertita in oratorio dedicato a sant’Antonio (XI secolo), la mostra dei frammenti architettonici di Santa Maria Antiqua ancora nei magazzini, una copertura leggera per eliminare le tettoie, forse un velario come nel cortile di Palazzo Altemps.
Altri articoli dell'autore
Tra Foro Romano e Palatino sono stati ritrovati i resti di una lussuosa dimora con una sala per banchetti a forma di grotta e uno straordinario mosaico impreziosito con conchiglie, vetri e tessere blu egizio
Si inizia con l’enigmatico scultore ateniese. Altre due monografiche saranno dedicate a Prassitele e a Skopas
Stéphane Verger nel chiostro di Michelangelo ha fatto eseguire interventi su sette teste di animali antiche (quattro di età adrianea e tre rinascimentali) e ne ha commissionata un’ottava a Elisabetta Benassi
Lo scavo condotto dalla Soprintendenza speciale di Roma ha riportato alla luce strutture in laterizio e un sontuoso apparato decorativo riconducibili a una committenza di altissimo rango, quasi sicuramente imperiale