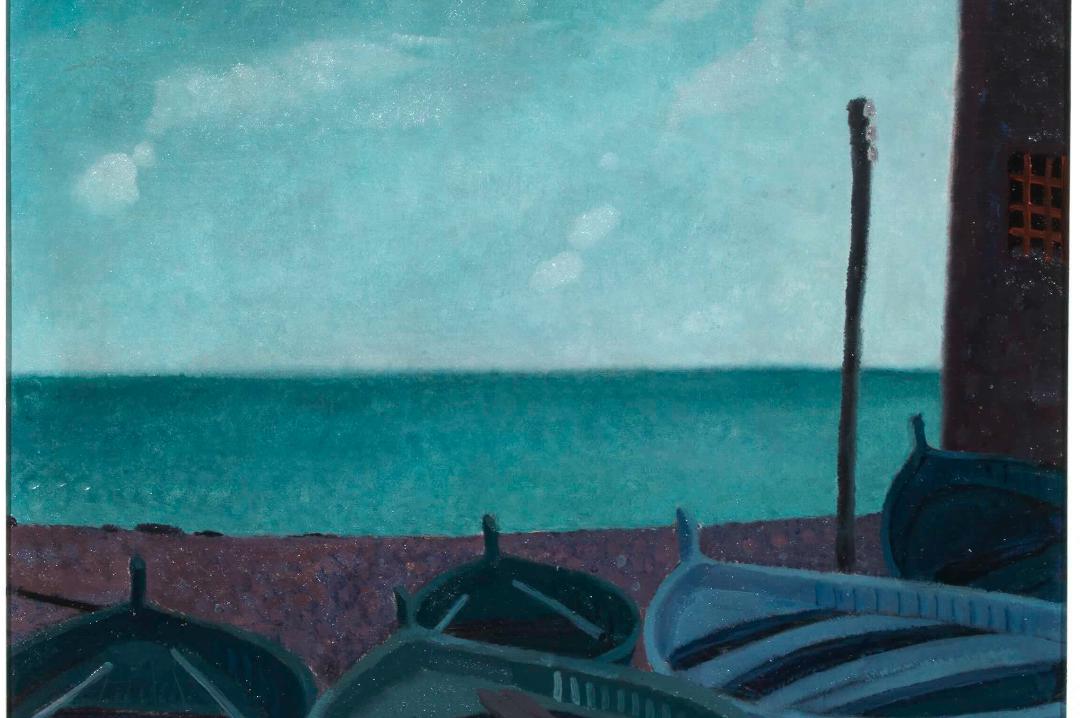Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Era il 1958 quando nel Palazzo Reale da poco risanato dalle ferite della guerra si apriva la grandiosa mostra (500 numeri di catalogo) «Arte lombarda dai Visconti agli Sforza», curata da Gian Alberto Dell’Acqua e Roberto Longhi. In una Milano che si risollevava dopo il conflitto, quella mostra, che rivendicava alla Lombardia un’identità culturale e un’autonomia espressiva che sino ad allora le erano state negate, assunse i contorni di un riscatto e, aggiunge Mauro Natale, «continuò a trasmettere per decenni un’idea positiva di rigore etico e di ottimismo».
Ecco perché oggi, a quasi sessant’anni da allora, lo stesso Mauro Natale e Serena Romano hanno voluto dare l’identico titolo alla mostra da loro curata, ideata e coprodotta da Skira con il Comune di Milano e Palazzo Reale. Da allora gli studi sono molto avanzati (molte le scoperte, i restauri, le nuove datazioni e attribuzioni), lo status di «regione geograficamente compatta e politicamente strutturata» per la Lombardia del Tre e Quattrocento è acquisito e la mostra di oggi (dal 12 marzo al 28 giugno), ricca di 250 selezionati pezzi, può compiere un’indagine ben più affilata su quella materia, allora esibita senza partizioni dal primo Trecento all’ultimo Quattrocento, scandendola in sezioni intitolate ai diversi signori della dinastia visconteo-sforzesca.
Spiega Mauro Natale: «Si è voluto porre l’accento sulla committenza ducale; restituire il proprio ruolo a ciascuno degli esponenti dei Visconti e degli Sforza, da Azzone, che chiamò Giotto a Milano, a Ludovico il Moro, che chiamò Leonardo e Bramante, evidenziando come a ciascuno corrisponda un diverso orientamento culturale. Al tempo stesso si sono messi in luce i rapporti, politici e culturali, che legavano Milano alle altre capitali del tempo». «I Visconti, argomenta Serena Romano, accompagnarono la svolta politica da loro impressa a Milano e alla Lombardia con un deliberato programma architettonico e artistico, con cui presero assai per tempo a rivaleggiare con le altre corti italiane: ci sarà in mostra, tra gli altri, un affresco staccato dal Palazzo Vescovile di Giovanni Visconti, zio di Azzone e suo successore, che fu staccato da un ciclo di cui ho ritrovato altri frammenti nelle soffitte del Palazzo Arcivescovile. È databile al 1340 e, dedicato com’è alla fondazione di Roma, illustra in modo esemplare il programma di comunicazione dispiegato dai Visconti nei loro meravigliosi palazzi, di cui purtroppo non resta che una pallida immagine. Con questa datazione si rende così giustizia alla precocità dell’arte lombarda, a lungo considerata ancillare rispetto a quella toscana».
I due secoli esplorati dalla mostra sono fra i più felici e fecondi della storia lombarda; una sorta di «età dell’oro» in cui si produssero dipinti e sculture, oreficerie e miniature, vetrate e arredi di un tale livello che nelle fonti del tempo l’espressione «ouvraige de Lombardie» è intesa come attestato di qualità, quasi un «made in Italy» ante litteram. Fra le novità della mostra, nella prima sezione si vedono le uniche vetrate lombarde del Trecento, da Bergamo: siamo prima dei tempi di Azzone, che chiamerà in città Giotto e Giovanni di Balduccio, toscano anch’egli e sensibile alla cultura francese.
La mostra esibisce qui una spettacolare parata di sculture sue, del Maestro di Viboldone e di Bonino da Campione e squisiti manoscritti miniati, oltre a tavole e affreschi di Giovanni da Milano e Giusto de’ Menabuoi. Con il 1400, e con Gian Galeazzo, ci si affaccia al gran cantiere cosmopolita del Duomo (un biglietto congiunto permette di visitare la sezione tardogotica del contiguo Museo del Duomo), di cui sono eccezionalmente esposte tre sculture calate da un pilastro e alcune vetrate su cartoni di Michelino da Besozzo altrimenti non godibili, insieme a manoscritti di Giovannino de’ Grassi e al «Libro d’ore», da Avignone, anch’esso di Michelino (la biblioteca viscontea di Pavia era una delle più ricche e preziose del tempo).
Un punto di grande interesse per gli studiosi è la possibilità di verificare la discussa attribuzione della «Madonna del Roseto» di Castelvecchio a Verona, qui accostata alla «Madonna in trono» di Stefano da Zevio, della romana Galleria Colonna, e a quella attribuita ora a Stefano, ora a Michelino, da Palazzo Venezia a Roma. In questa occasione si ricostituiscono poi, dopo secoli, un dittico di Franceschino Zavattari diviso tra Praga e gli Stati Uniti e, per gli anni di passaggio dai Visconti agli Sforza, un trittico di Bonifacio Bembo smembrato tra Cremona e Denver; viene inoltre riunita per la prima volta attorno alla «Madonna» della Collezione Cagnola (Gazzada Schianni, Va) anche l’opera del pittore di corte di Galeazzo Maria Sforza, Zanetto Bugatto, artista sfuggente e misterioso che Bianca Maria Visconti inviò nelle Fiandre per impadronirsi della tecnica della pittura a olio. Un’altra importante novità rispetto al 1958 è «la grande attenzione prestata all’eccellenza manifatturiera delle botteghe lombarde che, commenta Natale, rivaleggiavano nelle oreficerie e negli smalti con i migliori artefici parigini»: in mostra lo provano la serie di statue d’argento del Tesoro del Duomo di Vercelli, il celebre «Reliquiario degli Innocenti» del Museo di Sant’Ambrogio e alcune delle realizzazioni più spettacolari degli orefici e smaltatori milanesi della fine del Quattrocento, nei quali si scorge la comune radice formale con dipinti, sculture, miniature, vetrate e oreficerie, come accade anche con la scultura lignea, questa riportata all’attenzione da studi recenti. L’età di Ludovico il Moro, infine, illustrata contemporaneamente a Palazzo Reale dalla mostra di Leonardo (dal 15 aprile) e alla Pinacoteca di Brera dall’omaggio a Bramante (cfr. Il Giornale dell’Arte n. 348, dic. ’14, p. 29), è rappresentata qui da splendide vetrate del Duomo e da dipinti di Bernardino Butinone, Foppa, Zenale, Bergognone e dei leonardeschi Boltraffio e Ambrogio de Predis, con i quali si chiude questo luminoso, largo percorso lombardo tra Gotico, Tardogotico e Rinascimento.
Articoli correlati:
A Milano più regista che architetto

«Adorazione dei Magi» (1445-50) di Bonifacio Bembo dal Denver Art Museum

«Madonna con Bambino» di Bonino da Campione (Fondazione Irccs Ca’ Grande Ospedale Maggiore Policlinico di Milano)

«Ghepardo» di Antonio Pisanello dal Louvre di Parigi;

Affresco con «Scena di giudizio» dal Palazzo Arcivescovile di Milano

«Madonna del Roseto» di Michelino da Besozzo (attr.) dal Museo di Castelvecchio di Verona
Altri articoli dell'autore
In attesa della nuova edizione del progetto a giugno, è esposta una selezione delle 100 opere allestite in altrettanti borghi italiani
La galleria Tornabuoni Arte di Milano ospita un percorso che affianca undici opere di Felice Casorati a dipinti di artisti a lui affini per tematiche e atmosfere
Dal 30 aprile nel comune di Bellano trova casa, grazie alla donazione della famiglia, l’intero corpus grafico e un centinaio di dipinti dell’artista scoperto nel 1983 da Giovanni Testori
Per molti anni ripudiate dai critici e dagli stessi designer («escluse le “tre M” Mari, Munari e Mendini), le affinità elettive tra design e arte sono indagate dall’istituzione milanese