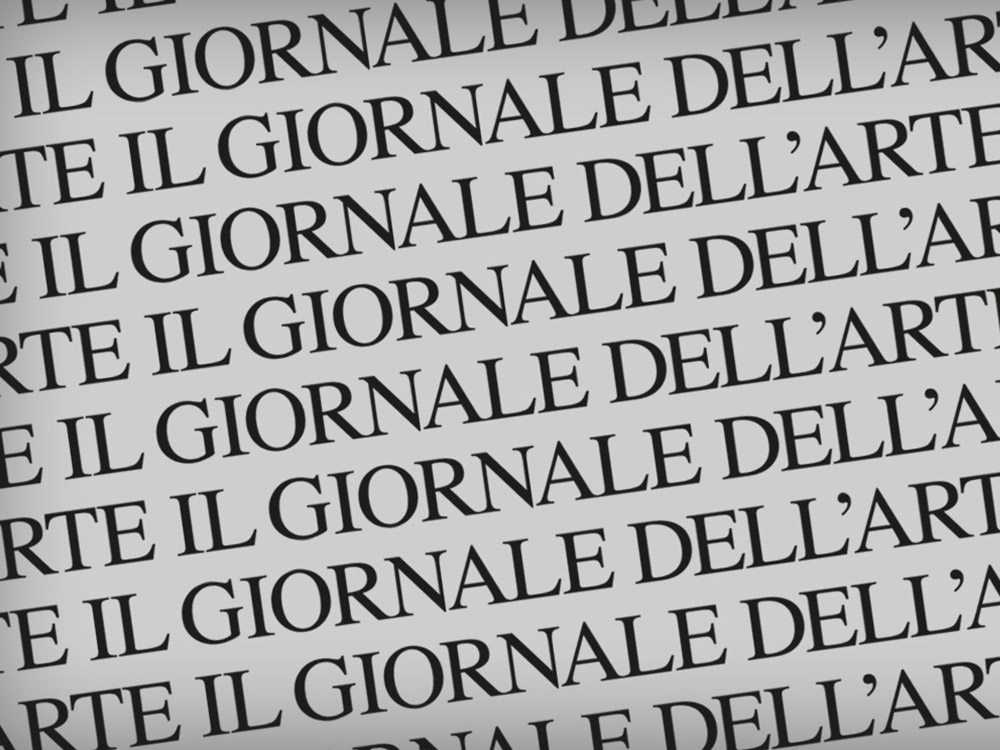Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Stefano Miliani
Leggi i suoi articoliAi suoi studenti vuole insegnare che quando leggiamo, andiamo a una mostra o vediamo un film, fuggire da tutto ciò che è «complesso» a favore di una vera o presunta facilità è una scelta dalle conseguenze dannose, perché esclude il pensiero critico.
Gabriele Pedullà (Roma, 1972), docente di Letteratura italiana all’Università Roma 3, studioso di Fenoglio e Machiavelli, in un articolo sulla «Domenica» de «Il Sole 24 Ore» del 6 novembre scorso ha tracciato una convergenza tra «populismo politico» e «populismo estetico» che, in nome di un «Nuovo Senso Comune», vuole bandire ogni difficoltà dell’arte dal nostro orizzonte: ha quindi preso di petto un termine che invade le cronache internazionali e lo ha esteso alla cultura. Nell’arte, ad esempio, ritiene sia mero conformismo adagiarsi solo su grandi nomi da esibizioni blockbuster alla Leonardo o Van Gogh. Narratore lui stesso, dopo il libro di racconti Lo spagnolo senza sforzo del 2009 Pedullà pubblica in questo inizio d’anno per Einaudi il romanzo Lame su un gruppo di pattinatori non più giovani che si confronta con la propria adolescenza.
Con il suo articolo su «populismo politico» e «populismo estetico» intende dire che domina l’idea di un «consumo» di prodotti culturali facilmente abbordabili negando libri, opere d’arte visiva o film quando presentano aspetti di complessità nel recepirli?
È così. Il sistema delle arti è sempre stato stratificato: nel Novecento al vertice c’erano le opere più originali e importanti, nonché, spesso, anche le più impegnative, che nella stagione delle avanguardie faticavano a farsi apprezzare e talvolta si ponevano in aperta polemica con l’arte ufficiale. C’erano poi le opere più tradizionali, o comunque meno aggressive e sovversive, ispirate a criteri di buon gusto facilmente comprensibili al pubblico educato. E c’erano, infine, le opere apertamente di consumo: dal film d’azione al romanzo giallo sino alla litografia con pagliaccetto triste da appendere in salotto. Oggi assistiamo a una crescente intolleranza verso quello che una volta era il livello superiore: un’intolleranza tanto più pericolosa perché, parrebbe, condivisa da alcune delle stesse istituzioni culturali che nel XX secolo avevano promosso l’alta cultura, a seconda dei casi nella sua versione più conciliata e in quella più sovversiva. Oggi non conta produrre una nuova visione originale, che allarghi e approfondisca la nostra percezione, ma incontrare rapidamente il gusto dei più, riconfermandoli nelle loro attese. Se una volta un grande scienziato e un grande artista facevano la stessa cosa, cercando di penetrare le leggi dell’universo e della vita attraverso tecniche sofisticatissime, oggi al grande artista si chiede di ragionare in termini statistici: non alla ricerca della risposta migliore ma di quella che il maggior numero di persone riterrà tale. Non illudiamoci: gli autori ambiziosi hanno sempre avuto vita difficile. Ma nel XX secolo l’intolleranza nei confronti delle loro «stranezze» è stata meno dannosa, perché oggi anche molte di quelle istituzioni e di quelle figure allora pronte a difendere gli esperimenti più azzardati o il perpetuarsi della memoria dei capolavori del passato sembrano condividere l’idea che ci si debba conformare tutti a un livello medio di fruibilità, come nel caso del Nobel a Bob Dylan. È come se queste istituzioni e queste figure, che una volta contribuivano a bilanciare (e talvolta a indirizzare) i gusti del grande pubblico, oggi cercassero di giustificare la propria stessa esistenza assegnando a posteriori un «bollino di qualità» a quello che si è già imposto in forza dei numeri. Il critico che si adegua a questo meccanismo diventa un mero pr.
Lei sostiene che anche chi dice, in politica, di non volere il «populismo» e di combattere le «forze antisistema», di fronte ai prodotti culturali fa «grancassa dell’insofferenza verso qualsiasi forma di arte sofisticata». Perché lo definisce «populismo estetico»?
Come definire altrimenti Matteo Renzi che, davanti al Nobel a Dylan, commenta su Twitter: «La poesia vince sempre»? L’antipopulista in politica che è populista in estetica sembra a prima vista una contraddizione, ma rappresenta invece una figura sempre più diffusa, perché in lui i due atteggiamenti si uniscono nel rifiuto a priori di tutto ciò che implica una contestazione del presente: al livello di gusto e di sistema di potere. Così, gli stessi commentatori che in occasione della Brexit hanno affermato perentoriamente che i cittadini non dovrebbero potersi esprimere su nessuna questione rilevante, ogni qual volta si discute di un’opera d’arte si affrettano a proclamare l’infallibilità dell’uomo della strada. Lo si è visto bene proprio nel caso dell’ultimo Nobel letterario.
Oggi si identifica un’opera «complessa» con «astrusa»? O (e per molti è peggio) rivolta solo alla categoria piuttosto indefinita degli «intellettuali»?
L’anti intellettualismo è uno dei tratti caratteristici del nostro tempo: il sospetto nei confronti dell’esperto, cioè di colui che ha dedicato anni di vita a studiare una determinata questione, a vantaggio del presunto buon senso (che spesso è semplice ignoranza) dell’uomo della strada. Dunque tutti a gridare in coro con Fantozzi che «La corazzata Potëmkin» è una cagata pazzesca! In questo, la polemica contro gli intellettuali assomiglia a quella contro i vaccini: e non è meno dannosa per il corpo sociale.
A quale tipo di opere guarda, all’interno di questo discorso?
Tra le opere che assecondano il pubblico, quelle che lo rifiutano sdegnosamente e quelle che non rinunciano a raggiungerlo ma alle proprie condizioni, ho una netta predilezione per queste ultime. Mi ha sempre colpito una riflessione di Italo Calvino, che sostanzialmente diceva: il problema non è trovare dei lettori scrivendo un altro libro costruito sulle convenzioni più trite, ma conquistarseli a uno a uno e portarli a fare un’esperienza intellettuale diversa.
È però essenziale comprendere quanto accade. Restando all’Italia, che cos’è successo?
La colpa è dell’industria culturale. Il termine fa molto Adorno e anni Sessanta, ma così è. Per questo non è possibile fare un’analisi della trasformazione del sistema senza un’analisi di come è mutato il capitalismo negli ultimi quarant’anni, ad esempio la sua tendenza a inseguire profitti istantanei in linea con la generale finanziarizzazione delle ricchezze. In Italia, per il mercato librario una grande responsabilità è ascrivibile alla distribuzione e alle catene librarie, Feltrinelli in testa. Rispondono tutte a una logica di redditività di corto respiro. E poiché, da un punto di vista economico, è più conveniente vendere venti copie dello stesso libro o dvd che due di dieci libri o dvd diversi, sono inevitabilmente schiacciate sui best seller: e così sarà in futuro se non ci diamo una seria regolamentazione come quella che in Francia sta ritardando la distruzione dell’ecosistema letterario.
E nell’arte?
Non succede qualcosa di simile anche con le mostre? Non siamo anche qui saturi di un’offerta culturale che ruota tutta attorno ai tre poli del «Genio rinascimentale» (Leonardo o Michelangelo), dell’Impressionismo e della Pop art? E che dire del teatro italiano, dove il repertorio nazionale non si schioda da Goldoni, Pirandello ed Eduardo? L’ideologia del mercato sta producendo un vero genocidio culturale.
Lei scrive: «Per dire no ai veri populismi, distinguere rimane essenziale. E che lo si possa fare solo restituendo alla dimensione estetica il posto che merita nel discorso pubblico è anche un modo di ricordarci che l’arte non è solo intrattenimento o riempitivo». Che cos’è, allora, l’arte? O meglio: come ha chiesto «Il Giornale dell’Arte» ai suoi lettori e in convegni internazionali, a che cosa serve l’arte?
L’arte fa tante cose. Nei casi migliori mi aspetto un potenziamento delle mie capacità conoscitive ed emotive. Commuovendomi, ridendo e ragionando, comprendo qualcosa che non avrei capito altrimenti o che avrei capito molto più tardi. Una grande opera d’arte accelera la mia maturazione di essere umano e talvolta ne orienta lo sviluppo in direzioni imprevedibili: mi consente di accumulare un’esperienza millenaria, e non solo perché oggi seimila anni di produzione artistica sono virtualmente accessibili a chiunque o perché, attraverso il cinema, il teatro e la televisione, posso vivere per interposta persona migliaia di altre esistenze. L’arte è un acceleratore: ci restituisce decuplicato il tempo che le dedichiamo. Affinché questo succeda, però, deve essere grande arte. E a volte, certo, questa grande arte è anche difficile: necessariamente (almeno all’inizio). Ma è proprio questo ostacolo che fa gridare i populisti estetici alla noia, all’assurdità e alle presunte conventicole.
La sua riflessione è scaturita anche dal confronto con i suoi studenti all’università?
A Roma Tre a un dibattito sul Nobel a Dylan organizzato da Luca Pietromarchi ho spiegato chiaramente agli studenti le ragioni della mia contrarietà leggendo in parallelo il testo (imbarazzante) di una sua splendida canzone, «Love Sick», e una poesia di argomento affine di Valerio Magrelli. Tolta la musica, come scrittore Dylan semplicemente non esiste. Che il Nobel sia andato a lui e non a Magrelli (o a qualche poeta del suo valore) è un altro effetto nefasto del populismo estetico. Potrei dire che tutta la mia attività di docente è indirizzata a formare gli studenti alla complessità.
Altri articoli dell'autore
Nuova pavimentazione, nuovi lampioni e una nuova, contestata pensilina: i lavori, costati 7,5 milioni, scatenano discussioni e malumori
Nella Rocca Albornoz e a Palazzo Eroli, a Narni, una settantina di sculture di uno dei maestri del Nouveau Réalisme per riflettere sul rapporto tra alto artigianato e creazione artistica
Il 6 aprile avrà luogo una commemorazione in ricordo delle 309 vittime del terremoto del 2009. Diamo conto della condizione di alcuni monumenti: il Castello spagnolo, le mura urbiche presso porta Brinconia, la Chiesa di San Marco e Palazzo Centi
La «culla» del francescanesimo era a rischio in quanto la soprastante cupola della Basilica di Santa Maria degli Angeli era preoccupantemente fessurata dal terremoto del 2016