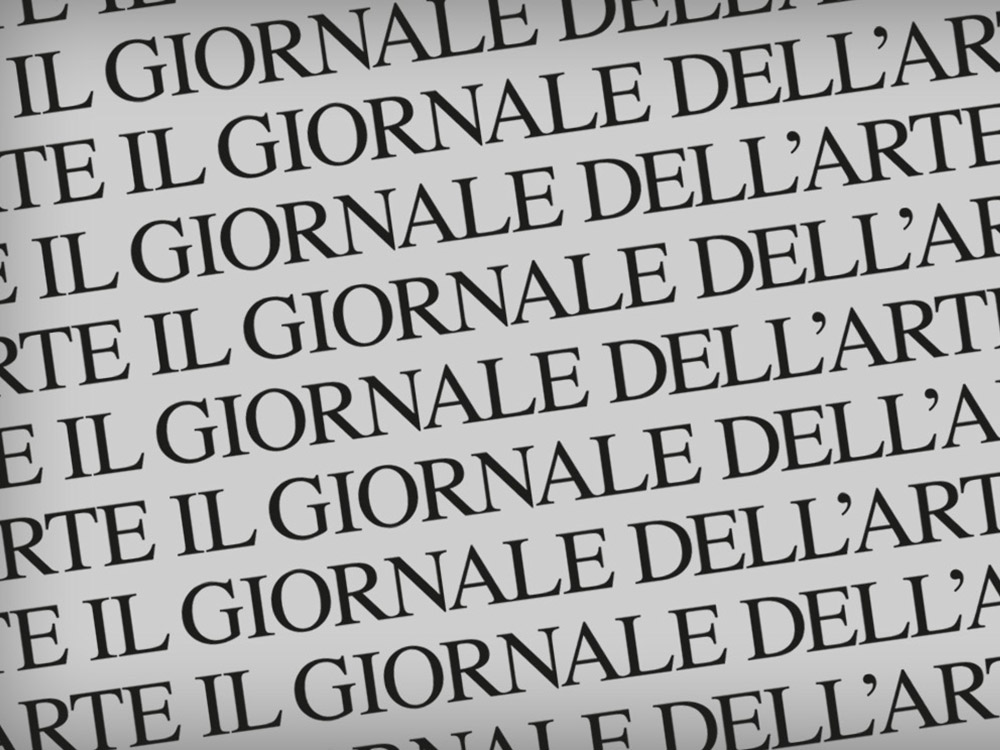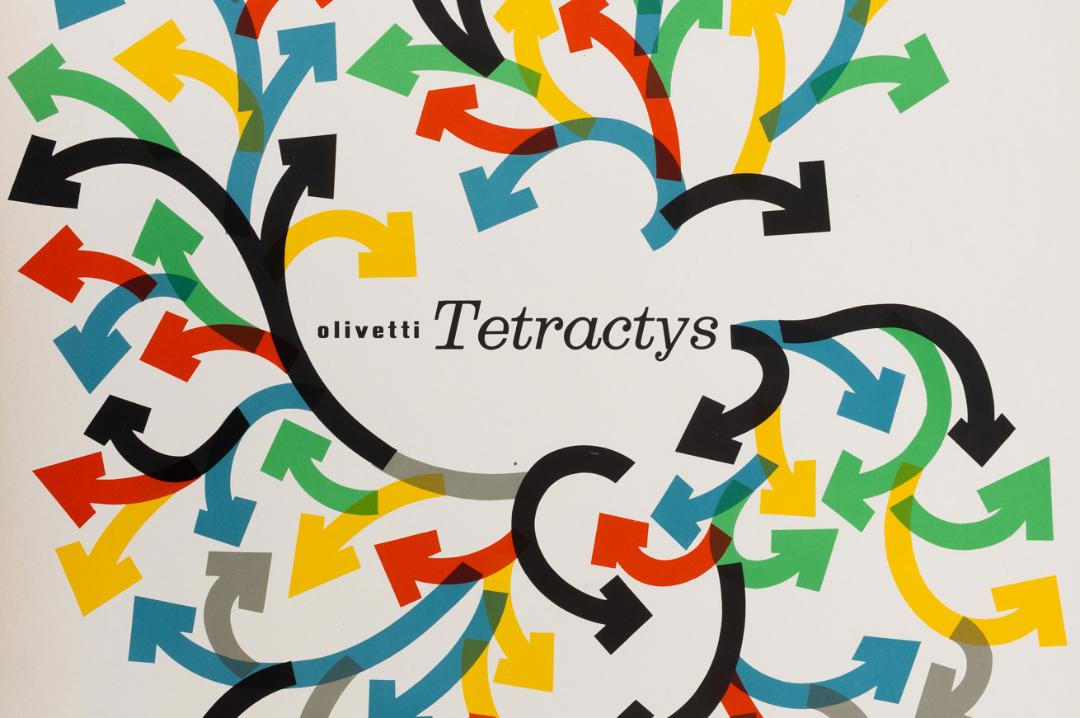Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Mariella Rossi
Leggi i suoi articoliDirettore del Muse, il Museo delle Scienze di Trento che con 1,5 milioni di visitatori in tre anni è tra i dieci musei più visitati d’Italia, Michele Lanzinger fa il punto sul panorama culturale regionale, auspicandone uno sviluppo fatto sempre più di partecipazione e meno di grandi eventi.
Qual è la situazione culturale in Trentino-Alto Adige?
L’Unesco definisce la cultura come «insieme di valori materiali e immateriali e di espressioni (che le popolazioni identificano come riflesso della loro identità) meritevoli di tutela e valorizzazione e da trasmettere alle generazioni future». Dunque una dimensione partecipativa della cultura, sia in termini di fruizione sia di produzione. Il nostro territorio è molto attivo nella musica e nel teatro grazie a un sistema scolastico e sociale che sostiene attività collettive come scuole musicali, bande, cori e teatri vernacolari. Diversa la situazione delle arti visive. Abbiamo istituzioni internazionali, il Mart, il Museion e il Castello del Buonconsiglio, e altre declinazioni di rilievo tra cui, in Trentino, Arte Sella, Museo Alto Garda e Galleria Civica di Trento, strutture più legate al territorio che esprimono la capacità di coinvolgere il luogo. Gli artisti della regione, al di là di rare eccellenze, sono assenti. Mancano hub di creatività giovanile anche se stanno via via comparendo. La generazione Erasmus aiuterà il territorio ad agganciarsi alle dinamiche europee facendo dell’arte contemporanea un elemento imprescindibile per la crescita di una comunità.
Il patrimonio naturale fa da traino alla cultura?
Il sistema paesistico e naturale del Trentino è un luogo eccellente per il tempo libero dei residenti ed è il principale attrattore turistico. I luoghi della cultura, prevalentemente concentrati nei principali centri urbani, vivono di una stagionalità in un certo senso opposta rispetto alle frequentazioni turistiche. Questa doppia prospettiva, naturale e culturale, è un valore aggiunto.
È diversa l’offerta culturale di centri e periferie?
Questa regione non ha aggregazioni urbane così rilevanti da segnare un sostanziale divario demografico e sociale tra centro e periferia. La capillare presenza di biblioteche di borgo, sale per musica o teatro e spazi espositivi distribuisce uniformemente sul territorio una certa presenza di attività culturali. L’opportunità di creare eventi e spazi espositivi in rapporto alla frequentazione turistica ha generato a sua volta una diffusione di centri culturali sul territorio. Ciò nonostante la centralità logistica di centri come Bressanone, Bolzano, Trento e Rovereto ha fatto assumere a queste città (già storicamente) il ruolo di attrattori culturali. L’interdipendenza tra centro e periferia è uno dei temi centrali per gli attori e le istituzioni culturali del territorio.
Gli ostacoli fisici tra le vallate alpine costituiscono un fattore di isolamento culturale?
L’accelerazione fornita dalle nuove tecnologie crea una base culturale comune, stratificata per età, genere e situazione sociale. Le differenze culturali locali sono ricondotte piuttosto agli orizzonti organizzativi e partecipativi che scontano le difficoltà di connessione. Il sistema di produzione e consumo locale opera ancora a livello di comunità di valle, ma partecipa alla dimensione globalizzante della società contemporanea e sviluppa relazioni con i maggiori centri abitati e le città capoluogo.
Come si può valorizzare l’ampio patrimonio storico regionale, già tutelato e restaurato?
È un tema comune a tutto il sistema culturale italiano, che soffre di eccesso di offerta. Il patrimonio va difeso e tutelato secondo una logica di sviluppo e conservazione durevole, coinvolgendo la cittadinanza locale in una dimensione di tutela partecipata che contribuisce ad alimentare un sentimento di appropriazione e identificazione con il patrimonio, che a sua volta deve entrare a far parte di una logica di sviluppo. Network, distretti culturali evoluti, sviluppo di forme di lavoro parziale, stagionale, rivolte ad ampie categorie di cittadini, sono tutti meccanismi per entrare in una dimensione affine al terzo settore, per diversificare e sostenere la promozione del patrimonio presso i diversi pubblici.
Come sono i rapporti tra le città dell’Euregio (Tirolo, Alto Adige, Trentino)?
Le questioni del Passo del Brennero sono più vicine alla dimensione politica che all’effettivo impatto sul territorio. Lungo l’asse del Brennero ci sono interessanti esempi di pratica culturale con un gradiente di relazioni che si riduce al comparire della barriera linguistica (italiano-tedesco). Ci sono ampi margini di miglioramento per una visione davvero transfrontaliera, capace di rappresentare unitariamente le terre di confine. Le nuove generazioni, che padroneggiano l’inglese e il tedesco grazie alla politica di trilinguismo attivata dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano, potranno sviluppare interazioni culturali più incisive.
Le differenze culturali sono un ponte o un ostacolo in un clima sociale e politico che mette a rischio Schengen?
Il tema della frontiera è un tema specifico, sottoposto alle contingenze politiche e all’effettivo manifestarsi di pressioni al valico. La vera questione è piuttosto l’affievolirsi di un progetto europeo capace di annullare il concetto stesso di frontiera, di ricercare le motivazioni di avvicinamento, partecipazione e scambio in opposizione alle istanze divisive, l’esperienza dell’Euregio in questo senso è esemplare. La pratica culturale potrebbe essere uno dei migliori ponti di connessione e di scambio tra le comunità a nord e a sud di questo confine.
Quali sono gli effetti dei tagli alla cultura?
La Regione, con le due Provincie autonome, negli anni precedenti la crisi ha disposto di risorse importanti sia sul fronte delle strutture sia su quello del finanziamento corrente. Oggi la situazione è cambiata, c’è una contrazione delle risorse che si riflette sul settore culturale. I segnali di risposta sono già presenti. Tra questi una maggiore attenzione alla costruzioni di reti che permettano l’emergere di economie di scala, una maggiore attenzione alla tariffazione e, non ultimo, la partecipazione a bandi promanati da fondazioni bancarie e dalla Comunità europea.
Come immagina il futuro?
Il futuro, per definizione, bisogna inventarselo. La resilienza di un sistema, compreso il superamento di fasi di stagnazione delle risorse economiche, si declina anche nella capacità di modificarsi tenendo fermi gli elementi di valore, ma senza ingessare il sistema, impedendo lo sviluppo e l’affermazione di energie nuove. In un mondo dove tutto cambia velocemente, il futuro può preoccupare chi lo osserva con una logica conservativa, viceversa, può essere pieno di opportunità per chi sa guardare agli spazi di azione offerti da un divenire in costante accelerazione. Come per la società anche per la cultura vi è da prevedere un allargamento della forbice tra le grandi iniziative dotate di bilancio, capacità di comunicazione e di rilevo economico per il territorio, e una dimensione basale, comunitaria, partecipativa, sociale, inclusiva, flessibile e creativa. In difficoltà le dimensioni intermedie, retaggio di un periodo di maggiore floridezza economica e non sufficientemente dotate di supporto finanziario e partecipativo.
Altri articoli dell'autore
I monumenti di eroi italiani ed europei dell’artista ottocentesco, esposti nel museo di Mendrisio, accolgono un’inedita e colorata installazione della giovane indiana
Con l’impegno della direttrice Stella Falzone, il MArTA aiuterà la città pugliese a cambiare pelle e a riprendere il suo ruolo dominante nel panorama archeologico nazionale e internazionale
Al m.a.x. museo e allo Spazio Officina una panoramica di designer, pittori e creativi
Dopo Ruth e Giancarlo Moro, nella città ticinese una serie di appuntamenti all’insegna dell’arte contemporanea