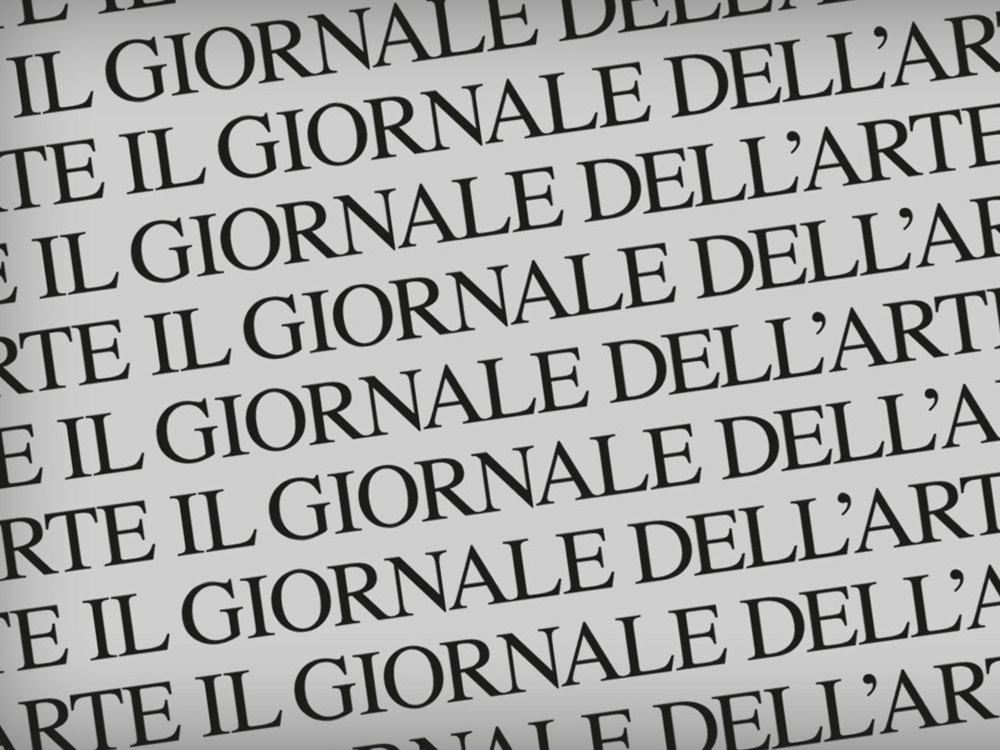Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Fabrizio Lemme
Leggi i suoi articoliIl mercato dell’arte deve essere retto da regole di comportamento ma queste debbono avere la loro fonte nella legge ed essere univoche, non arbitrariamente estrapolate da fumosi principi generali. Altrimenti, più che un «mercato regolato» avremmo un «mercato soffocato», contraddistinto dall’assoluta incertezza sul regime della esportazione, che verrebbe a esser retto non dalla legge ma dal mero arbitrio della Pubblica Amministrazione.
Tra le regole forzosamente estrapolate è oggi di moda, a iniziativa delle forze repressive, l’affermazione di un onere di corretta informazione della Pubblica Amministrazione che graverebbe su chiunque chieda un attestato di libera circolazione (ossia, una licenza di esportazione) di un bene culturale. All’onere di corretta informazione corrisponderebbe, nel caso di mendacio, l’invalidità di tale licenza e quindi, ove l’amministrazione non cascasse nella trappola, la duplice incriminazione di tentata illecita esportazione e di tentato falso per induzione; in caso contrario, ove la licenza fosse rilasciata, essa verrebbe considerata come atto inesistente, con la conseguente incriminazione della condotta di esportazione, che verrebbe a risultare priva del necessario supporto amministrativo.
Analizziamo questo singolare costrutto. L’onere di informazione è totalmente inesistente. Infatti, l’art. 68 del Codice dei Beni culturali prevede che «chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni che hanno un interesse culturale semplice (ossia, tutte le opere, nessuna esclusa, di oltre cinquant’anni e la cui paternità sia da riferire ad autore scomparso) deve farne denuncia e presentare al competente Ufficio di Esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale». Quindi, l’esportatore può limitarsi, compilando il relativo modulo (che non contiene alcuna prescrizione di indicazioni doverose, oltre al prezzo del bene da esportare), alla generica indicazione «dipinto» o «scultura» o altro nome appropriato, specificandone solo il valore venale. Ogni altra precisazione è superflua: si presume che i funzionari dell’Ufficio Esportazione, in genere storici dell’arte di sicura competenza, siano in grado di capire che cosa viene presentato, senza l’ausilio di indicazioni da parte dell’esportatore. Supponiamo peraltro che questi, pur non essendovi tenuto, specifichi elementi ulteriori relativi all’opera, ad esempio, «scuola italiana» o «scuola bolognese» o addirittura il presumibile autore o la sua cerchia e tale indicazione risulti dolosamente errata.
Il mendacio può ritenersi punibile?
Innanzitutto, ricordiamo che nel campo penale, contraddistinto dai principi di specificità e di legalità, non esiste una regola generale di repressione della frode. Il comportamento fraudolento, in altri termini, è punibile solo quando si possa riferire a specifiche norme incriminatrici e nello stretto ambito delle stesse: è un principio di civiltà giuridica, riaffermato perfino nel codice fascista del 1930 (art. 1), ribadito nell’art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice Civile del 1942 e oggi costituzionalizzato nell’art. 25 della nostra carta fondamentale (che risale, come a tutti noto, all’1/1/1948). Principio che non può soffrire eccezioni, quali che siano i beni giuridici tutelabili. Neppure la tutela del nostro patrimonio culturale, che pure ha dignità costituzionale (art. 9), potrebbe giustificare, per omaggio all’esigenza di difesa della cultura nazionale, la privazione della libertà a carico di un cittadino in assenza di specifica norma incriminatrice. Ma vi è di più: l’articolo 66/1 lett. b) della Legge 1 giugno 1939 n. 1089 criminalizzava, infatti, non solo l’esportazione clandestina (ossia, priva di licenza) ma anche quella ottenuta attraverso «dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero quando la cosa venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione». In sede di emanazione della Legge 30 marzo 1998 n. 88, riscrivendo la norma incriminatrice per renderla omogenea alla legislazione europea, il legislatore soppresse l’alinea b) relativo al mendacio, rilevando la sua differenza ontologica rispetto all’esportazione clandestina e la conseguente inopportunità di omologare, nell’ambito di una stessa norma, un reato di frontiera a un reato di frode. Le ragioni della modifica correttiva risultano chiaramente negli atti parlamentari, che registrano l’intervento al riguardo di un giurista di notevole spessore e di sicura vocazione non filocapitalistica, quale Giuliano Pisapia. Quindi, per la dichiarazione mendace, il legislatore è intervenuto con quella che i penalisti chiamano «abolitio criminis», ossia eliminazione di una incriminazione, con la conseguente ascrizione all’indifferente giuridico di un comportamento precedentemente punibile. In questa situazione, la criminalizzazione della frode in esportazione di bene culturale costituisce un autentico «monstrum» giuridico, che soltanto una preconcetta ostilità al mercato, unita a ignoranza giuridica, può far comprendere, ma non certamente accettare. Quanto poi all’incriminazione di falso per induzione (art. 483 c.p.), si fa solo notare che la licenza di esportazione non solo non è atto fidefacente ma neppure può configurarsi come un provvedimento nel quale siano «accertate» la qualità e l’autore dell’opera da esportare: il falso per induzione è punibile solo quando riguardi un atto destinato a provare la verità di un fatto storico.
Nella specie, viceversa, l’attestato di libera circolazione non costituisce una patente attributiva e irreversibile del bene da esportare; esso si limita a esprimere l’interesse o il disinteresse dello Stato al mantenimento dell’opera nel territorio nazionale, esaurendo in questo tutti i propri effetti. Quindi, anche sotto tale profilo, la costruzione del falso per induzione è sicuramente errata, in quanto la norma incriminatrice richiamata è del tutto inappropriata al caso considerato.
Altri articoli dell'autore
I beni culturali possono essere dichiarati di particolare interesse solo se la loro esecuzione risalga ad almeno cinquant’anni
La capacità (e l’obbligo) di correggersi della Pubblica Amministrazione
Va introdotta una distinzione tra ricerca significativa e ricerca inutile: la prima aggiunge qualcosa alle conoscenze già acquisite, la seconda si limita a riproporre il «déjà dit»
Il conflitto tra Russia e Ucraina mette in luce un relativismo che parte da Giovanni Battista Vico