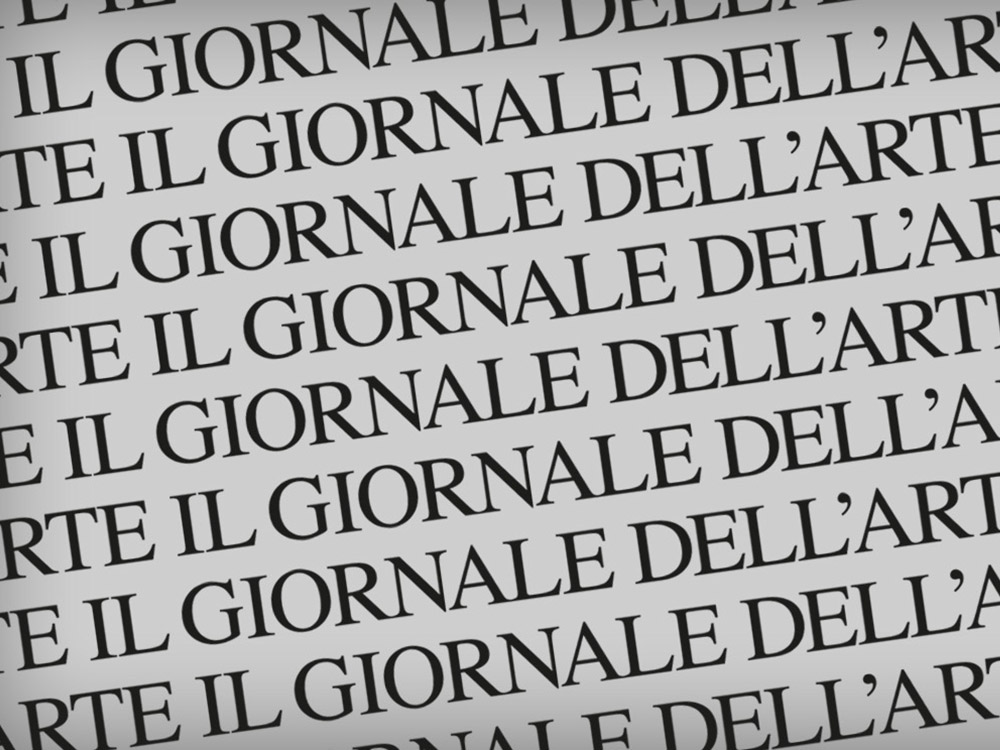Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Carlotta Venegoni
Leggi i suoi articoli«Papà non aveva raccontato la storia della sua vita nemmeno una volta». Soltanto oggi Simon Goodman è in grado di riferire ciò che il padre, Bernard Gutmann (questo il cognome originale), non riuscì mai a condividere. L’Orologio di Orfeo, edito nel 2015 da Electa, è la storia di una famiglia, quattro generazioni che ebbero a cuore l’arte, ma soprattutto i legami e i ricordi che questa è in grado di racchiudere
Una storia affascinante, dolorosa e commovente, una storia di cambiamento. Quanto l’autore ci tramanda non è solo quella dei suoi «nonni». È la storia dell’Europa e del nostro patrimonio.
Eppure, prima della morte del padre, Simon non sapeva molto delle sue origini. Ricevette in eredità quanto di più incredibile si possa pensare: nel 1994 furono recapitati a lui e a suo fratello Nick alcuni scatoloni del padre, contenenti carte «confuse, misteriose, enigmatiche», «molto simili all’uomo che le raccolse». Erano la chiave di lettura per ritrovare non solo la fortuna e la collezione, ma anche per conservarne il ricordo.
Bernard, e ancor prima il nonno e il bisnonno di Simon, appartenevano a una delle più ricche e potenti dinastie ebraiche di banchieri della Germania, i Gutmann. Fritz Gutmann e Louise von Landau erano stati proprietari di una lussuosa residenza in Olanda, Bosbeek, dove possedevano un’enorme fortuna e una collezione d’arte costituita da opere dei più grandi maestri antichi e moderni. Tutto era destinato a scomparire con l’avvento della seconda guerra mondiale. Bernard in Inghilterra riuscì a sopravvivere anglicizzando il cognome, così come sua sorella Lili, che si nascose in Italia, tra le mura della proprietà della suocera. Simon racconta che, come tutto il resto, «la favolosa proprietà, l’enorme fortuna, la magnifica collezione d’arte, i miei stessi nonni, era stata spazzata via».
Prima per curiosità, poi per «dovere filiale, rispetto, tenerezza», Simon dal 1994 riprende la ricerca da dove il padre l’aveva interrotta. Nelle carte di Bernard trovò i titoli di molti quadri, riferimenti ad alcuni dei personaggi storici più famigerati: Adolf Hitler, il Reichsmarschall Hermann Goering, Haberstock, Hofer e Bohler. Si faceva riferimento a Theresienstadt, il campo di concentramento modello dei nazisti, e alle camere della morte di Auschwitz.
Simon trascorse anni in archivi, nei depositi dei musei e biblioteche; incontrò sovente apatia, ostilità e molta indifferenza. Nulla fermò il desiderio di ricostruire quella storia. Chi era suo padre? Chi erano i suoi avi?
Fritz Gutmann, figlio minore di Eugen Gutmann, fondatore della potente Dresdner Bank, divenne un pilastro nella finanza e un raffinato intenditore d’arte. Direttore della filiale della banca di famiglia a Londra, nel 2013 sposò la baronessa Louise von Landau. Durante la prima guerra mondiale fu deportato nell’Isola di Man, dove circa ventitremila internati tedeschi trascorsero tre anni dietro il filo spinato. Finita la guerra Fritz e Louise, con i figli Bernard e Lili piccoli, ricominciarono a vivere in Olanda, dove l’azienda Proehl & Gutmann fondata nel 1919, specializzata in accettazioni bancarie, aiutando a ricostituire le loro finanze.
Con la morte del padre Eugen, la vita di Fritz era destinata a cambiare per sempre: fu nominato esecutore testamentario della proprietà, direttore della società di famiglia e custode della leggendaria Gutmann-Silbersammlung. La collezione, composta da ori, argenti, bronzi e manoscritti di famiglia, comprendeva l’orologio da tavolo di maggior pregio del Rinascimento, l’«Orologio di Orfeo». Fritz trasferì la collezione nella sua raffinata residenza di Bosbeek e inizò ad allestire una collezione di dipinti che avrebbe consumato di passione non solo lui ma anche suo figlio e, oggi, il nipote. Arrivarono opere di antichi maestri italiani, tra cui Guardi, Fra Bartolomeo, Luca Signorelli, Botticelli, Paolo Veronese, del Rinascimento nordico, tra cui Lucas Cranach il Vecchio o Hans Memling, Hans Holbein il Vecchio, Hieronymus Bosch, una Pietà del XIV secolo, ma anche Elisabeth Vigée-Le Brun, Franz von Stuck, Edgar Degas e Pierre-Auguste Renoir. La villa era arredata da sculture rinascimentali, d’oro e d’argento, di valore inestimabile, di tappeti e arazzi preziosi, porcellane Meissen e mobili in stile Luigi XV. Fu uno dei collezionisti privati più importanti dell’Olanda.
Con l’avvento del nazismo anche la vita di Fritz e Louise era destinata a cambiare. La loro ricchezza non li avrebbe protetti dalle politiche razziali, dall’orda di mercanti d’arte nazisti, pronti a «rimpatriare» capolavori di origine tedesca liberandola «dagli indegni collezionisti ebrei». Essi bussarono alla loro porta per arricchire il museo di Hitler, il Führermuseum, e la collezione di Herman Goering. Fritz fu costretto a «vendere» a Bohler e Haberstock, ricevendo come ricompensa una somma irrisoria rispetto ai beni estorti, per di più versata su un conto congelato.
Karl Haberstock il più famigerato collezionista d’arte in Europa, collezionista per Hitler, prosciugò i tesori artistici francesi, olandesi, belgi, svizzeri e italiani, tramite metodi illegittimi, spietati e addirittura brutali.
Fritz non cedette mai la collezione di argenti del padre, nemmeno in cambio di una promessa libertà. L’«Orologio di Orfeo» iniziò a scandire un tempo di morte e Goering non rinunciò mai ad averlo. Il 26 maggio 1943 i nonni di Simon furono costretti ad abbandonare Boskeek, per non farvi più ritorno. Deportati prima al campo di concentramento di Theresienstadt, dopo dieci mesi Fritz fu assassinato nella Piccola Fortezza e Louise portata a morire nel campo di concentramento di Auschwitz.
Per Bernard le opere d’arte rubate ai suoi genitori assunsero un’importanza che andò oltre il loro valore artistico o materiale. Erano «l’ultimo filo che lo univa alla vita di un tempo, l’ultima eredità lasciatagli dai genitori assassinati». La ricerca diventò un’ossessione e condusse a una vita segreta, segnata da continui viaggi, senso di frustrazione e rabbia. Il loro ritrovamento e successivo recupero infatti non si rivelò semplice.
Nel 1943 il Governo statunitense fondò un’unità militare, la Monuments, Fine Arts, and Archives di cui facevano parte storici, mercanti d’arte e altri esperti, il cui compito fu quello di recuperare e restituire ai legittimi proprietari i capolavori sottratti dai nazisti. Lentamente parte della collezione Gutmann veniva rintracciata. Anche attraverso l’aiuto di Rose Valland, alcuni dipinti iniziarono a essere restituiti, altri Bernard e Lili dovettero riacquistarli, incredibilmente, dal Governo olandese; per altri ancora, scomparsi, ricevettero esigue somme di rimborso. Molto ancora era disperso.
Nel 1994 Bernard morì e due mesi dopo Simon e Nick ricevettero gli scatoloni. Capirono che lì, nascosti tra quelle carte, c’erano i segreti che il padre non era mai stato in grado di rivelare.
Tre negativi di fotografie scattate da Rose Valland conducevano a un Renoir e due Degas. Iniziò la ricerca. Cavilli burocratici, ostilità e indifferenza, difficoltà a dimostrarne la proprietà, cause legali, modifiche al titolo delle opere e tanta ignoranza contribuirono a rendere l’impresa degna di essere raccontata e condivisa oggi.
Per rintracciare e recuperare le opere d’arte Simon Goodman ha esaminato documenti segreti, transazioni bancarie, contratti di vendita stipulati tra ufficiali nazisti e collezionisti conniventi, raccolte fotografiche, registri dei campi di concentramento. L’indomita Valland, le case d’asta Christie’s e Sotheby’s e qualche collezionista, sensibile all’orrenda storia che si celava dentro ai quadri identificati, aiutarono i fratelli nell’impresa: stavano riscrivendo la Storia.
Per la prima volta negli Stati Uniti un importante caso legato ai saccheggi dei nazisti finiva in un’aula di tribunale. Tutti i quotidiani ne parlavano.
Nel 1998 vengono sanciti i Princìpi di Washington, che avrebbero definito nuove linee guida per musei e avrebbero portato alla nascita di comitati di restituzione in Austria, Francia e Paesi Bassi. Sotheby’s introdusse un dipartimento interno incaricato della restituzione, guidato da Lucian Simmons. La Christie’s nominò per la carica Monica Dugot.
Il mondo del mercato dell’arte stava scendendo a patti con la Storia. Nel corso della loro indagine, Simon e Nick, e la zia Lili, contribuirono a cambiare il modo di condurre gli affari nel mondo dell’arte, aiutando probabilmente molti altri eredi di vittime dell’Olocausto a ritrovare i beni sottratti e la memoria dei loro cari.
Simon racconta come avvenne il recupero dei Renoir, Degas, Botticelli, Franz von Stuck, Hans Baldung Grien, la «Pietà», Guardi e molti altri pezzi tra dipinti, arredi e argenti. Parte di questa fortuna fu poi rivenduta da Christie’s con due cataloghi: Property from the Gutmann Collection e Importanti argenti, tra cui tre magnifiche opere d’arte rinascimentali d’argento dorato provenienti dalla collezione di Fritz e Eugen Gutmann. Fu un enorme successo di vendita.
La gioia più grande, tuttavia, fu ritrovare quell’oggetto misterioso dal quale tutto era cominciato: l’«Orologio di Orfeo» era al Landesmuseum di Stoccarda.
L’arte può avere una memoria? Può caricarsi di dolore? Certo, questi oggetti potenzialmente immortali, hanno attraversato quattro generazioni, svelandone i segreti: «Ognuno aveva una storia da raccontare».
L’Orologio di Orfeo
di Simon Goodman
traduzione di Andrea Vincre
368 pp., 19 ill. col.
Mondadori Electa
Milano 2015
€ 19,00
Altri articoli dell'autore
Lavinia Fontana e Properzia de’ Rossi rivivono in due monografie dedicate all’infanzia
Yuri Primarosa riporta gli atti di una giornata di studi del 2021, con alcuni contributi che delineano il profilo umano e professionale dell’artista romana
Sono stati riconosciuti dipinti attribuiti a Tiziano, Tintoretto, Spinello Aretino, Giovanni Fei, alla bottega di Vittore Carpaccio e Paolo Veneziano, sottratte alla collezione fiorentina Contini Bonacossi. Nuove ricerche ne hanno identificate altre di Francesco Guardi, Michele Marieschi, Giuseppe Gambarini, Canaletto, Alessandro Turchi detto l’Orbetto
Un libro per chi non ha il cervello pigro, che riflette sulla permanenza del segno umano