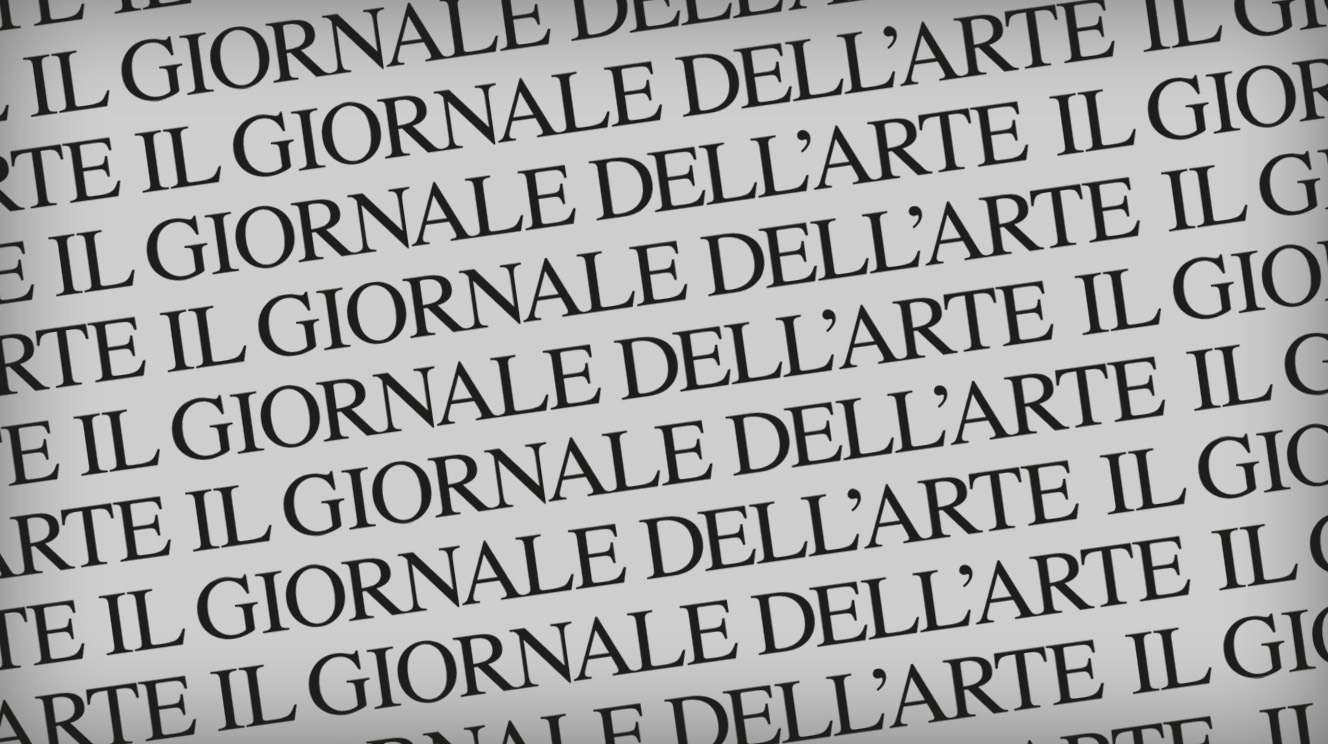Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
.jpeg)
Anna Somers Cocks
Leggi i suoi articoliOgni domenica, un uomo dall’aspetto ordinario, nel suo solito abito blu e camicia bianca, guidava un’auto ordinaria fino a una casa ordinaria alla periferia di Torino e pranzava, servito dalla sua fedele domestica Marcellina, in una sala porticata traboccante di orchidee. Avrebbe potuto scegliere di sedere nella sala da pranzo, accanto ai suoi dieci quadri metafisici di de Chirico, ma gli piaceva stare in mezzo ai fiori. Amava la bellezza, e ogni stanza era piena dei capolavori acquistati in quasi settant’anni dai cataloghi delle case d’asta o semplicemente aspettando che il mondo dell’arte andasse da lui. Erano la sua famiglia, i suoi amici, la sua unica raison d’être oltre al suo lavoro.
Federico Cerruti, scomparso il 15 luglio a 93 anni, impiegava molto tempo per decidere e, anche se occasionalmente chiedeva delle consulenze, le sue scelte erano guidate unicamente dal suo occhio, dal dono di saper riconoscere la grande arte. Nella sua camera da letto c’erano fondi oro di fine Medioevo e dipinti del primo Rinascimento, Paolo Veneziano, Sassetta, Bergognone e altri, tutti di indiscussa qualità e in condizioni di conservazione perfette. Nel salotto facevano mostra di sé i più insigni maestri del Rinascimento, Dosso Dossi, Pontormo e Paris Bordone, accanto ai Tiepolo e alle opere allegoriche di Batoni del XVIII secolo. Un meraviglioso nudo di Boldini tra quadri dell’Ottocento e poi Klee, Boccioni e Modigliani, fino ad Alberto Burri e ai moderni. Tra questi, la prima opera acquistata da Cerruti, un disegno di Kandinskij, che affermò sapere di essere autentico perché riportava la dedica dell’artista a un amico. Sui tavoli erano impilati libri rari, come l’Atlas Maior di Joan Blaeu in dodici volumi, il più importante progetto editoriale del XVII secolo.
C’erano anche le più preziose produzioni dell’editoria di lusso, come una copia di À la recherche du temps perdu in una rilegatura Art Déco di Pierre Legrain. Vicino al letto, nella stanza dov’era conservato un secrétaire in avorio intarsiato di Piffetti, il più raffinato ebanista italiano di tutti i tempi, c’era uno squisito libricino con copertine smaltate e incastonate di pietre preziose del Seicento francese. Tutto ciò era stato reso economicamente possibile proprio dai libri, o meglio dalle rilegature. Federico Cerruti nacque nel 1922 in una famiglia genovese che possedeva una piccola legatoria industriale. In seguito si trasferirono a Torino e ampliarono l’attività. La fabbrica fu distrutta durante un bombardamento e Cerruti sfuggì alla morte per una pura coincidenza il 9 settembre 1943. Avrebbe potuto essere sulla corazzata Roma, affondata proprio in quel giorno dalla Luftwaffe.
Fu allevato con severità dai suoi genitori, che gli trasmisero un’etica del lavoro ossessiva. Così studiò contabilità, non discipline umanistiche. Seppe trarre il massimo vantaggio dal boom postbellico e la Legatoria Industriale Torinese diventò una delle due principali realtà del settore nel Paese, con il contratto di stampa per tutte le guide telefoniche. Aveva un pied-à-terre sopra il suo ufficio, dove abitò da solo per tutta la vita. Nella villa che aveva costruito apposta per sé dormì una sola notte. Annalisa Ferrari, il suo braccio destro per trent’anni, ricorda di averlo sentito dire che svegliarsi in mezzo alla sua collezione d’arte gli aveva causato la sindrome di Stendhal, una sensazione di agitazione e svenimento indotta da un eccesso di emotività estetica. Due volte l’anno organizzava sfarzose feste in villa, in occasione del compleanno e dell’onomastico, quasi un obbligo dal momento che non aveva amici.
Era generoso nei prestiti per le mostre e con la collaboratrice, Annalisa Ferrari, e consentì persino a piccoli gruppi di estimatori d’arte di visitare la collezione, accogliendoli con una sconcertante umiltà cavalleresca. Uno di questi gruppi fu il Friends of the Fitzwilliam, di cui facevano parte il defunto Lord Leicester e il nipote di Lord Ashburton, che aveva venduto il Piffetti nella collezione di Cerruti. Tutti furono stupefatti dalla bellezza che si parò davanti ai loro occhi, soprattutto perché non ne avevano mai sentito parlare. Rifuggiva le apparizioni in pubblico al punto che di lui esistono pochissime fotografie. Disse alla signora Ferrari di organizzare il suo funerale prima di annunciarne la morte, per evitare le inutili e immancabili occasioni di chiacchiere e incontri di società. Chiese di essere sepolto con un crocifisso d’avorio nella bara e le fotografie dell’adorata madre e di Padre Pio.
Negli Stati Uniti e in Inghilterra, i musei si sarebbero prodigati per ossequiarlo, invitarlo a far parte dei loro consigli di amministrazione, offrirgli un ambiente congeniale in cui condividere la sua passione. In Italia, l’abisso e il reciproco sospetto tra musei e collezionisti privati sono tali che nulla di tutto ciò è potuto accadere. Ci fu un tentativo da parte dell’Assessorato alla Cultura della Città di Torino di corteggiarlo, fallito perché fu indiscretamente annunciato alla stampa, suscitando l’ira di Cerruti, che era soggetto a violenti attacchi di collera. Un altro progetto che si spinse poco oltre fu l’offerta della Compagnia di San Paolo di occuparsi della gestione della collezione dopo la sua morte.
C’era però l’intenzione di spostarla dalla villa in un edificio in centro città e per questo Cerruti rifiutò. Svariati altri progetti si conclusero con un nulla di fatto. Due anni fa Cerruti istituì la Fondazione FC e vi conferì la villa, la collezione e una somma di capitale. Al momento di andare in stampa non è ancora stato aperto il testamento, ma a ereditare dovrebbe essere la sorella di Cerruti. A lei spetterebbe la decisione se affidare la gestione della casa e dei suoi tesori al Fai - Fondo Ambiente Italiano, che la aprirebbe alla visita su prenotazione per piccoli gruppi. Non sorprende che un uomo che ha lasciato scorrere così tanta vita tra le dita abbia rimandato la firma dei documenti necessari finché non è stato troppo tardi.
Malato di perfezione
È improbabile che in Europa vi sia una collezione privata paragonabile a quella di Federico Cerruti. Paragonabile per l’estensione dei territori specialistici e temporali in cui si è estesa, dai libri alle rilegature, dai mobili alle arti decorative, dai fondi oro all’arte rinascimentale e post, all’Ottocento, alla modernità. Ma soprattutto a essa paragonabile per la qualità assoluta, altissima di ogni pezzo, nessuno escluso, del gran numero di opere e manufatti di cui la collezione è costituita.Il direttore di uno dei grandi musei eclettici del mondo, del Louvre o del Metropolitan o dell’Ermitage, che avesse avuto la straordinaria fortuna di riceverla in dono, avrebbe potuto inserirla tale quale nel proprio museo, semmai sostituendo qualche pezzo del museo con quelli di più elevato livello che Federico Cerruti aveva meticolosamente scelto.
Come si può spiegare un livello così alto, diciamo così «perfetto», senza alcuna eccezione o cedimento? Ancora una volta la spiegazione va cercata nella personalità del collezionista. Un uomo solitario, intelligentissimo, che si è via via costruito la sua competenza ma estremamente intuitivo dei valori e dei metodi e dei requisiti di identificazione e di qualificazione di ogni opera. Solitario, ma documentato, anche in ciascuna delle sue scelte, sempre molto ponderate, molto meditate talvolta fino all’esasperazione come hanno verificato i suoi alternati interlocutori mercantili, da Mario Tazzoli a Gianfranco Luzzetti, da Carlo Orsi a Paolo Baldacci a Gian Enzo Sperone e in primis il vertice delle grandi case d’asta londinesi e newyorkesi. Esigentissimo con le persone come nelle sue scelte artistiche. Forse non a caso (come la sorella Andreina quasi coetanea) non si era mai sposato malgrado una relazione senza convivenza durata 17 anni.
Nessuno potrebbe testimoniare la sua personalità salvo la sorella Andreina o la sua stretta collaboratrice per 33 anni, Annalisa Ferrari, figlia del pittore Eugenio Polesello, divenuta persona di assoluta fiducia, che agiva per suo mandato non solo negli affari professionali, ma perfino nel visionare le opere. Cerruti, il cui mondo era deliberatamente circoscritto alla sua fabbrica e al suo pied-à-terre annesso, estremamente sobrio e austero (ma il letto in cui dormiva non era una branda, come la leggenda racconta, bensì di Bonzanigo...), cioè al numero 29 della periferica via Ludovico Bellardi di Torino, mandava in esplorazione la signora Ferrari a Maastricht, a Londra o a Parigi facendosi descrivere al telefono, tra un antiquario e un altro, che cosa aveva visto e i prezzi che chiedevano.
La spiegazione anche delle sue celebri collere e della sua rara, e ancor più occulta, bontà e generosità è probabilmente qui: intollerante e ipocondriaco, la perfezione che cercava, mai in misura soddisfacente, nelle azioni umane e nelle persone, la trovava nelle opere d’arte che non potevano e «non dovevano» deluderlo. Perciò le sceglieva con tanta accuratezza. La contemplazione solitaria dell’arte gratificava il suo bisogno estetico di assoluta perfezione. Assistere a Natale alla messa dei barboni del gruppo Bartolomeo & C. di Lia Varesio e tante altre sue segrete azioni benefiche gratificavano la sua pietas umana altrettanto esigente, nascosta e segreta.
Altri articoli dell'autore
Una guida in 10 punti, partendo dai 50mila euro raccolti da Palazzo Madama a Torino per acquisire cinque smalti del prezioso scrigno medievale
In una rara intervista del 2005 l’Aga Khan descrive il suo approccio globale per aiutare le comunità islamiche ad aiutarsi, ripristinando al contempo il loro patrimonio del passato: non basta ricreare un ambiente fisico senza affrontare anche i problemi sociali che lo circondano. Solo così si crea un «ambiente favorevole», dove possano fiorire la speranza, l'autosufficienza e la società civile
Dopo sei anni alla Pilotta di Parma, da nove mesi guida il museo fiorentino, sempre più minacciato dal sovraffollamento (5 milioni di ingressi nel 2023): il nuovo direttore vuole attirare pubblico a Palazzo Pitti e a Boboli, senza sacrificare i 40 milioni di euro di ricavi annui, con novità e progetti, dal Museo della Moda alla nuova Tribuna, al 30% di spazio in più nelle 12 sale dei Nuovi Uffizi
Un antiquario parigino offre a 50mila euro cinque preziosi smalti di Limoges che si è scoperto appartenere alla decorazione del cofano, conservato in Palazzo Madama, del cardinale Guala Bicchieri, promotore della Magna Carta. Il museo torinese promuove un crowdfunding per raccogliere entro fine anno i fondi