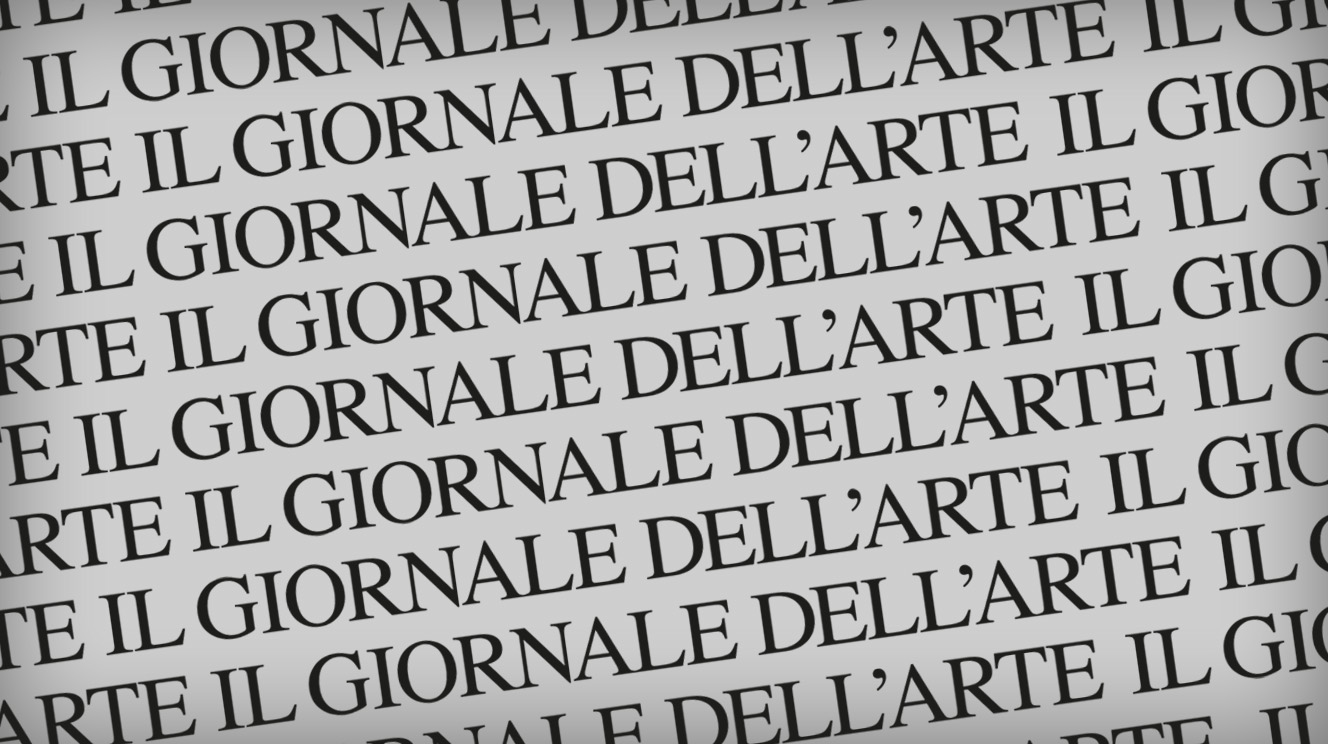Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Michele Roda
Leggi i suoi articoliSono le continue mediazioni e la lunghezza dell’iter amministrativo per i permessi che spingono Pier Luigi Nervi, nei primi anni Settanta, a minacciare di ritirare la propria firma dal progetto per la Cassa di Risparmio di Venezia, in campo Manin. L’edificio, conosciuto come Palazzo Nervi-Scattolin (Angelo Scattolin è il coprogettista), prese il posto di un palazzo di fine Ottocento, posto accanto a edifici gotici. Situazione che creò polemiche e numerose richieste di riadattamento del progetto, tanto che l’edificio realizzato è molto diverso dal disegno originale. Nonostante non si sia arrivati al disconoscimento da parte di Nervi, questo caso è considerato dai giuristi emblematico del rapporto tra progetto e realizzazione dal punto di vista della tutela del diritto d’autore.
Ancora più eclatante quanto era successo, pochi anni prima, a Sydney. Il concorso per la nuova Opera House viene vinto dall’allora semisconosciuto architetto danese Jørn Utzon. È il 1957, il cantiere si rivela lungo, complesso e i costi aumentano a dismisura. Alcune forze politiche mettono il progettista sul banco degli imputati per l’incapacità di gestire la commessa e quando, nel 1966, viene rifiutata dal committente l’indicazione di un fornitore per pannelli in legno, Utzon rinuncia all’incarico. Non tornerà più in Australia nemmeno nel 1973 quando, alla presenza della regina d’Inghilterra, l’opera venne inaugurata senza mai citare il nome del suo architetto. Soltanto decenni dopo la ferita venne sanata e l’architetto danese intervenne direttamente per alcuni adattamenti in quello che è oggi uno dei più noti edifici al mondo. Due casi più recenti, che coinvolgono Frank Gehry, aggiungono alcuni punti. Il primo riguarda un edificio inaugurato nel campus del Mit di Boston nel 2004. Tempo pochi mesi si sono rivelate le prime infiltrazioni d’acqua tanto che, dopo interventi non risolutivi, la committenza ha deciso di chiedere i danni al progettista per «gravi errori di progettazione e costruzione». Qui interessa la risposta di Gehry: «Ci sono cose che furono lasciate fuori dal progetto; il cliente scelse di non realizzare alcuni accorgimenti sul tetto per ridurre la spesa».
Lo stesso architetto americano è stato protagonista di una «rinuncia» clamorosa, prima ancora di iniziare il cantiere, dall’incarico per il Museo della Tolleranza a Gerusalemme, voluto dalla Fondazione Simon Wiesenthal e dal Comune di Gerusalemme, a causa delle richieste di ridimensionamento di un progetto contestatissimo e mai decollato. Non poche le polemiche anche intorno a un altro edificio simbolo della nostra contemporaneità, come la Freedom Tower di New York, con il progetto di Daniel Libeskind, vincitore di concorso, a più riprese rimaneggiato e modificato. In tempi recenti analoga disputa a quella di Chipperfield ha contrapposto Massimiliano Fuksas e la Regione Piemonte per la torre degli uffici regionali a Torino, in corso di ultimazione. La costruzione era stato realizzata, secondo Fuksas, stravolgendo le indicazioni di progetto. La minaccia di disconoscimento sembra però rientrata grazie a un accordo. Un altro capitolo riguarda invece le varianti in corso d’opera. Su questo punto la giurisprudenza è più prudente: la tutela del diritto d’autore all’integrità dell’opera di architettura non può confliggere con le esigenze d’uso del committente-proprietario.
Un caso emblematico è quello che ha visto gli eredi di Marcello Piacentini (il diritto d’autore si trasmette per via ereditaria) schierati contro alcune integrazioni nel Palazzo di Giustizia di Milano. Soluzione risolta con un accordo tra le parti.
Altri articoli dell'autore
Chiuso per restauro il Padiglione Centrale ai Giardini, la sede all’Arsenale diventa il cuore del progetto del curatore, che ha disseminato molte installazioni per descrivere il mondo d’oggi e puntare sulla collettività
L’architetto Michele Roda ha visitato la 18ma edizione della Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, scegliendo 12 dei 64 padiglioni nazionali, con un «borsino» dei top e dei flop tra le partecipazioni
In occasione del suo ottantesimo compleanno, abbiamo intervistato l’architetto ticinese: «Si sono esauriti i valori del Moderno e abbiamo dimenticato che veniamo dal Romanico. L’uomo non è più al centro, la globalizzazione ha annullato le differenze e la gravità e la geometria, fondamenti del costruire, oggi fanno paura»
La direttrice della 18ma edizione della Biennale di Venezia ha concepito una mostra-laboratorio giovane, collettiva, con poche archistar e molte donne