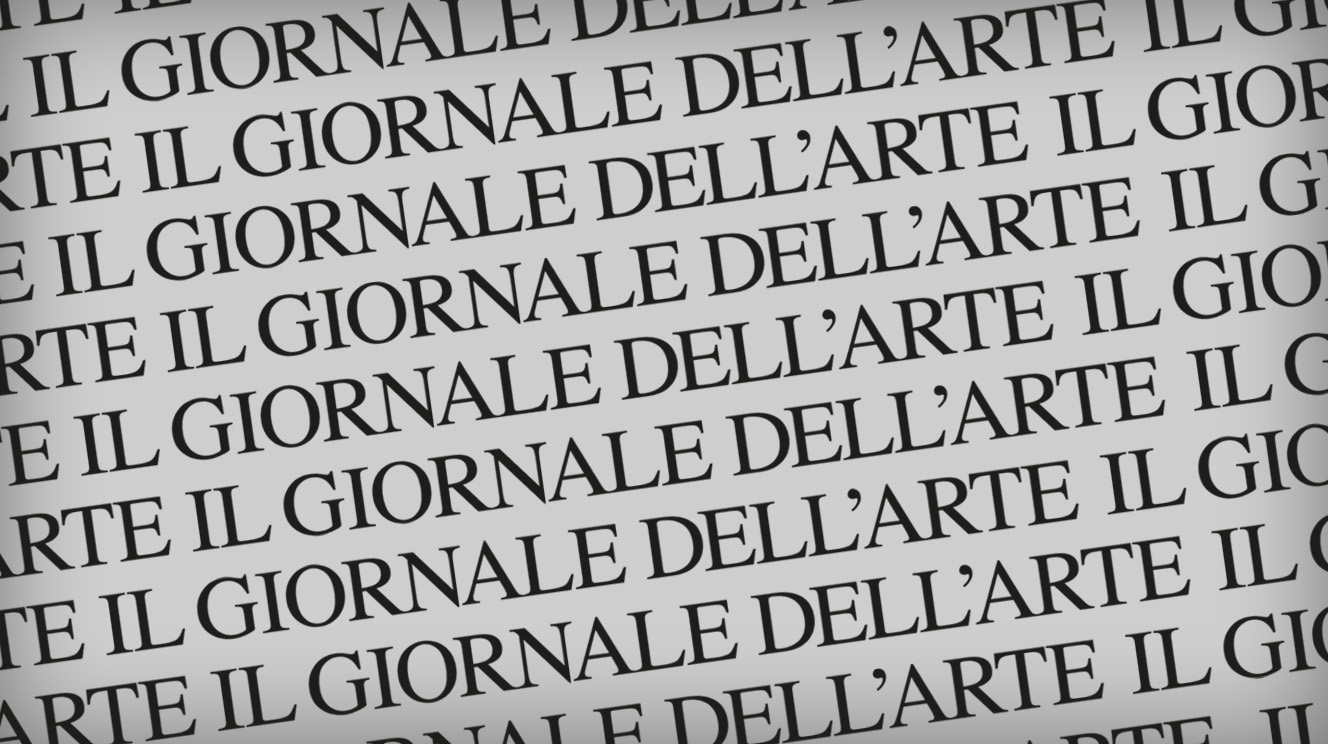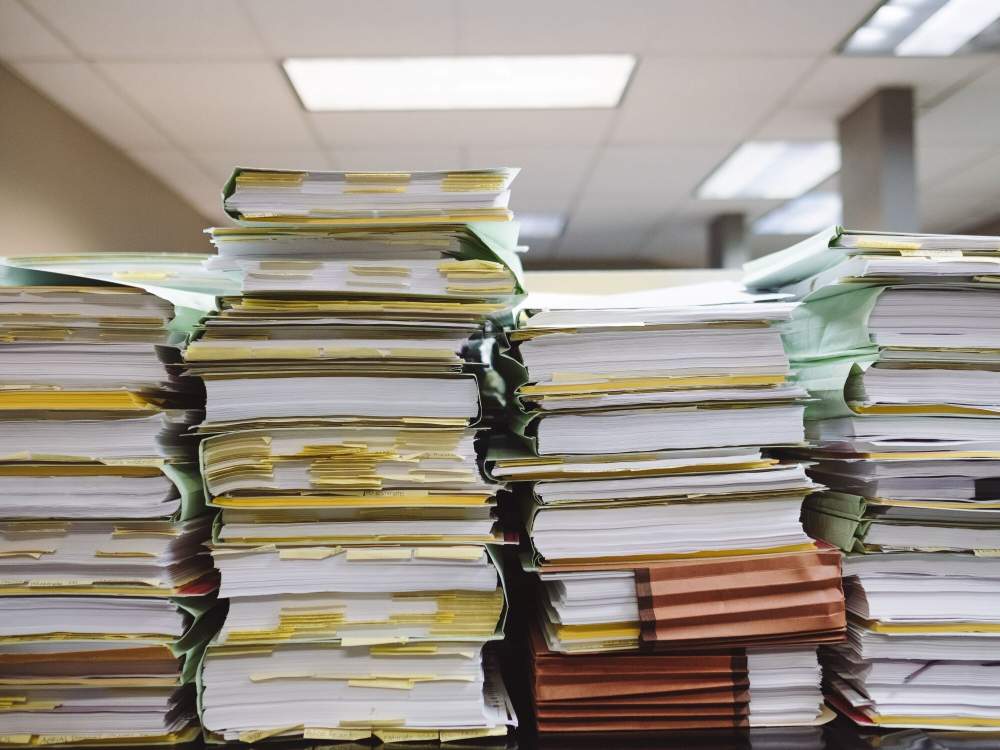Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GDA
Leggi i suoi articoliNel 1740, quando il banchiere inglese Henry Hoare visitò Roma, arrivò in città anche Giovanni Battista Piranesi, colui che più di altri doveva cambiare le vicende del gusto. Hoare si invaghì dell’aura classica, ma il migliore fra i suoi acquisti fu un oggetto curioso, uno stipo di ebano ricoperto di pietre dure e di alabastri, trovato fra i beni dell’ultima discendente di Sisto V. Hoare non fu il solo inglese a interessarsi a quel genere di manufatti: i romani, incostanti nelle mode, si disfecero nel Settecento di molti lavori del genere, arredi in pietre colorate eseguiti fra la seconda metà del Cinquecento e il secolo successivo. La quantità di stipi manieristi ascrivibili a botteghe romane e di piani di tavolo con intarsi di marmi colorati conservati ancora oggi in Inghilterra è grande. Con il loro censimento si apre il ricchissimo volume di Simon Swynfen Jervis e Dudley Dodd sul cosiddetto Stipo di Sisto V, un censimento in cui vengono accostati anche oggetti non di provenienza romana come gli stipi e i tavoli in sole pietre dure di manifattura fiorentina. A Roma fra Cinque e Seicento si eseguivano con le pietre dure opere stilisticamente diverse da quelle della Galleria Medicea, e lo stipo studiato nel libro è l’esempio più alto di una tecnica che privilegiò i contrasti cromatici rispetto al naturalismo dei fiorentini.
Il mobile è un edificio a tre piani, con un’edicola alla sommità: l’aggetto centrale e le colonne arretrate alla base creano l’illusione che si tratti di un edificio a pianta centrale, un alto tabernacolo, e con questo termine, infatti, venne descritto nel 1713 nell’ultimo documento romano che lo riguarda. Nel volume si propone che il mobile sia stato commissionato dallo stesso Sisto V (Felice Peretti, 1585-90) e si ripercorre la storia dei suoi proprietari e dei luoghi dove lo stipo fu alloggiato, dalla loggia sul Palazzo Felice, la dimora edificata da Peretti al centro della sterminata villa sull’Esquilino, dove lo stipo compare per la prima volta in un inventario del 1655, alle stanze di Stourhead dove è ancora oggi custodito. Restano ignoti, come accade ancora spesso con manufatti romani del genere, gli autori materiali di quell’arredo: si possono per ora fare solo ipotesi, persino sull’architetto che dovette disegnarlo. Gli autori giustamente ricordano il nome di Domenico Fontana, impiegato costantemente da Sisto V nell’esteso rimodellamento di Roma, ma anche nelle commissioni private come la villa e il proprio mausoleo, quella Cappella del Presepe nella Basilica di Santa Maria Maggiore che, non a caso, troneggiava alla fine di uno dei viali della villa stessa. L’oggetto è insolito, un capolavoro isolato; i paragoni architettonici appaiono spesso inefficaci perché riferiti a edifici veri e propri. Vorremmo qui suggerire di guardare anche ai pensieri di un intagliatore e architetto che si fece una fama come progettista ed esecutore di tabernacoli e organi, e cui fu commissionato persino il modello ligneo della più straordinaria impresa in pietre dure mai concepita, la Cappella dei Principi di Firenze, Giovanni Battista Montano. Alcuni suoi disegni sembrano corrispondere al gusto complesso di quegli ultimi tre decenni del Cinquecento che lo stipo esprime.
Altri articoli dell'autore
L’Associazione archeologi del Pubblico Impiego (Api-MiBact) ha inviato una nota al Ministero della Cultura e a quello della Funzione Pubblica, nonché ai membri delle Commissioni cultura di Camera e Senato, per esprimere il proprio dissenso per il bando per 75 posti nell’area dell’elevate professionalità (Ep), le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 26 giugno
Il premio Nobel e il direttore del Museo Egizio si sono incontrati per parlare di musei e romanzi: «Sono simili: sono i “luoghi” in cui avviene l’interpretazione del significato della nostra vita, nei quali riflettere su sé stessi»
Anche quest’anno Tag Art Night, la Notte delle Arti Contemporanee, propone un palinsesto di mostre diffuse sul territorio cittadino
Rimodulate le competenze e modificato la struttura organizzativa: dal Segretariato generale al modello dipartimentale