
Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Cristina Fiordimela
Leggi i suoi articoliIl Victoria & Albert Museum di Londra ha riportato in superficie l’attualità dei depositi come riserve museali, con i suoi 16mila metri quadrati e oltre 250mila oggetti, per reimmaginare i musei del futuro. In attesa di ritornarci il 13 settembre, a tu per tu con gli oltre 90mila documenti dello Storehouse del David Bowie Centre, meno spettacolare ma impattante per il grande numero è il report mondiale di Icom dello scorso anno che svela come a loro volta le riserve museali si accumulino occupando vaste aree del pianeta (103.852 nel mondo, di cui 3.195 in Italia) con tipi di spazi diversi, annessi o dislocati ai musei, con architetture imponenti o seminascoste nel paesaggio. Ed è soprattutto l’allestimento, la matrice architettonica che fa la differenza nel porre in evidenza le possibilità della riserva museale a essere reinterpretata come «ecologia delle collezione».
Ne parla diffusamente il libro Les réserves des musées. Écologies des collection di Tiziana N. Beltrame e Yaël Kreplak (pp. 366, les presses du réel, Digione 2024, € 28), prendendo in esame soprattutto la Francia che ne conta ben 40.811, dove tra evoluzioni e rivoluzioni museali, conservare è trasformare il patrimonio partendo dalle origini stesse del museo: l’accumulazione e i suoi spazi, i depositi. Nel libro (solo in lingua francese), una raccolta collettanea di articoli, incontri, interviste e saggi, Tiziana N. Beltrame, antropologa (DiSSGeA Università di Padova), e Yaël Kreplak, sociologa (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), intrecciano pratiche museali, filosofie museologiche e progettazione museografica per andare a fondo di ciò che sta avvenendo nei depositi dei musei da vent’anni a questa parte, prendendo come campo di indagine principalmente i musei parigini e dell’Île de France, ma spingendosi anche in altri Paesi europei con alcuni casi studio emblematici.
Alla base del libro è la ricerca sul campo, cioè nei depositi stessi, dove le fonti e le metodologie di indagine, quella antropologica e quella sociologica, pur rimanendo distinte si intersecano nel considerare il museo come «terreno» comune, addentrandosi insieme, e a più riprese, nella riserva intesa come ambiente professionale e vitale, occupato e abitato, e che, nel senso più allargato di «ambiente mediale» (secondo Augustin Berque), considerano come un’interfaccia tra scienze ambientali e scienze sociali. L’«ambiente deposito» è un modo di interleggere le relazioni tra corpi: il corpo umano di coloro che vi lavorano, i corpi degli oggetti che vi convivono e il corpo dello spazio architettonico. La scala temporale del viaggio inchiesta è quella della «longue durée» della conservazione mirata alla «fabbricazione dell’eternità delle collezioni», ma intercettata nelle relatività dei tempi del lavoro quotidiano, dalla movimentazione dei reperti al loro restauro. Il punto di vista è quello dell’osservazione del dettaglio: pratiche, strumenti di lavoro, ma anche i gesti dell’essere umano nel prendersi cura degli oggetti.
Il libro è dunque, prima ancora che la restituzione di una ricerca, uno strumento utilissimo per approntare la ricerca nei musei contemporanei, dove il deposito si rivela il «milieu» privilegiato per intravedere i musei del futuro, o il futuro dei musei. Tutt’altro che statico, il deposito è piuttosto un luogo in perenne trasformazione, vaso comunicante che traccia del museo una storia parallela, anche paradossale se si guarda alla percentuale delle collezioni «nascoste» nelle riserve rispetto a quelle esposte: la punta di un immenso iceberg sommerso e cangiante.
Negli ultimi vent’anni il deposito va configurandosi come un ambiente collegato ma autonomo dal museo: è l’altro centro, ovvero un luogo dove la ricerca può tornare a essere protagonista della politica museale. Se infatti, come scrive François Mairesse nel suo saggio a chiosa del libro dal titolo Évolution et révolution des réserves, facendo un balzo indietro negli anni ’70, la svolta neoliberale provoca nel mondo dei musei una mutazione verso il «credo del mercato» come la fonte più considerevole di autofinanziamento (fatto che spinge le politiche museali a interessarsi sempre più al pubblico consumatore e alla sua frequentazione e quindi all’attività di esposizione, con un’impennata delle funzioni mediatiche a partire dagli anni ’90, e con una progressiva riduzione e alienazione della ricerca), sono proprio queste trasformazioni e questi periodi di cambiamento a marcare le tappe significative nella storia dei depositi museali, di cui si mette in discussione l’utilità in quanto ritenuti spazi improduttivi, poiché non visitabili dal pubblico, ma nel frattempo si prende atto, già nella prima conferenza internazionale sui depositi organizzata nel 1977 dalla Smithsonian Institution a Washington, che le riserve sono diventate una sorta di «realtà aumentata» del museo, a cominciare dalle politiche di acquisizione tra le due guerre mondiali con l’accumulo di oggetti, sia per avidità colonialiste, sia per il fervore sociale ed educativo con la produzione di copie finalizzate allo studio.

Riserva degli oggetti radioattivi al Musée Curie, Paris, 2022. © Adrien Klapisz/ Musée Curie

Prelievo di un campione dalla zampa di un uccello, al Mnhn, Musée national d’Histoire naturelle, Parigi. Photo © Adrian Van Allen
Léonie Hénaut e Héllène Vassal evidenziano come negli anni ’90 coincidano l’affermazione della conservazione preventiva, la formazione di registrar come figura professionale più definita e i grandi cantieri che includono i depositi nei programmi e nei progetti di ampliamento del museo, comportando un incremento e un dinamismo professionale verso la «formazione ai mestieri delle riserve», che accompagna l’emancipazione dei depositi da spazi di stoccaggio passivo a luoghi di dibattito e di lavoro a sé stanti, ma sempre in costante interazione con le aree di esposizione.
Nell’incontro con Éléonore Kissel (Musée du quai Branly) si riaffaccia l’interesse per la «galleria di studio», oggi possibile «ecologia dello spazio» che tiene in una relazione spaziale contigua documenti, oggetti e persone che fanno ricerca potendosi spostare liberamente in un luogo di lavoro ibrido. L’accumulo di oggetti nei depositi implica una ridefinizione della riserva in nuova prospettiva: riserva come risorsa che attraverso la sua esternalizzazione diventa una fonte di economia circolare, riserva come «liaision» interculturale attraverso percorsi di decolonizzazione delle collezioni, riserva come potenziale di ricerca museologica e museografica nella possibilità di sperimentare nuove forme di allestimento e relazione con il pubblico.
Ma, come evidenziano le autrici nell’introdurre alla lettura dei testi, la riserva oggi è anche la somma di criticità per l’impatto ambientale, sia per l’accumulo di nuovi edifici (e il loro moltiplicarsi in modo sparso o annettendo nuove costruzioni), sia per come e dove essi sono collocati rispetto al museo: nodo strutturale del discorso che aleggia quotidianamente nei depositi delocalizzati e che ha dato avvio a questo libro. Era l’aprile 2023 e circolava una petizione online lanciata da un collettivo del personale del Museum national d’histoire naturelle di Parigi, per opporsi alla decisione della direzione del museo di traslocare una parte delle collezioni a Digione, a 300 chilometri dalla capitale francese.
Ecoconservazione e post-preservazione, sono alcune delle parole chiave che tendono a indicare attitudini ecoresponsabili (C. Pesme) rendendo con chiarezza l’inscindibilità della conservazione dalla dimensione politica, e interrogandoci sull’impermanenza delle cose tra estetica e politica delle riserve (N. Etienne), incluse le collezioni radioattive del Musée Curie (T. Beaufils e A. Klapisz), e quindi sul loro deterioramento non più come perdita di materia e di informazione ma piuttosto come capacità di metamorfosi culturale ed ecologica.
La museografia, dall’architettura dell’edificio (H. Fontenas) e degli apparati di immagazzinaggio (R. Radal) fino all’imballaggio (F. Buisson) è la texture trasversale di questo ricco volume sui depositi, di cui le riserve del Musée des Arts et Métiers a Saint-Denis, progettate trenta anni fa da François Deslaugiers, sono ancora un’architettura pionieristica, fondata sulla convivenza del deposito e degli atelier di conservazione e restauro, e sulla circolazione degli oggetti (M. Allary, R. catillon, S. Maillard).
Fontenas, già architetto alla Direction des musées de France, riporta, in dialogo con Kreplak a proposito dei suoi progetti per le riserve dei musei di Poitiers e di Calvi, l’importanza del passaggio da progetto a programma architettonico, poggiato su analisi e studi preliminari in grado di corrispondere alla complessità e alla pluralità di bisogni e contesti specifici, nonché alla sensibilità per la «massa» architettonica, a sua volta apparato di mediazione tra paesaggio e comunità.
In chiusura Mairesse, citando il rapporto «Meadows» (1972), accenna alla messa in causa del modello del museo in quanto luogo a crescita illimitata, così come all’insufficienza dello sviluppo sostenibile e all’impatto delle grandi opere delle riserve delocalizzate in uno scenario di collasso dell’accumulazione, prefigurando un modello opposto: forme modeste, fondate sulla resilienza e sulla rinuncia, sul restauro e sulla riconciliazione. Di certo il tema centrale, per cui ancora musei e depositi sono in divenire, non è solo la correlazione tra museo e riserva, ma il rapporto primigenio dell’essere umano con l’«hoarding» (accumulo), che non prevede fine.
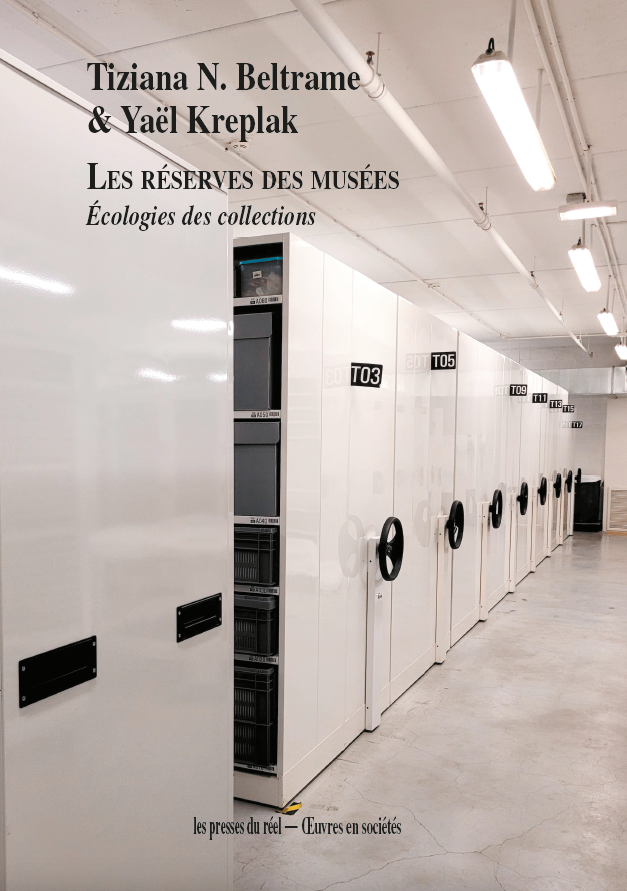
La copertina del volume
















