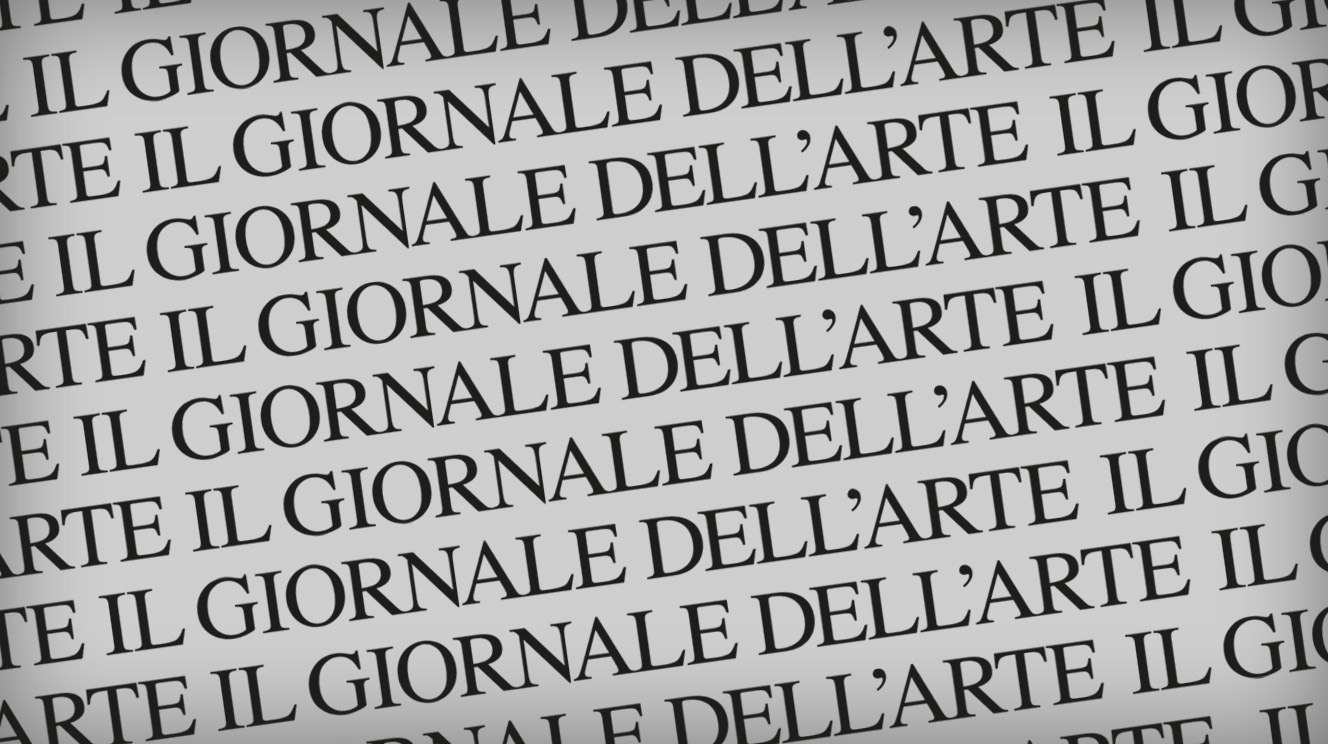Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Federico Florian
Leggi i suoi articoliCerco di immaginare il mondo come se fosse visto da un alieno»: è questa la visione che sottende la pratica artistica di Adrián Villar Rojas, artista argentino classe 1980. Le sue monumentali installazioni d’argilla, capitoli di una saga mitologica senza nome, catapultano il visitatore in un universo fantastico: balene gigantesche, repliche di busti michelangioleschi, ibridi di animali e materiali inorganici. Simili a residui archeologici provenienti dal futuro, le opere di Villar Rojas, tra i protagonisti dell’attuale Biennale di Istanbul, testimoniano un immaginario post-apocalittico, dove ogni distinzione tra umano e animale, organico e inorganico viene meno. Lo abbiamo intervistato in occasione della sua prossima mostra personale, la prima in Italia, alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino dal 4 novembre al 28 febbraio, dal titolo «Rinascimento» a cura di Irene Calderoni.
Quali lavori espone alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo?
Il progetto torinese indaga il concetto di «affezione» e il legame che esso intrattiene con l’idea di cura e pulizia. Mi interessa il gesto quotidiano del pulire e del lucidare. Le incombenze domestiche, a volte, tradiscono una ragione affettiva: pulire la propria casa è spesso un’azione paragonabile a una sorta di «riparazione» emotiva. Associerei questa mostra a una condizione di «hangover», una sorta di stato post-sbornia, in cui il momento della sbronza ha coinciso con la preparazione dell’installazione per la Biennale di Istanbul, «The Most Beautiful of All Mothers».
La mostra torinese si intitola «Rinascimento». È un riferimento al movimento artistico italiano quattro-cinquecentesco? Penso ad alcuni suoi vecchi lavori, in cui ha riprodotto e reinventato esemplari di sculture rinascimentali, come il «David» di Michelangelo.
«Rinascimento» è un titolo che si addice particolarmente a quella che, in teoria, potrebbe essere la mia ultima mostra. Indubbiamente è un modo per ricollegarsi all’Italia e alla sua storia.
Tutti i suoi progetti sono concepiti per il luogo in cui vengono esposti. Spesso lei utilizza la metafora del teatro per descrivere la sua pratica «corale»: vi sono attori-collaboratori, una specifica scenografia e un regista teatrale, da lei impersonato. Descriverebbe più in dettaglio il lavoro di squadra che sta dietro alle sue mostre?
Negli anni, soprattutto a partire dal 2013, ho cominciato a elaborare la metafora della «troupe» e dell’officina itineranti. Nella mia «compagnia» un gruppo di «attori», tutti esperti nell’arte dell’improvvisazione, intrattiene una relazione dinamica e fluida con il proprio «regista». Quest’ultimo, attraverso vari canali (disegni o parole), comunica agli attori una serie di informazioni necessarie alla realizzazione del progetto finale. Eppure, la comunicazione è spesso difettosa, il messaggio distorto o male interpretato: è proprio in questo spazio, in questa zona opaca dell’atto comunicativo che lo scambio tra i componenti della troupe si fa più prolifico. Questa, oggi, è la mia metodologia di lavoro. Non vi è alcuno schema fisso o rigida procedura; al contrario vi è un’infinita gamma di possibilità. Mi interessa il fatto che non esista modo di esprimere un messaggio in maniera trasparente: c’è sempre qualcosa che ostacola la comunicazione. Mi piace lavorare con questo «rumore» che interferisce con la comunicazione. In un certo senso è una pratica che rispecchia quella che Socrate definiva «catarsi»: un pensiero che evolve e avanza in modo dialettico attraverso il dialogo e la comunicazione, fino a quando il soggetto, dopo l’ammissione del proprio errore, accede alla «verità». Nella mia metodologia di lavoro, ovviamente, non vi è alcuna verità definitiva: si tratta piuttosto di una strategia dialogica che consente agli attori di estrarre un pensiero originale dalle proprie risorse creative. La relazione che intrattengo con i miei collaboratori non è mai neutrale o «diplomatica»: è una relazione di conflitto. Quello che cerco di fare è elaborare questo conflitto, come fosse un «trasferimento negativo», per usare un concetto psicoanalitico di Melanie Klein.
Le sue sculture sembrano rappresentare un mondo post-apocalittico abitato da creature ibride, metà animali e metà umane...
Credo che siamo tutti figli di un’epoca molto sensibile alle catastrofi; siamo persino in grado di predirle, e questo non è mai accaduto prima nella storia dell’uomo. Conseguenza piuttosto ovvia è il fatto che ciò ha portato un certo pessimismo nell’immaginario presente.
Realizza soprattutto sculture, perlopiù in argilla. Per quale ragione utilizza questa tecnica? I suoi lavori, inoltre, sono generalmente imponenti e sovradimensionati: quale ruolo attribuisce alla monumentalità?
L’arte contemporanea, a mio avviso, non può più essere valutata secondo queste categorie: medium, monumentalità, installazione ecc. Nell’arte di oggi ogni classificazione tassonomica è morta. Una dimensione chiave della mia pratica è quella dell’agire come un ospite, una sorta di parassita, ruolo che copro con le istituzioni che supportano i miei progetti, così come con lo spazio fisico, sia esso l’architettura dell’edificio, la città o il territorio. Si tratta di residenze prolungate, durante le quali gradualmente mi prefiggo di superare alcuni divieti da parte dell’istituzione ospitante. È il contesto sociale, geografico, culturale e istituzionale ad alimentare ciascuno dei miei progetti. Per rispondere alla sua domanda, faccio sculture perché sono una creatura tridimensionale che si muove in un ambiente di quattro dimensioni (inclusa quella del tempo). La mia relazione con il mondo materiale mi rende uno scultore, proprio come ogni essere umano che abita su questo pianeta. Noi tutti siamo scultori. Noi tutti siamo sculture.
Altri articoli dell'autore
In occasione del centenario della nascita del maestro cinetico più celebre al mondo, anche un convegno internazionale, oltre a mostre in tutta Europa
La prima edizione della Triennale di arte contemporanea della città francese è un prototipo per una rassegna alternativa: attenta a una dimensione locale più che globale, nasce dal desiderio di relazionarsi attivamente e genuinamente con il tessuto urbano e la comunità dei cittadini
All’Eye Museum di Amsterdam la personale della raffinata artista e filmmaker greca
La sua prima retrospettiva istituzionale negli Stati Uniti, al MoCA di Los Angeles, è una profonda riflessione del rapporto tra verità, spettacolo e rappresentazione