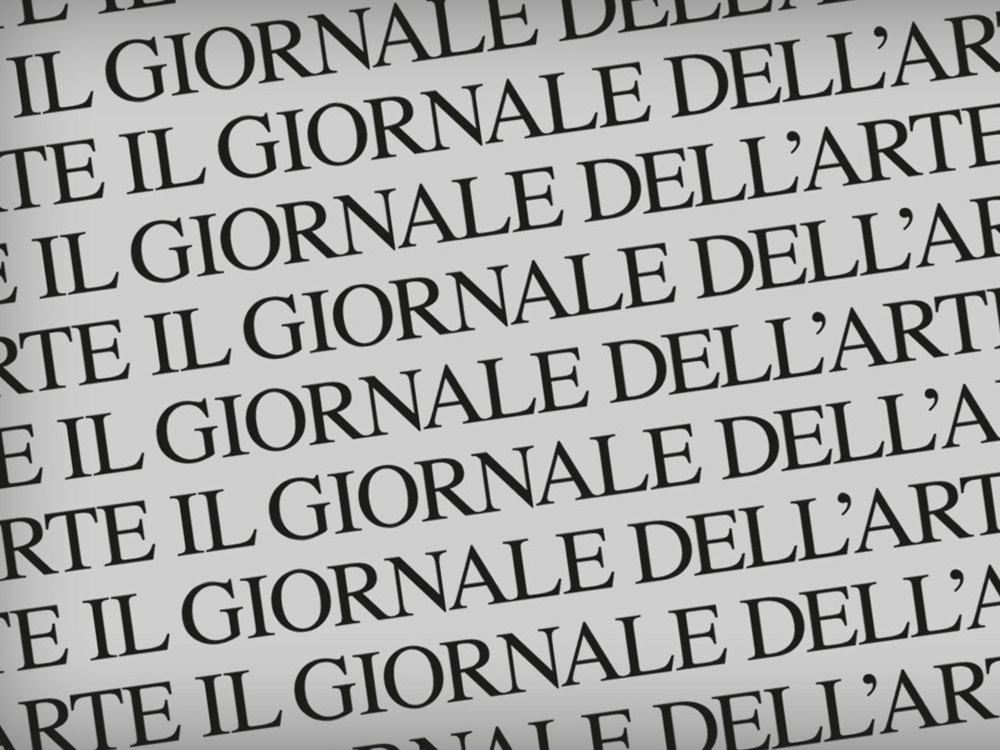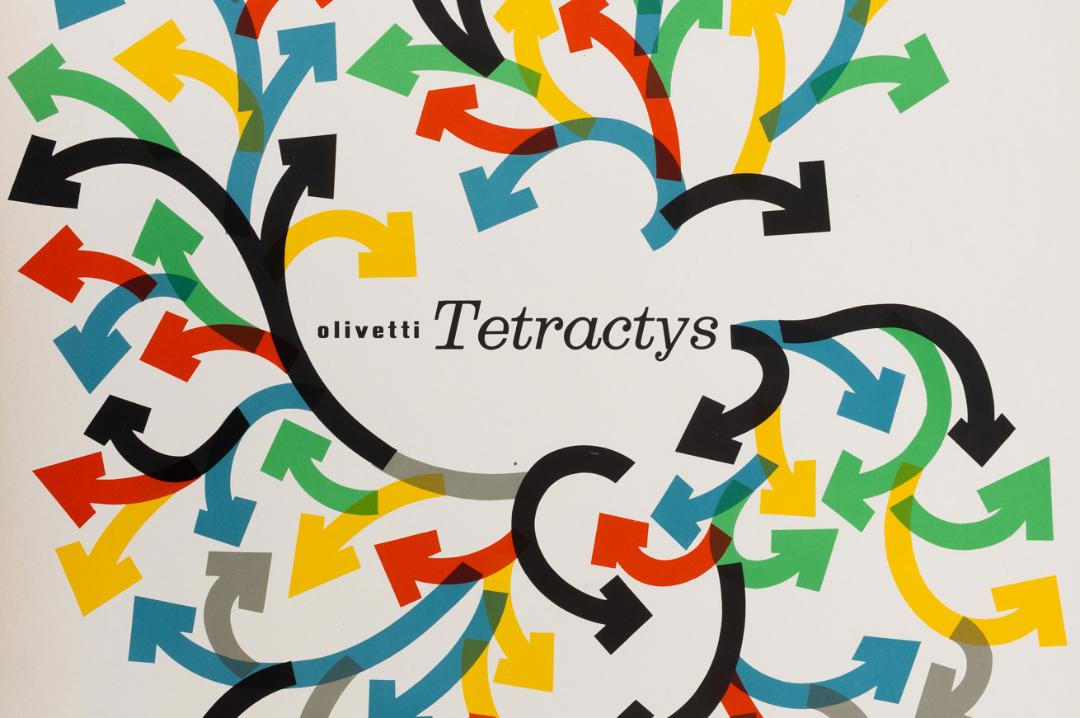Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Mariella Rossi
Leggi i suoi articoliCarole Haensler Huguet, curatrice del Museo Villa dei Cedri di Bellinzona, racconta ai lettori di «Vedere in Canton Ticino» i retroscena della mostra intitolata «L’anima del segno. Hartung-Cavalli-Strazza»
Allestita dall’8 ottobre al 29 gennaio, la mostra è un’inedita esplorazione a tre voci sull’uso del segno nell’incisione e nella pittura nel dopoguerra.
Come e quando nasce l’idea della mostra?
È il primo progetto che ho cercato di mettere in moto quando tre anni fa sono stata nominata curatrice di Villa dei Cedri. Nel frattempo abbiamo deciso di rinnovare il museo. È la mostra più ambiziosa realizzata fino ad ora. È rappresentativa di una riflessione analitica sul patrimonio del museo, un approccio alla pratica espositiva che si ritrova adesso in molti musei svizzeri, ma credo anche nel resto d’Europa. Dopo la rincorsa della novità a tutti i costi, col rischio di sganciarsi dalla funzione educativa del museo, ora si guarda maggiormente al patrimonio e alla sua valorizzazione. La funzione primaria del museo è di conservare e fare ricerca continuativa sulle proprie collezioni (non solo sui nuovi fondi) e condividerne i risultati.
Il percorso parte dunque dalla collezione?
Una caratteristica del patrimonio del Museo Villa dei Cedri sono i fondi monografici. Il primo fu proprio quello di Massimo Cavalli, poi quelli di Giulia Napoleone, Enrico della Torre, Renzo Ferrari, Paolo Mazzuchelli, solo per citarne alcuni. Non basta presentare questi fondi singolarmente.
Che tipo di confronto è stato messo in atto?
Sulla collocazione degli autori e delle loro opere nella storia dell’arte e nella storia della mentalità: mi sono chiesta perché questi artisti sono arrivati a una data soluzione insieme, pur essendo stati distanti. Massimo Cavalli e Guido Strazza conoscevano tutti e due il lavoro di Hartung tramite pubblicazioni e mostre; mentre Hartung non li conosceva, e Strazza e Cavalli non si sono mai conosciuti.
E come ci sono arrivati?
Il Ticino è un luogo di incontro tra Nord e Sud. La compenetrazione della cultura francese, tedesca, lombarda, piemontese e di altre regioni è riconoscibile nelle collezioni dei musei e nelle ricerche dei singoli artisti. Per primo ho conosciuto il lavoro di Massimo Cavalli (Locarno, 1930) e l’ho compreso molto bene riconoscendovi tratti della cultura francese nonostante lui non abbia mai operato in area francofona, per tanti anni ha avuto lo studio a Milano. Nella sua opera ho ritrovato la cultura italiana e francese. Nello stesso periodo Guido Strazza ha fatto tutt’altri percorsi, ha avuto altri riferimenti eppure è giunto a soluzioni vicine a quelle di Cavalli che non ha mai conosciuto. Questa è la storia della mentalità: in un dato periodo in vari luoghi ci sono soluzioni simili che parlano anche delle particolarità culturali. È questo l’incontro che volevo mettere in evidenza tra Cavalli, Hartung e Strazza. Hartung rappresenta quello che è successo a Parigi anche prima dell’Informale. Tutti e tre sono stati associati all’Informale dalle gallerie e nelle mostre in cui erano coinvolti perché era la tendenza del periodo, ma rispetto ad altri artisti l’Informale rappresentava per loro solo una sperimentazione durante la ricerca di un proprio linguaggio. La loro è piuttosto una «secessione dall’informale».
Sono diversi i processi creativi di questi tre artisti?
Per Hartung, la linea è il mezzo espressivo essenziale, il suo segno. Gli esperimenti tra incisione e litografia gli hanno dato maggior libertà nel gesto che la traccia, oltre ad offrirgli nuove soluzioni plastiche per il lavoro sulla tela. Per Strazza e Cavalli, che lavorano molto con il bulino, è invece essenziale il rapporto di forza, di tensione con la lastra.
Com’è articolato il percorso espositivo?
Vogliamo documentare lo sviluppo cronologico della ricerca di ogni artista e mettere in evidenza i punti di contatto in sale ove sono esposte insieme le opere di tutti e tre. Un ulteriore livello di lettura è il rapporto tra incisione e pittura: di ogni artista abbiamo selezionato una serie di opere su carta, soprattutto incisioni ma anche una decina di disegni e acquarelli, più un massimo di cinque tele per un totale di una trentina di opere di Hartung, altrettante di Strazza e alcune in più di Massimo Cavalli.
Da dove provengono le opere?
Siamo partiti da opere del museo per tutti e tre. Altri lavori di Hartung provengono da collezioni pubbliche e private come il Musée d’Art et d’Histoire di Ginevra e una serie di sei inchiostri è del Musée Picasso di Antibes. Di Cavalli molte opere sono del museo e per quanto riguarda i disegni e le tele mi sono rivolta a collezionisti privati. Di Strazza a breve uscirà un catalogo ragionato della Calcografia Nazionale di Roma, ho trovato ordine nel suo archivio quando sono andata a trovarlo a Roma. Tutti e tre gli autori sono stati recentemente oggetto di studi ragionati.
Altri articoli dell'autore
I monumenti di eroi italiani ed europei dell’artista ottocentesco, esposti nel museo di Mendrisio, accolgono un’inedita e colorata installazione della giovane indiana
Con l’impegno della direttrice Stella Falzone, il MArTA aiuterà la città pugliese a cambiare pelle e a riprendere il suo ruolo dominante nel panorama archeologico nazionale e internazionale
Al m.a.x. museo e allo Spazio Officina una panoramica di designer, pittori e creativi
Dopo Ruth e Giancarlo Moro, nella città ticinese una serie di appuntamenti all’insegna dell’arte contemporanea