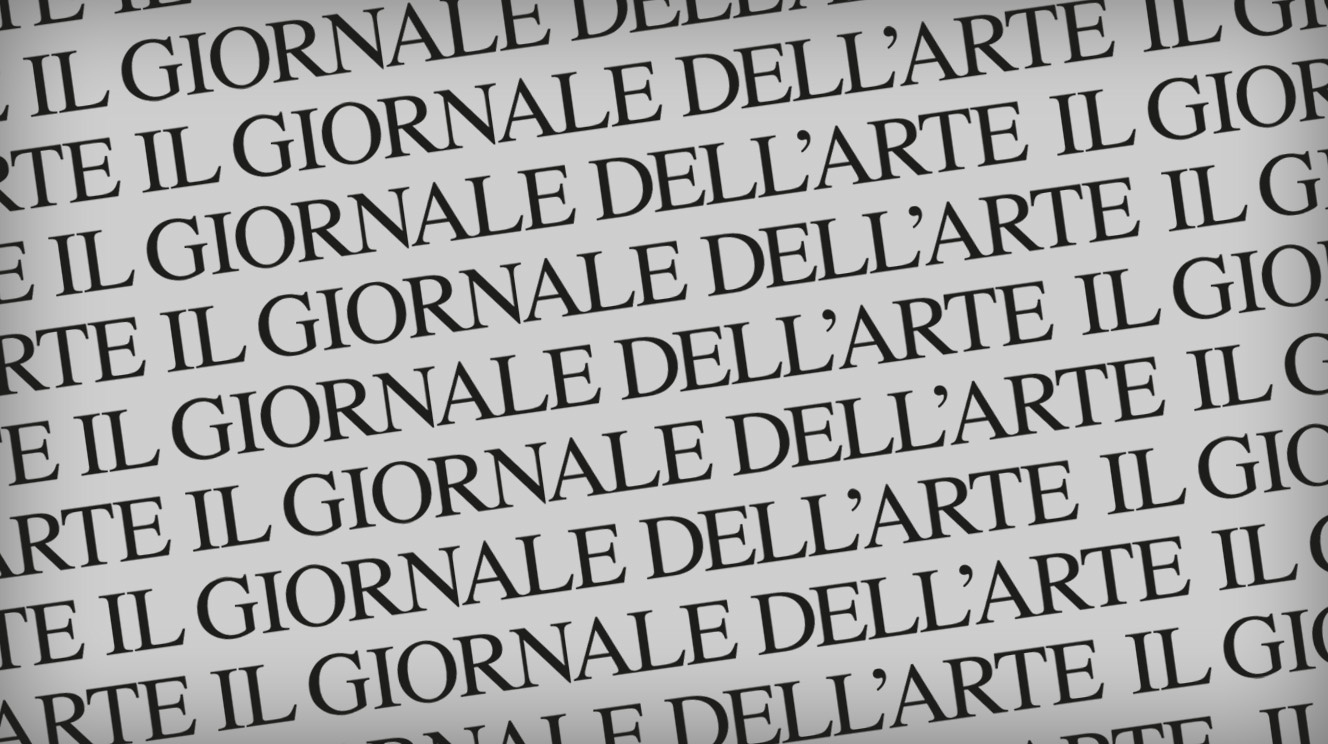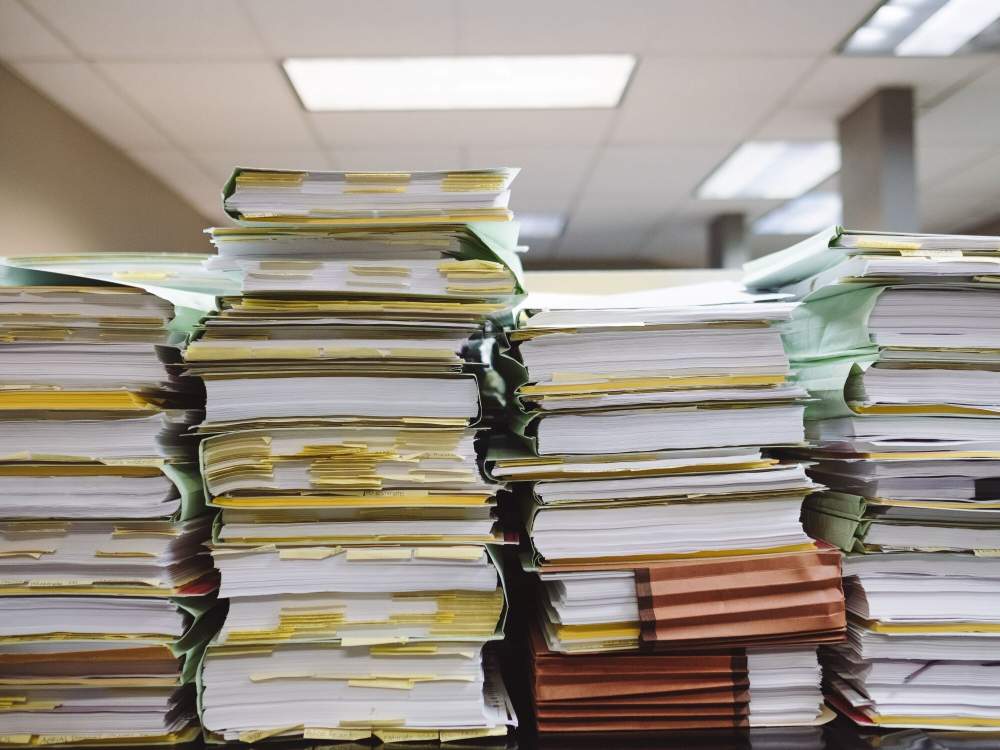Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Redazione GDA
Leggi i suoi articoliNon ha mancato di far rumore l’asserito riconoscimento da parte del naturalista Mark Griffiths in un trattato di botanica stampato nel 1598, del vero ritratto di William Shakespeare, e tale e tanto da strappare a Mark Hedges, direttore di «Country Life» che del ritrovamento dava notizia, l’imprudente affermazione, ripresa anche dalla più autorevole stampa quotidiana nostrana, onde «la scoperta letteraria del secolo» era avvenuta.
In realtà, se gli argomenti su cui poggia l’identificazione (la presenza della fritillaria e della spiga di mais che rimanderebbero a Venus and Adonis e a Titus Andronicus) sembrano abbastanza fragili e lasciano perplessi, lo scalpore s’avverte giustificato in quanto suscitato dalla constatazione di un punto d’incontro ad altissimi livelli e, per i contenuti in gioco, privilegiato, «tra due discipline che, sulla base dell’inevitabile interazione tra parole e immagini, spesso dialogano», la storia della letteratura e la storia dell’arte; e si tratta dello «studio dei ritratti figurativi dei letterati» che, calandoci in ambito italiano, un Lomazzo equiparava per eccellenza e dignità, a quelli di imperatori, papi, re, principi, cardinali.
Così come constatava il compianto Enrico Castelnuovo in un saggio memorabile (1973), or ora opportunamente riproposto col titolo Ritratto e società in Italia nella «Piccola Biblioteca Einaudi», «come fece Giotto il quale espresse in Dante la profondità, Simon Senese nel Petrarca la facilità, Frate Angelico la prudenza del Sannazzaro, e Titiano nell’Ariosto la facundia e ornamento».
Ma a quale, o a quali, fra i ritratti di Ludovico che la tradizione ci ha consegnato con la paternità del Cadorino, si riferiva veramente Giovanni Paolo Lomazzo? Egli, in effetti, accoglieva un topos, l’accoppiata Ariosto-Tiziano, fissato da Lodovico Dolce nel Dialogo della pittura (1557) e destinato all’ulteriore fortuna consolidata da Carlo Ridolfi nelle Maraviglie dell’Arte (1648), sul fondamento della constatazione che, «havendo elleno un medesimo fine di rappresentare le humane attioni e gli effetti dell’animo, sì che potevasi ben dire, che fossero accoppiati insieme l’Homero, e l’Apelle della moderna età», ma al punto da costituire un raggruppamento in realtà eterogeneo quanto ad attendibilità dell’esecutore dell’immagine e dell’identità del soggetto rappresentato. Dunque, insoddisfacente, incerto e sostenuto spesso da esiti scontati per pigrizia di indagini, piuttosto che provati dall’autorità di riscontri solidi.
Ad affrontare la questione, nella sua complessità, esce ora, e merita una segnalazione che solo ragioni di disponibilità di spazio renderanno laconica, un lodevole saggio di Marco Paoli, Lo specchio del Rinascimento / The Mirror of the Renaissance / Novità su Tiziano e Dosso che ritraggono Ariosto /New findings on Titian and Dosso portraying Ariosto.
L’autore, che si preoccupa di dichiararlo preventivamente, non è «un italianista, né uno storico dell’arte» ma, direttore della Biblioteca Statale di Lucca e ben noto studioso di codicologia e di storia della miniatura e dell’editoria, proprio da codesta sua esperienza pluridisciplinare trae gli strumenti di metodo che gli consentono di misurarsi con una problematica intrigante e insidiosa, sforzandosi di «tracciare un confine al di là del quale sono i ritratti alieni e fuorvianti, veri e propri fantasmi ariosteschi» (pp. 43-66).
Tra questi una terna spettante comunque al pennello di Tiziano (e sono i dipinti di un patrizio Barbarigo della National Gallery di Londra, e di gentiluomini del Museo Fesch di Ajaccio e del John Herron Art Museum di Indianapolis) col quarto numero oggi nella National Gallery di Londra e unanimemente attribuito a Palma il Vecchio ma con la riduzione a sia pur nobile anonimato del soggetto raffigurato, sino alla sanzione («ritratto di poeta, cosiddetto Ariosto») nella recentissima, bella mostra dedicata al Maestro bergamasco.
Che Paoli rimette in discussione, non solo riconoscendo le fattezze di quel Niccolò Dolfin, che fu tra gli esponenti del petrarchismo e sappiam aver dialogato con Bembo e Triffon Gabriele, ma rintracciando, nella comparazione con quella fisionomia, convincentemente, un paio di altre immagini del patrizio-letterato nei ritratti sinora ritenuti di personaggi innominati, ora nella Johnson G. Johnson di Filadelfia (inv. 188) e già nella Collezione del Maresciallo Tito a Belgrado.
Quanto al nodo Tiziano-Ariosto, dissolti «i fantasmi», il perseguimento dell’«icona vera» è da Paoli effettuato nel riferimento imprescindibile alla silografia impressa da Nicolò d’Aristotele detto Zoppino sul frontespizio della sua edizione, nel 1530, del Furioso, non già traendo dal vivo e d’accordo con il Poeta (com’è noto siamo al cospetto di un’edizione pirata), ma, molto probabilmente (e conveniamo con l’ipotesi), dalla galleria dei ritratti «tolti dal vivo, sì che parevano spiranti», giusta Ridolfi, dal Cadorino inserita nel telero dell’«Umiliazione del Barbarossa» (del 1522 e, quindi, successiva all’incontro tra il pittore e il Poeta, ma purtroppo, perduta nell’incendio del 1577 di Palazzo ducale).
Se, in effetti, siffatta immagine non è contraddetta da quella stampata per cura dello stesso Ludovico sul recto dell’ultima pagina della princeps del Furioso affidata ai torchi di Francesco Rosso da Valenza l’1 ottobre 1532, essa s’accorda puranche con il ritrattino miniato sul frontespizio dell’esemplare di quest’ultima impressione che appartenne al cardinale Ippolito II d’Este e sta ora nella Biblioteca Apostolica Vaticana (cod. Barb. Lat. 3942), e con il dipinto che, rinvenuto nella Casa di Ugo Oriani nel Ravennate e certificato da Gronau (1933) e da Tietze (1936) è purtroppo oggi irreperibile.
Non solo, ma siamo già fuori dal novero dei fantasmi a suo luogo contestati, giacché Paoli non manca di regalarci proposte inedite che coinvolgono Dosso, alla sua volta «familiare», con Tiziano, di Ariosto («amico et dimestico suo», lo testimonia Vasari) e nella condizione di inserirsi in un contesto di complicità e solidarietà. Proposte che, mentre chi qui scrive trova ben illustrate e persuasive, potranno suscitare un fecondo dibattito tra gli studiosi, e si tratta del profilo d’uomo barbuto del Kunsthistorisches Museum di Vienna (inv. GG 106) che Paoli ritiene copia già nelle collezioni di Francesco I d’Este, e, per Dosso, degli splendidi ritratti conservativi dagli Uffizi (inv. 889) e dal Wichita Center of Arts (Coll. S. Kress, inv. K 1070).
Lo specchio del Rinascimento. Novità su Tiziano e Dosso che ritraggono Ariosto / The Mirror of Renaissance. New findings on Titian and Dosso portraying Ariosto, di Marco Paoli, edizione italiano e inglese, 128 pp., ill., Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca 2015, € 30,00
Altri articoli dell'autore
L’Associazione archeologi del Pubblico Impiego (Api-MiBact) ha inviato una nota al Ministero della Cultura e a quello della Funzione Pubblica, nonché ai membri delle Commissioni cultura di Camera e Senato, per esprimere il proprio dissenso per il bando per 75 posti nell’area dell’elevate professionalità (Ep), le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 26 giugno
Il premio Nobel e il direttore del Museo Egizio si sono incontrati per parlare di musei e romanzi: «Sono simili: sono i “luoghi” in cui avviene l’interpretazione del significato della nostra vita, nei quali riflettere su sé stessi»
Anche quest’anno Tag Art Night, la Notte delle Arti Contemporanee, propone un palinsesto di mostre diffuse sul territorio cittadino
Rimodulate le competenze e modificato la struttura organizzativa: dal Segretariato generale al modello dipartimentale